Itàlia (arte e cultura)
IndiceFilosofia: dall'Umanesimo a Vico
Sulle origini del pensiero filosofico italiano sono ormai superate quelle tradizioni storiografiche che cercavano la sua affermazione prima nella “sapienza magnogreca”, in Pitagora e negli eleati (come sostenuto da certa storiografia illuministica o cattolica “liberale” ottocentesca), o quelle che ancora cercavano di stabilire una continuità fra questi primordi del pensiero italico, quello medievale (Boezio, Sant'Anselmo, San Bonaventura, San Tommaso, considerati come espressioni del genio italiano) e quello moderno (idea che si ritrova per esempio in Gioberti). Si può infatti parlare di pensiero filosofico italiano solamente con il manifestarsi del senso dell'autonomia culturale della nazione o del popolo italiano. Sulla base di questo canone si può far cominciare la filosofia italiana nel periodo umanistico-rinascimentale. Parimenti unilaterali appaiono però quelle concezioni storiografiche che vorrebbero ravvisarne le origini nello spirito del Rinascimento inteso come affermazione della libertà di pensiero contro le istituzioni ecclesiastiche e nella funzione della nuova scienza (come accade in certa storiografia di marca illuministica o positivistica), o quelle che considerano costante del pensiero italiano l'ontologismo e l'ispirazione metafisico-religiosa (V. Gioberti). Né molto aiuto si può trarre dalla storiografia idealistica, volta a vedere nella filosofia italiana precorrimenti di quella europea moderna (B. Spaventa) o a cercare nei filosofi del passato anticipazioni dell'idealismo (G. Gentile). Abbandonate dunque suggestioni culturali indifendibili, è giusto invece ripercorrere il pensiero filosofico italiano, cercando di dare il senso della sua complessità senza costringerlo in un'unità artificiosa, sottolineando i contributi da esso dati allo spirito europeo e il modo particolare in cui, nel suo ambito, furono vissute correnti di pensiero formatesi oltralpe. Premesso che l'affermata unità umanesimo e Rinascimento è molto discutibile, nel periodo dell'umanesimo sono ben individuabili almeno due filoni di pensiero. Il primo è più immediatamente legato alle riflessioni sull'etica e sulla vita civile e annovera fra i suoi rappresentanti F. Petrarca (1304-1374), C. Salutati (1331-1406), L. Bruni (1370-1444), L. Valla (ca. 1407-1457); il secondo è d'ispirazione platonica e ha il suo rappresentante massimo in M. Ficino (1433-1499), il cui nome è legato all'Accademia Platonica fondata a Firenze da Cosimo de' Medici: Ficino è iniziatore di una filosofia che innesta in una prospettiva profondamente religiosa (il platonismo stesso è concepito come propedeutico al cristianesimo) il tema della centralità dell'uomo nell'universo e della sua dignità. Il tema della dignità dell'uomo si ritrova come fondamentale anche nell'altro grande umanista italiano, G. Pico della Mirandola (1463-1494), che non solo si sforzò di conciliare cristianesimo e filosofia greca, aristotelismo e platonismo, ma anche assunse nel suo filosofare motivi cabalistici e magici, che grande diffusione ebbero poi nel Rinascimento. Elemento caratterizzante l'umanesimo è comunque l'esigenza di un'armonia che si fa programma culturale esplicito, armonia fra uomo e universo, mondo naturale e sovrannaturale, cultura greca e cristianesimo, azione e contemplazione. Questa armonia che le più alte personalità dell'umanesimo seppero realizzare nella loro opera e persona andò invece declinando nel Rinascimento e la sua perdita si accentuò con il conflitto religioso scatenato, in Europa, dalla Riforma. Indubbiamente nel periodo rinascimentale si ha l'affermazione di un naturalismo schietto che, se non rifugge dalla religiosità, si fa fautore (ed è questo il suo motivo più originale) di una religiosità immanente che sfocia nell'esaltazione dei valori mondani. Primo momento del naturalismo rinascimentale può essere considerato l'aristotelismo di P. Pomponazzi (1462-1525): l'Aristotele che Pomponazzi cercava di far rivivere era quello della ricerca naturalistica e non più quello conciliabile con il platonismo di M. Ficino e di Pico. Ma le espressioni più ricche e interessanti del naturalismo rinascimentale sono da ravvisarsi nella filosofia naturale di B. Telesio (1509-1588), volta a studiare la natura iuxta propria principia (in base cioè ai principi che le sono immanenti) e il panteismo dinamico di G. Bruno (1548-1600), figura tante volte assunta come simbolo della libera speculazione, che non riconosce altra norma al di fuori di quella che la verità immanente all'uomo ispira, e dello spirito “faustiano” moderno per la sua celebrazione dell'attività umana come prolungamento in nuove forme senza mai posa dell'attività infinita della natura. Più complesso è il pensiero di T. Campanella (1568-1639) che, pur sostenendo una filosofia della natura vivente, costantemente perseguì il progetto di una riforma politico-religiosa che lo portò a riproporre una filosofia cristiana nel quadro dell'attività controriformistica. Espressione ancora del naturalismo rinascimentale può essere considerata infine la nuova scienza della natura, che ha in Leonardo da Vinci (1452-1519) il suo precursore e in G. Galilei (1564-1642) il suo fondatore: la natura è in questo quadro ridotta a pura oggettività misurabile e la ricerca intorno a essa si spoglia di ogni presupposto teologico o metafisico riconoscendosi nell'autonomia dei suoi metodi. E ancora all'idea di una “realtà effettuale” da indagare alla luce dei principi che le sono immanenti è da riportarsi la riflessione politica che ha in N. Machiavelli (1469-1527) e F. Guicciardini (1483-1540) i suoi massimi rappresentanti. Le scienze mondane (non solo la fisica, ma la politica e la giuridica) traversarono l'età barocca, favorite dalle tendenze controriformistiche interessate a mettere al servizio della fede una prudente regolamentazione dell'operare mondano. Robuste personalità speculative mancarono in Italia in questo e nel secolo successivo se si fa eccezione per G. B. Vico (1668-1744) la cui figura grandeggia solitaria: la sua originalità aprì la filosofia alla considerazione della storia impostando acutamente la problematica che questa apertura importava; la complessità del suo pensiero, in cui elementi di filosofia politica si uniscono a una profonda ispirazione religiosa, ne fanno forse il maggior filosofo italiano: egli raccolse il meglio della speculazione umanistica anticipando temi che il romanticismo riscoprirà e la sua filosofia, che sempre rivive in nuove interpretazioni, ha un'attualità non ancora esaurita.

Italia . Dante e Virgilio incontrano Ulisse in una miniatura veneta che illustra un'edizione trecentesca della Divina Commedia (Venezia, Biblioteca Marciana).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Ritratto di F. Petrarca sul frontespizio di un manoscritto quattrocentesco delle Rime (Montpellier, Musée Atger).
De Agostini Picture Library/M. Seemuller

Italia . Gabriele D'Annunzio.
De Agostini Picture Library

Italia . Alberto Moravia in un dipinto di Carlo Levi (1932; Roma, Fondazione Levi).
De Agostini Picture Library/U. Marzani

Italia . Cesare Pavese.
Archivio Einaudi Editore

Italia . Statua femminile proveniente da Lavinio (sec. V a. C.; Pratica di Mare, Museo).
De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Il Colosseo e l'Arco di Costantino in un dipinto di Gian Paolo Panini (Collezione Privata).
Collezione Privata

Italia . Raffigurazione di un duello in un affresco proveniente dalla necropoli di Andriuolo (Paestum, Museo).
De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . Veduta degli scavi di Ercolano.
De Agostini Picture Library/G. Dagli Orti

Italia . Veduta del chiostro di impronta araba della basilica di Monreale.
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La facciata romanica del duomo di Cremona.
De Agostini Picture Library

Italia . L'interno della chiesa di S. Maria Novella a Firenze.
De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Il palazzo dei Consoli a Gubbio.
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La facciata gotica del duomo di Siena.
De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . L'interno della Cappella degli Scrovegni a Padova.
De Agostini Picture Library

Italia . Veduta delle Logge vaticane affrescate da Raffaello Sanzio e allievi.
De Agostini Picture Library/G. Cigolini

Italia . Deposizione del Beato Angelico, particolare della pala di S. Trinita (Firenze, Museo di San Marco).
De Agostini Picture Library/G. Nimatallah

Italia . Particolare de Il ritorno del Bucintoro di F. Guardi (Copenaghen, Statens Museum).
Copenaghen Statens Museum

Italia . Maternità di A. Martini (1929-30).
De Agostini Picture Library/A. De Gregorio

Italia . A. Scarlatti in un ritratto dell'epoca (Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . C. Monteverdi in un'illustrazione de Gli abiti de' veneziani di Giovanni Grewembroch (Venezia, Museo Correr).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Una pagina della partitura autografa della Messa a tre voci di T. Albinoni (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Scenografia per una rappresentazione del Barbiere di Siviglia di G. Rossini (Vienna, Museen der Stadt).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Scenografia di P. Ricci per una rappresentazione dei Pagliacci di R. Leoncavallo (Napoli, Teatro S. Carlo).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti
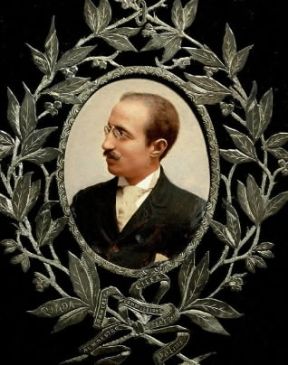
Italia . F. Cilea in una miniatura del 1892 (Palmi, Museo Cilea).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . La Bohème di G. Puccini in un allestimento moderno.
De Agostini Picture Library

Italia . Cartolina di L. Metlicovitz per la prima rappresentazione della Madama Butterfly di G. Puccini a Brescia nel 1904 (Lucca, Fondazione Puccini).
De Agostini Picture Library/A. Dagli Orti

Italia . Ma l'amor mio non muore (1913) di M. Caserini.
De Agostini Picture Library

Italia . Assunta Spina (1915) di G. Serena con F. Bertini.
De Agostini Picture Library

Italia . I topi grigi (1917) di E. Ghione.
De Agostini Picture Library

Italia . Gli uomini, che mascalzoni! (1932) di M. Camerini.
De Agostini Picture Library

Italia . Quattro passi fra le nuvole (1942) di A. Blasetti.
De Agostini Picture Library

Italia . Ossessione (1942-43) di L. Visconti.
De Agostini Picture Library

Italia . Umberto D. (1952) di De Sica-Zavattini.
De Agostini Picture Library

Italia . Senso (1954) di L. Visconti.
De Agostini Picture Library

Italia . Ludwig (1973) di L. Visconti.
De Agostini Picture Library

Italia . Un momento del Carnevale di Ivrea in Piemonte.
De Agostini Picture Library/M. Leigheb

Italia . Un momento dell'Infiorata di Genzano (Roma).
De Agostini Picture Library/C. Pozzoni

Italia . La ""partita a scacchi"" di Marostica.
De Agostini Picture Library/A. Vergani

Italia . Il ""palio della balestra"" a Gubbio.
De Agostini Picture Library

Italia . La ""regata storica"" sul Canal Grande a Venezia.
De Agostini Picture Library/A. Vergani

Italia . Fuochi d'artificio per la festa di Piedigrotta a Napoli.
De Agostini Picture Library/A. Vergani
Filosofia: dall'illuminismo al trionfo dell'idealismo
Un tono minore nei confronti di quello europeo ha certamente l'illuminismo italiano, che ha i suoi centri a Napoli, con A. Genovesi (1713-1769), F. Galiani (1728-1787), G. Filangieri (1752-1788) e a Milano con P. Verri (1728-1797), A. Verri (1741-1816) e C. Beccaria (1738-1794): in Italia gli illuministi s'interessarono soprattutto di questioni giuridiche, economiche e politiche. La filosofia italiana riacquistò maggior slancio speculativo con il Risorgimento: P. Galluppi (1770-1846), autore di un'originale “filosofia dell'esperienza”, ebbe il merito di vivificare il pensiero italiano a contatto con i grandi sistemi filosofici europei. E se alcuni pensatori come G. D. Romagnosi (1761-1835) e C. Cattaneo (1801-1869) ripresero la tradizione illuministica, temperandola di spirito vichiano, nell'esigenza di fondare una “civile filosofia”, G. Mazzini (1805-1872) dava al problema politico un'impostazione etico-religiosa (la religione del progresso e del popolo) e si faceva interprete del Risorgimento come educazione nazionale. A. Rosmini (1797-1855) e V. Gioberti (1801-1852) cercarono infine di difendere e riaffermare la tradizione cristiano-cattolica alla luce della quale impostavano lo stesso problema del Risorgimento nazionale nei confronti della nuova filosofia europea (illuministica e romantica), giungendo a sintesi filosofiche originali intese a far emergere da questa tradizione virtualità nuove e insospettate. In questo clima si ebbe la diffusione dell'hegelismo, che segnò l'anello di congiunzione fra l'Italia dell'Ottocento e quella del Novecento: centro di questa diffusione fu Napoli con F. De Sanctis (1817-1883), A. Vera (1813-1885) e B. Spaventa (1817-1883). I temi dell'hegelismo napoletano ottocentesco furono infatti ripresi, nell'ambito di un allargamento delle problematiche e con nuova sensibilità speculativa, da B. Croce (1866-1952) e G. Gentile (1875-1944): il pensiero di Croce e di Gentile dominò quasi incontrastato fra le due guerre mondiali, rinnovando potentemente la cultura nazionale, prima in gran parte dominata dal positivismo (di cui si può vedere il rappresentante più originale in R. Ardigò, 1828-1920). Croce definì il suo sistema “filosofia dello spirito”: esso consisteva in una specie di idealismo storicistico ed ebbe grande diffusione soprattutto nel campo dell'estetica per le profonde e geniali intuizioni che portarono a un rinnovamento della critica d'arte. Gentile elaborò, invece, una “filosofia dell'atto puro” intesa alla riaffermazione del “divino immanente” e dominata dall'esigenza di una profonda riforma etico-religiosa della coscienza nazionale (egli è spesso considerato l'ideologo del fascismo, anche se certamente il rapporto tra il filosofo e la dittatura è più complesso). Contrario a ogni immanentismo, il pensiero di P. Martinetti (1872-1943) s'indirizzò con rigore morale a riappropriarsi di una trascendenza, dove “la volontà, liberata dal dominio delle cose mutevoli, s'arresta sul sentimento profondo della sua unità con la volontà che è immutabile”.
Filosofia: dal tramonto dell'idealismo alla filosofia contemporanea
Alla fine della seconda guerra mondiale, dalla crisi dell'idealismo come filosofia incapace di rispondere ai problemi che travagliavano la coscienza europea presero le mosse, accanto a una ripresa del marxismo (che Croce e Gentile avevano cercato di criticare o superare) e a una rivendicazione dell'attualità del pensiero di A. Gramsci (1891-1937), il problematicismo di U. Spirito (1896-1979), la filosofia del dialogo di G. Calogero (1904-1986), entrambi allievi di Gentile, e, soprattutto, lo sforzo del pensiero italiano di assimilare le correnti filosofiche formatesi in Europa e in America, quali il neoempirismo, l'esistenzialismo, la fenomenologia. Il neoempirismo, in particolare, ha dato un importante impulso allo sviluppo della filosofia della scienza, della cui diffusione in Italia è stato artefice L. Geymonat (1908-1991) che, in un'ottica marxista, ha posto l'accento sul ruolo sociale della scienza. Alla sua scuola si è formato G. Giorello (n. 1945), che ha dato un efficace contributo alla divulgazione di questa disciplina. Su un altro versante si colloca la riflessione di E. Severino (n. 1929), che ha individuato nella speculazione greca la radice ontologica dell'odierno strapotere tecnico-scientifico. L'esistenzialismo ha trovato in Italia due originali interpreti in N. Abbagnano (1901-1990), che su questa base teoretica ha innestato la sua attenzione verso il pragmatismo di matrice americana, e in L. Pareyson (1918-1991), la cui indagine si è orientata piuttosto verso una visione ontologica della libertà, affrontando nel contempo tematiche attinenti all'estetica e all'ermeneutica. Queste due discipline – così come quella del linguaggio – sono oggetto di interesse anche da parte di G. Vattimo (n. 1936), già allievo dello stesso Pareyson, il quale, a tal riguardo, si richiama alle tesi di Heidegger e poi di Gadamer; egli, anche attraverso una rilettura delle teorie di Nietzsche, è giunto a formulare un'idea della filosofia come "pensiero debole", chiamato a confrontarsi con il venir meno delle certezze assolute. La filosofia di Nietzsche e di Heidegger ha influenzato anche la riflessione di M. Cacciari (n. 1944), volta alla ricerca – estesa al terreno storico-religioso – delle radici del “pensiero negativo”. Critico sia verso il “pensiero debole” di Vattimo sia verso il “pensiero negativo” indagato da Cacciari, R. Bodei (n. 1938) parte dalla crisi dei sistemi e degli “ismi” per giungere a proporre la centralità dell'amore e del desiderio di felicità. La fenomenologia ha avuto come autorevoli esponenti A. Banfi (1886-1957), uno dei primi a farla conoscere in Italia, e soprattutto il suo allievo E. Paci (1911-1976) che, in quest'ottica, ha riflettuto sulla relazione tra la filosofia e le scienze, aprendosi al confronto col marxismo. E proprio il marxismo ha occupato un ruolo centrale nel dibattito filosofico italiano almeno fino agli anni Ottanta (prima che il crollo dei regimi comunisti ne sancisse la crisi). Al suo interno si sono differenziate le posizioni degli storicisti, come E. Garin (1909-2004), da quelle dei critici dello storicismo, come C. Luporini (1909-1993), nonché degli assertori di un'interpretazione del marxismo in chiave antihegeliana e scientifica (G. Della Volpe, 1895-1968). Fiero oppositore della cultura laica e della filosofia del “pensiero debole”, A. Del Noce (1910-1989) analizza nella sua opera le cause e le manifestazioni del processo di secolarizzazione nel mondo contemporaneo. Nel campo della filosofia del diritto e della politica, infine, è da ricordare N. Bobbio (1909-2004) che, muovendo da un'ispirazione fondamentalmente neoilluminista, ha fornito un significativo apporto teorico a entrambi i settori, distinguendosi inoltre per la sua costante attività a sostegno dei valori democratici.
Lingua e dialetti: generalità
La lingua ufficiale, parlata in tutto il territorio della repubblica, è l'italiano, ma entro i confini nazionali esistono numerose isole linguistiche, tutelate dall'art. 6 della Costituzione. Tra le principali minoranze alloglotte ricordiamo: quelle provenzali di molte valli del Piemonte occidentale e dell'alta Valle di Susa, e quelle franco-provenzali della media e bassa Valle di Susa, della Valle di Lanzo e della Valle d'Aosta (ma nello Statuto speciale della regione è sancito lo status ufficiale del francese – tradizionalmente lingua di cultura – accanto naturalmente all'italiano); quelle ladine delle valli situate intorno al gruppo del Sella; quelle tedesche dell'Alto Adige (tutelate nella provincia di Bolzano dallo Statuto speciale) e di zone circoscritte della Valle d'Aosta, del Veronese e del Vicentino; quelle slovene di alcune zone delle province di Udine, Gorizia e Trieste; quelle albanesi dislocate tra Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia; quelle greche di alcune zone della Calabria e del Salento; quella catalana di Alghero. Minoranze provenzali e franco-provenzali, relitti di antiche colonie valdesi, si ritrovano anche a Faeto e a Celle di San Vito, in Puglia, e a Guardia Piemontese, in Calabria. Dal punto di vista glottologico andrebbero considerate lingue diverse dall'italiano, e non semplici dialetti, anche il friulano e il sardo (quest'ultimo diviso in quattro varietà: logudorese, campidanese, gallurese e sassarese). L'italiano è parlato e studiato anche all'estero, sia in quei Paesi verso i quali c'è stato un forte flusso migratorio e la comunità italiana è piuttosto numerosa, sia in quelli in cui la cultura italiana – dalla letteratura alla musica, dalle arti figurative alla moda – gode di particolare prestigio, sia nelle ex colonie (in Somalia, per esempio, l'italiano è usato come lingua veicolare nell'insegnamento universitario). In questo campo le stime sono meno certe, ma si può quantificare in 300.000 gli italofoni in Svizzera e in più di un milione il numero nei soli Stati Uniti.
Lingua e dialetti: i rapporti tra centro e periferia
La storia linguistica italiana è caratterizzata da un'intensa e duratura dialettica tra centro (lingua nazionale) e periferia (dialetti), cosa che non si riscontra nelle altre principali culture europee: il territorio appare storicamente molto frazionato dal punto di vista linguistico e la diversificazione dei dialetti è tale che, per esempio, tra il siciliano e il milanese sussistono differenze maggiori di quelle riscontrabili tra milanese e francese. Semplificando, si possono distinguere tre grandi aree dialettali – la settentrionale, la centrale e la meridionale –, separate da due linee di confine: la linea La Spezia-Rimini e quella Roma-Ancona. All'area settentrionale appartengono i dialetti gallo-italici, veneti e istriani; alla centrale i dialetti toscani e mediani (parlati in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo); alla meridionale i dialetti meridionali intermedi ed estremi (tra questi ultimi vengono classificati, oltre al siciliano, i dialetti parlati nella Calabria meridionale e nel Salento). Delle parlate locali, quella toscana (e in particolare fiorentina) è la più simile all'italiano comune, dato che quest'ultimo deriva dal fiorentino trecentesco. Ma i due codici non possono essere pacificamente identificati; il fiorentino e l'italiano presentano alcune differenze, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche fonetiche: si pensi in particolar modo a pronunce come amiho, la hasa (è la cosiddetta “gorgia”), o alla riduzione dei dittonghi in forme come bono o novo. Alla fine del sec. XX solo una minoranza degli Italiani (circa il 10%) era esclusivamente dialettofona, così come la percentuale di coloro che parlano sempre e soltanto l'italiano era piuttosto ridotta (circa il 25%). La grande maggioranza della popolazione si trova in una condizione di “diglossia”, alterna cioè dialetto e lingua, scegliendo di volta in volta il codice da usare a seconda delle situazioni (queste cifre sono il risultato di stime e di processi autovalutativi da parte di coloro che rispondono a questo tipo di domande presenti, per esempio, nel censimento). Va anche detto che l'uso del dialetto è esteso in maniera molto diversa nelle varie zone d'Italia; esso si riscontra soprattutto nelle regioni nord-orientali (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), e in quelle centro-meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia). Altri fondamentali fattori di differenziazione sono l'età, il luogo in cui si vive, il livello culturale: il dialetto resiste di più tra le persone anziane, gli abitanti delle campagne e dei piccoli centri, le persone poco colte. In tutta Italia, comunque, i dialetti hanno subito e subiscono sempre più un processo di avvicinamento alla lingua nazionale: il grado di italianizzazione è già così forte da far ritenere a più di uno studioso che i dialetti siano destinati a scomparire in tempi relativamente brevi. Il sostrato dialettale fa sì che l'italiano sia parlato in modo sensibilmente diverso da zona a zona, tanto da poter parlare di italiani regionali, che si possono classificare in quattro grandi varietà: settentrionale, toscana, romana, e meridionale. Le differenze riguardano soprattutto la pronuncia e il lessico, mentre sono minori nel settore della morfosintassi. A proposito del lessico va anche notata la tendenza, sempre viva nell'Italia unita, per la quale molti regionalismi, una volta conosciuti in tutta la nazione, entrano a far parte a pieno titolo della lingua comune.
Lingua e dialetti: lingua scritta e lingua parlata
Se è vero che circa il 90% degli Italiani ha una competenza attiva dell'italiano, non bisogna però pensare che tutti siano in grado di utilizzare la lingua “standard” (quella descritta da grammatiche e dizionari). Una parte non irrilevante della popolazione ha, infatti, a disposizione come unico codice linguistico alternativo al dialetto il cosiddetto “italiano popolare”, ossia, come l'ha definito M. Cortelazzo, "il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto". Una caratteristica fondamentale di tale varietà – che sembrerebbe fare riferimento soprattutto alla lingua parlata, ma che in realtà è stata studiata per lo più nella sua realizzazione scritta – è l'interferenza a vari livelli tra italiano e dialetto, il che fa sì che sembri più corretto parlare di tanti “italiani popolari”. In effetti è possibile riscontrare alcuni fenomeni grammaticali comuni, più o meno corretti che, prescindendo dalle differenziazioni geografiche, si rintracciano nelle produzioni linguistiche, tanto orali quanto scritte, di tutti i semicolti (ovvero delle persone appartenenti agli strati culturali bassi). L'insieme di tali usi dà luogo a quello che F. Sabatini ha chiamato, con una formula fatta propria dalla quasi totalità dei linguisti, "italiano dell'uso medio". Va peraltro notato che nessuno dei fenomeni in questione è nuovo nella lingua (alcuni viceversa esistono da sempre): quello che è cambiato è il grado di accettabilità che oggi sembrano aver assunto (diverso comunque da caso a caso). Molti mutamenti in atto nell'italiano contemporaneo sono interpretabili come tracce di semplificazione grammaticale; si tratta di un processo che – al di là degli allarmi a volte lanciati su una presunta decadenza dell'italiano – è analogo nella sostanza a quello subito da tempo da altre lingue. È vero che l'italiano per certi aspetti ha subito profonde trasformazioni a partire dall'inizio del Novecento come un fatto in sé negativo, bensì come il risultato inevitabile della sua trasformazione da lingua pressoché solo scritta, posseduta da una esigua minoranza di persone, a lingua parlata dalla quasi totalità dei cittadini. Un'altra tendenza che desta molte preoccupazioni è l'“invasione” dei forestierismi non adattati, e in particolare degli anglicismi, che rischierebbero secondo alcuni di snaturare la nostra lingua (va detto peraltro che si tratta di un allarme da parecchio tempo vivo tra politici e opinionisti vari, ma molto meno tra i linguisti). In realtà, se è innegabile che la quota di anglicismi presenti in italiano è alta e in continua crescita, è anche vero che si tratta per lo più di parole tecniche, relative a settori ben specifici; molto diversa è la situazione se si guarda al cosiddetto “vocabolario di base” (ossia quelle parole che fanno parte del bagaglio lessicale delle persone di media cultura e il numero delle quali è stimato in modo assai diverso dai vari linguisti), in cui gli anglicismi non adattati sono relativamente pochi.
Letteratura: il Duecento
I primi documenti letterari in volgare italiano risalgono agli inizi del sec. XIII, anche se già da alcuni secoli idiomi volgari venivano usati in Italia per esprimere le esigenze concrete della vita quotidiana. L'uso del volgare come lingua della cultura ebbe inizio con la nascita della nuova civiltà comunale e l'affermazione di una classe borghese di imprenditori e di mercanti che nell'espressione dotta e ricercata trovò la consacrazione dell'importanza assunta nella vita cittadina in contrasto con il mondo dell'aristocrazia e del clero. Non si deve però pensare a una frattura tra la nuova cultura volgare e la cultura latina medievale: mentre infatti continuava la produzione dotta in latino, non pochi furono coloro che adoperavano il latino per scritture più immediate e artistiche: è il caso di Salimbene da Parma (1221-1288), autore di una colorita cronaca sulla vita della sua città. Notevole fu inoltre l'influsso esercitato sulla letteratura italiana delle origini dalla letteratura francese (con i romanzi del ciclo brettone, carolingio e classico) e provenzale (con la lirica dei trovatori): mentre nel Veneto fiorivano i poemi cavallereschi detti franco-veneti, in un francese imbastardito da volgarismi dialettali, presso le corti dell'Italia settentrionale poetavano in provenzale i trovatori di origine italiana: i genovesi L. Cigala e B. Calvo, il veneziano B. Zorzi e il più celebre di tutti, Sordello da Goito. Accanto alla produzione in latino, in francese e in provenzale, divennero sempre più numerose, nel sec. XIII, le manifestazioni letterarie in volgare, che si possono distinguere in due filoni essenziali: da una parte, la poesia aulica e raffinata, che si proponeva uno scopo risolutamente artistico ed eleggeva pertanto una lingua “illustre”; dall'altra, una serie di eterogenee esperienze letterarie che privilegiavano, rispetto ai fini artistici, quelli morali e religiosi e si rivolgevano a un pubblico più vasto di quello cortigiano, usando una lingua mediocre e popolareggiante. Non a caso il documento più antico delle nostre lettere, il mirabile Cantico di frate Sole (1224) di San Francesco (ca. 1182-1226), privilegia la lingua dei rapporti quotidiani anziché quella dei dotti: esso è espressione di quel messaggio popolare di umiltà e povertà in cui consiste l'essenza storica del francescanesimo. In Umbria, la poesia religiosa ispirata a San Francesco ebbe la sua fioritura collettiva nelle laude, i canti religiosi delle compagnie di flagellanti o disciplinati, che, assumendo forma drammatica, preludevano alla sacra rappresentazione. Delle laude si servì con geniale capacità di rielaborazione personale il più grande poeta religioso del Duecento, Iacopone da Todi (ca. 1236-1306). Tutt'altro che rozzo e incolto, Iacopone si abbandona a un'ossessiva vituperazione dei beni mondani e a una esaltazione inebriata, quasi sensuale, dell'amore divino con una tale robustezza di accenti che ha fatto erroneamente pensare alla schiettezza istintiva di un poeta popolare, mentre in realtà siamo dinanzi a un complesso fenomeno d'incontro tra natura e cultura, mediante il quale il sentimento religioso del popolo si eleva a un'autentica espressione poetica. Mentre in Umbria si affermava la poesia religiosa, nei Comuni del Nord fiorì una letteratura didattica e moraleggiante, volta a gettare le basi di una nuova cultura, che soddisfacesse le attese della borghesia. In area francescana si resta con Giacomino da Verona (seconda metà sec. XIII), autore di rozzi poemetti sui regni d'oltretomba, mentre, nella stessa materia, Bonvesin da la Riva (ca. 1250-ca. 1315) introduce un più consapevole senso dell'arte. Pur legata alle esigenze morali e religiose delle masse popolari, anche se sconfinano nell'eresia patarina, la letteratura dell'Italia settentrionale conserva un carattere gotico, ancora impregnato di echi feudali, mentre più laica e più raffinata è la poesia allegorico-didattica fiorita in Toscana, che ha i suoi testi esemplari nel Tesoretto di B. Latini (1220-1294) e nei poemetti anonimi Il Fiore e L'Intelligenza. In Toscana, inoltre, nasceva la prosa italiana e si stabiliva un saldo legame tra retorica e politica, come appare dalla Retorica di B. Latini, scritta per fornire all'uomo politico un manuale per parlare e scrivere bene. Dallo stesso gusto, tipicamente fiorentino, di un discorso artisticamente elaborato, derivò il Novellino, libro “di bel parlar gentile”, che si propose un intento di elevazione sociale e culturale nei confronti dei ceti subalterni. Al gusto aristocratico delle classi superiori, invece, venivano largamente incontro le traduzioni delle leggende bretoni, come il Tristano ricardiano e la Tavola ritonda; all'impetuoso espandersi dei Comuni toscani corrispondevano le cronache (dalla Sconfitta di Monte Aperto di anonimo senese all'Istoria fiorentina di Ricordano Malispini), nelle quali la storia era ancora concepita come opera diretta della Provvidenza. Non in volgare italiano, ma in francese fu scritto il testo più significativo della prosa duecentesca, il Milione di M. Polo che al gusto romanzesco associa una capacità tipicamente mercantile di osservazione di usi e costumi, costituendo il primo esempio di prosa scientifica moderna. Accanto all'esperienza culturale in versi e in prosa sin qui esaminata, si svolgeva una ricerca letteraria profondamente diversa, volta a fini esclusivamente artistici e riservata a cerchie selezionate e aristocratiche di lettori. La prima iniziativa unitaria e organica in tal senso fu quella della scuola siciliana, che raccolse intorno al saldo organismo del regno di Federico II, intellettuali, funzionari come Pier della Vigna (ca. 1190-ca. 1249), notai come Iacopo da Lentini (notizie 1233-1240), giudici come Guido delle Colonne (ca. 1210-1280) e gli stessi principi svevi, poeti dilettanti: il modello della poesia provenzale veniva da essi sottoposto a un processo di elegante stilizzazione e di alto manierismo, che isolava il tema dell'amore, concepito come rapporto d'ideale vassallaggio e come gioco raffinato e aristocratico. Al carattere dotto della scuola non si sottrassero neppure quei poeti, come Odo delle Colonne, Rinaldo d'Aquino, Giacomino Pugliese, Cielo d'Alcamo, tutti della prima metà del sec. XIII, che erano più vicini a spiriti e modi popolari. Dopo la sconfitta di Benevento (1266) la scuola siciliana si disperse; ma i suoi testi si erano già diffusi in Toscana, dove i rimatori ne assimilarono motivi e schemi, arricchendoli di una più complessa tematica psicologica, in direzione etico-politica (Guittone d'Arezzo, ca. 1235-1294) o mistico-simbolica (C. Davanzati, m. 1303).
Letteratura: il dolce stil novo e Dante
Dal ceppo di questa esperienza lirica toscana si stacca il dolce stil novo, con cui la poesia italiana d'ispirazione cortese toccò il suo culmine. Alla corte reale della scuola siciliana subentrò una corte ideale, un cenacolo di poeti colti e raffinati, che, mediante il concetto di “cor gentile”, sostituirono alla superiorità feudale derivante dalla nascita la nuova distinzione dell'“altezza d'ingegno”. Nutrita di pensiero filosofico, la nuova scuola si distaccava dalla tradizione sia per il processo d'interiorizzazione cui sottoponeva il tema amoroso sia per la sobrietà e la musicalità dell'espressione. La poesia stilnovistica trascorre dal fervore intellettuale di G. Guinizzelli (tra il 1230 e il 1240-ca. 1276), che, nella celebre canzone Al cor gentil rempaira sempre Amore, proponeva i motivi dell'identità tra amore e gentilezza e della donna-angelo, alla concezione cupa e pessimistica di G. Cavalcanti (ca. 1259-1300) che, con la fenomenologia degli “spiriti”, offrì la visione di un mondo irreale e astratto, percorso dai fantasmi del proprio dolore, fino alla concretezza psicologica di Cino da Pistoia (ca. 1270-ca. 1336 o 1337), con il quale, abbandonate le rarefatte e sognanti atmosfere guinizzelliane e cavalcantiane, si sgombrò la strada verso la lirica petrarchesca. Ma il maggior poeta del gruppo fu Dante, che, con la Vita nuova, offrì il più alto esempio di approfondita introspezione psicologica e di stile visionario: l'esperienza stilnovistica fu tuttavia per l'Alighieri solo una tappa di un ben più arduo cammino poetico. Antitetica allo stil novo fu la poesia burlesca (o giocosa o comico-realistica), che assunse i temi dimessi, grossolani o sensuali della vita, adottando un linguaggio corposo e “comico”, che però non riproduceva affatto la parlata quotidiana, ma era frutto di un'abile rielaborazione letteraria: il più cospicuo esponente di questa “maniera” fu il senese C. Angiolieri (ca. 1260-tra il 1311 e il 1313), i cui atteggiamenti di “poeta maledetto” sono in realtà il risultato di uno scaltrito gioco culturale, mentre, nella produzione di Folgore da San Gimignano (m. ca. 1330), il quadro di una vita signorile e godereccia viene trasferito in una sfera di raffinata mondanità. Non solo il Duecento, ma tutto il Medioevo cristiano si concluse nella gigantesca opera letteraria di Dante Alighieri (1265-1321). Non si deve infatti dimenticare che la Divina Commedia, apparentemente isolata nella sua monumentale grandezza, affonda le sue radici nella cultura medievale, sintetizzata, nel poema, in una concezione monolitica e, insieme, policentrica, che abbraccia cielo e terra, fede e ragione, vita e morte. Anche il distacco fra le opere minori e il capolavoro appare meno vistoso se si coglie la linea di sviluppo che lega un'opera all'altra in un processo ascensionale verso una piena maturità artistica e umana. Se, nella Vita Nuova e in gran parte delle Rime, Dante si era fatto interprete dell'ideale di vita raffinata della nuova classe dirigente del Comune fiorentino, dopo l'esilio egli si trasformò da intellettuale comunale in intellettuale cortigiano e, in tale nuova situazione, tentò la strada delle grandi opere di cultura, che potessero conferirgli prestigio, come il Convivio e il De vulgari eloquentia. Nel clima ideologico della Commedia si entra già con la Monarchia, in cui Dante risolve lo spinoso problema dei rapporti tra Impero e Chiesa, sostenendo che le due autorità promanano direttamente da Dio e sono quindi indipendenti l'una dall'altra, rispettivamente nella sfera temporale e in quella spirituale. Ma la crisi profonda delle due massime istituzioni medievali, congiunta al vanificarsi di ogni speranza di ritorno a Firenze, indusse il poeta ad abbandonare le grandi opere di cultura per dedicarsi definitivamente a una suprema opera di poesia in cui la ricchezza delle sue esperienze culturali e umane fosse proiettata su un piano universale. L'umano e l'eterno, il concreto e l'astratto, il realistico e il simbolico s'intrecciano strettamente nella Commedia, la cui radice è da ricercare in una visione profetica e utopica, e cioè nel recupero di un ideale passato, che realizzi in breve volgere di tempo un perfetto equilibrio tra Impero e Chiesa, mondanità e sacralità: poema di totale partecipazione, la Commedia esprime l'aspirazione del Medioevo a un'armonica fusione tra mondo superumano e realtà terrena, dalla quale possa scaturire il totale rinnovamento dell'umanità.
Letteratura: il Trecento
Nonostante la contiguità cronologica, il mondo di F. Petrarca (1304-1374) è molto diverso da quello di Dante: all'incrollabile fede in un ordine perfetto che sorregge la Commedia dantesca si contrappone, in Petrarca, la rinuncia ad affrontare la realtà esterna e la tendenza a chiudersi nella contemplazione del proprio mondo interiore. Libero da ogni legame politico e da ogni attività utilitaristica, Petrarca fece della cultura la sua professione, specializzandosi nello studio della letteratura, che viene isolata dal contesto ideologico della cultura medievale, dove s'identificava con la morale e la religione, per assumere un ruolo autonomo e una specifica funzione. Il ritorno all'antichità classica ebbe, in tale prospettiva, un valore decisivo: l'interesse per le humanae litterae consentì di recuperare l'alto insegnamento spirituale dell'umanità pagana, saldandolo con la cultura cristiana, a sua volta ricondotta alla purezza delle origini e fondata sul motivo squisitamente agostiniano dell'introspezione e dell'esame di coscienza. Non il racconto di una vicenda d'amore, ma una lucida analisi interiore vuole essere appunto il Canzoniere. Fin dal sonetto proemiale emerge il dissidio interiore (già analizzato nel Secretum) che travaglia l'animo di Petrarca: da una parte, un'ansia di assoluto, di stabilità, di pace; dall'altra, il senso della caducità di tutte le cose, travolte dall'incalzare del tempo verso la disgregazione e la morte. È un dissidio tra l'ideale e il reale che non può comporsi, perché dall'orizzonte di Petrarca sono scomparse le consolanti certezze che consentivano a Dante di concludere il viaggio della sua anima in Dio: ma il tentativo petrarchesco di conferire alle cose terrene la stabilità delle cose celesti è tutt'altro che vano, preludendo alla conciliazione tra l'umano e il divino, che costituirà il motivo dominante dell'età rinascimentale. Se il dissidio petrarchesco non può essere risolto, può almeno essere manifestato in un'espressione nitida e armoniosa: il perfetto dominio della forma sarà così per Petrarca il solo mezzo per dominare la sua inquietudine interiore. Petrarca ha in tal modo donato all'umanità non solo le espressioni più suggestive e più intense dell'amore e del dolore, ma la lingua stessa della lirica moderna. Rispetto a Petrarca, G. Boccaccio (1313-1375) appare più tenacemente ancorato alla realtà del Comune e alieno da ogni concezione sopranazionale dell'opera letteraria; in realtà, però, il suo capolavoro, il Decameron, si colloca in una prospettiva cosmopolitica, ricavando da una materia quotidiana e cittadina gli elementi di un'universale condizione umana. Nelle opere del periodo napoletano (la Caccia di Diana, il Filostrato il Filocolo, il Teseida trova espressione una ricca esperienza autobiografica, rielaborata secondo i moduli della cultura classica, senza trascurare tuttavia le narrazioni di tipo popolaresco. Il ritorno a Firenze significò per Boccaccio un rapporto più stretto con l'ambiente comunale e con la poesia allegorico-didattica che discendeva dalla Commedia dantesca: nacquero così il Ninfale d'Ameto e l'Amorosa Visione ben più interessanti sono l'Elegia di Madonna Fiammetta, dove l'appassionata materia autobiografica dei romanzi giovanili è esaminata con atteggiamento lucido e distaccato, e il fresco e arioso Ninfale fiesolano, pervaso di grazia popolaresca e di umana cordialità. Nel Decameron è raggiunto il difficile equilibrio tra la tendenza autobiografica allo sfogo e alla testimonianza personale e la volontà di contemplare con distacco la propria esperienza, facendola passare attraverso il filtro dell'arte. Il capolavoro di Boccaccio, ricco di robusti succhi popolari, persegue nel contempo il proposito di imitare le forme dell'arte colta e aristocratica, realizzando così la sintesi tra l'eredità del mondo feudale e le esigenze della borghesia comunale, desiderosa di assimilare e trasformare la cultura della vecchia classe egemone. Assai netto è il distacco dalla vertiginosa trascendenza della Commedia dantesca, come anche dallo scavo introspettivo del Canzoniere petrarchesco: opera di carattere mondano, il Decameron mostra una assoluta indifferenza per l'elemento religioso e un'assoluta fiducia nell'elemento laico dell'intelligenza e della cultura, anticipando alcune delle conquiste fondamentali della civiltà moderna, dalla contemplazione del desiderio sessuale come sana manifestazione di una forza di natura alla concezione della realtà come una costruzione esclusiva dell'uomo. Carattere dilettantesco, lontano dall'impegno realistico del Decameron, hanno le Trecentonovelle di F. Sacchetti (1330-ca. 1400), tipico esponente dell'oligarchia mercantile fiorentina. Il mondo svagatamente idillico di Sacchetti vuole dimenticare l'asprezza delle passioni politiche che invece pervade la Cronica delle cose occorrenti nei tempi suoi di D. Compagni (ca. 1255-1324): appassionata autodifesa politica, l'opera di Compagni mostra una robusta tempra morale, di stampo dantesco, mentre più scialba e più fredda è la cronaca di G. Villani (1276-1348), che però registra con interesse tipicamente mercantile gli aspetti della vita economica. Un filone interessante della produzione trecentesca è costituito dalla letteratura devota, e anzitutto dalle prose anonime dei Fioretti di San Francesco, che riflettono, nella grazia fresca e schietta delle narrazioni popolari, il tema francescano dell'umiltà, immergendolo in un'atmosfera di sogno e di fiaba. Ben diversa tonalità ha lo Specchio di vera penitenza di I. Passavanti (1302-1357), pervaso da un'atmosfera fosca e tetra e dominato, nei suoi “esempi”, dal motivo ossessivo della paura del peccato: siamo dinanzi a un esempio di realismo gotico, non sfiorato dalla ventata dell'umanesimo, mentre non altrettanto si può dire della produzione di Santa Caterina da Siena (1347-1380), nella quale il peccato diviene la conseguenza della libera volontà dell'uomo, padrone del proprio destino.
Letteratura: l'umanesimo
Sul finire del Trecento si diffuse tra gli intellettuali italiani il mito della rinascita della cultura classica, cui si accompagnò la nozione di un'età di mezzo, rozza e barbara, in cui fu deformato il vero volto della classicità. La concezione umanistica del mondo era imperniata su una visione ottimistica dell'uomo, non più creatura fragile e ossessionata dalla paura del peccato, ma libero, dotato di intelligenza ed energia per realizzare il proprio destino, capace di tenere a freno gli istinti e di raggiungere un equilibrio armonico tra il corpo e lo spirito. Tale concezione venne ritrovata dagli umanisti negli scrittori classici, lo studio dei quali fornì gli indispensabili strumenti per conoscere meglio il presente. Nacque così il principio di imitazione, inteso non nel senso di una pedissequa ripetizione, ma come scoperta, attraverso i classici, del proprio mondo interiore. L'imitazione presupponeva un'integrale conoscenza del patrimonio della classicità, in senso non solo quantitativo, ma anche qualitativo: si trattava cioè di un modo nuovo di leggere i testi degli antichi, nei quali non si vedeva più la rivelazione di una verità indiscussa, che andava solo interpretata e commentata, ma la fonte di una ricerca spregiudicata da compiere sottoponendo l'eredità del passato a una verifica sperimentale: esemplare, sotto questo profilo, è l'opera De falso credita ed ementita Constantini donatione di L. Valla (1407-1457), dove è dimostrata l'inautenticità del documento su cui la Chiesa fondava la sua pretesa al dominio temporale. È dunque lo spirito critico l'elemento caratterizzante che distinse l'età umanistica dal Medioevo e che fondò la scienza moderna. La scoperta della vera fisionomia della classicità implicava un atteggiamento polemico nei confronti della visione enciclopedica del sapere, tipica del Medioevo, che negava autonomia alle varie discipline, tutte subordinandole alla teologia; ed essendo lo studio dell'uomo il vero fine della cultura, vennero privilegiate le discipline letterarie. La lezione dei classici doveva però tradursi, secondo gli umanisti, in una concreta azione politica, perché solo nella dimensione della vita civile l'uomo realizza pienamente se stesso. Ne discese l'esaltazione della famiglia, della ricchezza, delle attività produttive ed economiche, che rivela le radici borghesi del movimento umanistico, nel quale giunse alla sua maturazione la civiltà comunale italiana: non a caso i più notevoli esponenti del primo umanesimo, da C. Salutati (1331-1406) a L. Bruni (ca. 1370-1444), da P. Bracciolini (1380-1459) a G. Manetti (1396-1459) , appartennero all'alta borghesia fiorentina. Ma la civiltà comunale era in via di esaurimento e la nuova realtà era quella della corte, presso la quale l'intellettuale perdeva la sua autonomia e diventava letterato di mestiere, al servizio di un signore. È questo il noto fenomeno del mecenatismo, i cui lati negativi risaltarono più tardi, ma che, all'inizio, agì come stimolo per integrare strettamente la cultura con la società. Ne sono una conferma il moltiplicarsi delle Accademie: l'Accademia Romana di tendenza archeologico-erudita, fondata da G. Pomponio Leto; l'Accademia Alfonsina (vedi Pontaniana), napoletana, fondata da G. Pontano, a indirizzo filologico-letterario; e la celebre Accademia Platonica Fiorentina, che ebbe i suoi maggiori esponenti nei filosofi Marsilio Ficino e Pico della Mirandola; il fiorire di scuole di tipo nuovo, che miravano alla formazione integrale, fisica e spirituale, dell'uomo (celebri soprattutto le scuole di Guarino Veronese a Ferrara e di Vittorino da Feltre a Mantova), la fondazione di biblioteche (dalla Biblioteca Vaticana di Roma alla Biblioteca Marciana di Venezia). Il mondo aristocratico delle corti stimolò il culto dell'eleganza e del decoro, l'aspirazione a un'euritmia interiore, che si tradusse nel vagheggiamento di un ideale di serenità e di armonia, sul quale fu sensibile l'influsso della filosofia platonica. Durante il trionfo dell'umanesimo latino, il volgare fu usato solo in opere che si proponevano fini pratici e fu legato ai valori della tradizione. Gli scrittori devoti si ricollegavano agli spiriti e alle forme della letteratura precedente e, rivolgendosi alle masse incolte, escludevano ogni proposito d'arte: F. Belcari (1410-1484) tentò ingenuamente di far rivivere la lauda medievale; Bernardino da Siena (1380-1444) compose in uno stile saporosamente popolaresco le sue prediche, prive di accenti cupi e pessimistici, mentre, al contrario, fosca e apocalittica fu la visione religiosa di G. Savonarola(1452-1498). Un gusto per il cupo e l'orrido caratterizzò anche il Novellino di Masuccio Salernitano (1415-1475), che ricalca i motivi del Decameron. Anche la poesia burlesca ebbe una sua prosecuzione nelle stravaganti rime di Domenico di Giovanni detto il Burchiello (ca. 1404-1449), che si fece portavoce delle esigenze espressive dei ceti subalterni. Verso la metà del Quattrocento, esaurita la fase del bilinguismo, si verificò la rinascita del volgare come lingua colta. La letteratura volgare riapparve ufficialmente nell'ambito della più illustre tradizione con il "certame coronario" (1441), una gara di poesia in volgare promossa da L. B. Alberti (1406-1472), lo scrittore che conciliò in una sintesi armonica la cultura umanistica con la tradizione volgare: nella sua opera più nota, il trattato Della Famiglia, si rispecchia l'ideale di equilibrio e di saggezza che è frutto di una dura lotta della virtù contro la fortuna. Personalità poliedrica e aperta a molteplici esperienze come Alberti fu Leonardo da Vinci, che però si definì un antiumanista (“uomo sanza lettere”): in realtà, nell'appassionato fervore, non privo di religioso sgomento, con cui egli indagò il mondo della natura, sottoponendolo alla verifica sperimentale, si ripeteva lo stesso atteggiamento degli umanisti nei riguardi della realtà storica e umana; e squisitamente umanistica è l'affermazione leonardesca della superiorità della pittura sulla geometria e l'aritmetica. Poliedrica fu anche la personalità di Lorenzo de' Medici (1449-1492), detto il Magnifico, nella cui intensa attività politica la poesia non poteva che costituire un episodio. Nella sua eclettica produzione il Magnifico accolse gli stimoli più diversi, dal platonismo ficiniano alle suggestioni stilnovistiche e petrarchesche, dal corposo realismo all'edonismo idillico e voluttuoso, dalla sensualità alla spiritualità; ma nelle sue cose più felici, la Nencia da Barberino e il Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo seppe assumere i sentimenti di un contadino innamorato o di tutta una folla festante, esprimendo attraverso un eccezionale equilibrio fantastico lo spirito di tutta un'epoca. Una prodigiosa cultura classica distinse, nella cerchia medicea, A. Ambrogini detto il Poliziano (1454-1494), che nella sua opera volgare espresse un ideale di perfetta armonia umanistica nel segno di una compiuta resa di stile. Nelle ballate il Poliziano si piegò con simpatia verso la lirica popolaresca, conciliandone la freschezza e spontaneità con una finissima rielaborazione letteraria; nella Favola d'Orfeo, intrecciò il mito classico con la struttura scenica delle sacre rappresentazioni, nelle Stanze per la giostra, infine, tradusse in musica perfetta il sogno umanistico della bellezza, sullo sfondo di una ridente natura primaverile. L'arte del Poliziano non si può facilmente definire: i suoi eleganti arabeschi danno corpo al sentimento idillico della vita e al vagheggiamento della giovinezza e dell'amore, unito alla struggente malinconia per la loro inevitabile fugacità; sulla sostanza psicologica e umana prevale però, in questi splendidi arazzi, l'esercitazione figurativa fino ai limiti del decorativo. All'ombra della corte medicea visse anche L. Pulci (1432-1484), che però, a differenza del Poliziano, non ebbe una compiuta educazione umanistica e si ricollegò alla tradizione burlesca, dando al suo poema, il Morgante, un'impronta vivacemente popolaresca. La materia del poema, la cavalleria, lasciava moralmente indifferente uno smaliziato borghese fiorentino come il Pulci, che, dentro la sinuosità delle vicende avventurose, proiettò il suo estro comico e bizzarro e il suo spirito anticonformista e provocatorio. Ma è nell'inesauribile vivacità linguistica del poema che si scopre la sua segreta sostanza umanistica, e cioè quel gusto dell'estrosa avventura filologica che coincide con il fervore dell'età delle esplorazioni e delle scoperte geografiche. La cavalleria, indifferente per il borghese Pulci, rappresentò per il conte M. M. Boiardo (1441-1494) un mondo di valori autentici, intensamente sentiti e vissuti. Il cavaliere fu umanisticamente inteso da Boiardo come l'individuo attivo e libero che trionfava sulla fortuna grazie alla sua forza fisica e al suo coraggio morale: di conseguenza, nell'Orlando innamorato, evocando un mondo incantato e una umanità energica e primitiva, Boiardo idealizzò e trasfigurò nel sogno il mondo stesso della corte di Ferrara. Accanto alle armi, l'amore è l'altro motivo dominante dell'Innamorato; ma siamo anche qui lontani dalla visione medievale: la concezione cortese della donna “angelicata” sparisce nella maliziosa figura di Angelica, nella cui psicologia sensuale e capricciosa si esprime un'intuizione modernissima della femminilità; e del resto un'onda di calda sensualità percorre anche il Canzoniere di Boiardo, riscattandolo dall'imitazione petrarchesca e facendone la più alta espressione della lirica del Quattrocento. Per il carattere della sua cultura, il napoletano I. Sannazaro (1457-1530) si distacca dai limiti del suo secolo, anticipando la figura del letterato puro che sarà propria del Cinquecento. Nelle molli cadenze del suo romanzo pastorale, l'Arcadia, si esprime una vena sottile di assorta malinconia e si idealizza il mondo bucolico; ma sul sentimento idillico prevale il culto delle belle forme poetiche del passato, assaporate con nostalgia e trasposte in un leggiadro mosaico di citazioni e di reminiscenze.
Letteratura: il Rinascimento
Nei primi decenni del sec. XVI il movimento umanistico giunse alla sua estrema maturazione, che prende per consuetudine il nome di Rinascimento. Centro della concezione rinascimentale fu l'uomo, che compendiava in sé il tutto, come un microcosmo che rispecchia l'intero universo. Di fronte all'uomo era la natura, intesa animisticamente come un complesso di forze oscure che l'uomo poteva dominare solo attraverso lo studio delle sue leggi, ancora sconosciute, ma non inconoscibili. Nell'ambito di questo mito centrale dell'uomo signore dell'universo, si possono individuare due fondamentali tendenze: quella idealistica, che fa capo a Castiglione e a Bembo, e quella realistica, che si scinde nel realismo politico di Machiavelli e Guicciardini e nel realismo della cosiddetta “letteratura d'opposizione” al classicismo; a mezza strada fra idealismo e realismo si colloca Ariosto. Lo sfondo sociale della letteratura “idealizzante” fu la corte; nella piccola ma splendida corte di Urbino si ritrovano i maggiori esponenti di questa tendenza: il mantovano B. Castiglione (1478-1529) e il veneziano P. Bembo (1470-1547). Con il Cortegiano, Castiglione si colloca tra i più autentici interpreti della civiltà rinascimentale, che vagheggiava nel “perfetto cortegiano” l'uomo equilibrato, ricco di cultura raffinata, dedito al mestiere delle armi e, nel contempo, abile consigliere del principe. Sul piano del Cortegiano è da collocare il Galateo di G. Della Casa (1503-1556), che non è solo un trattato di buone maniere, ma l'elogio dell'ideale rinascimentale del decoro e della misura. Vero dittatore della cultura cinquecentesca fu P. Bembo: i suoi Asolani diedero impulso alla trattatistica amorosa di tipo platonico e le Rime diedero il via all'importante filone del petrarchismo; ma la sua fama è affidata soprattutto alle Prose della volgar lingua, manifesto della nuova cultura volgare, alla quale Bembo proponeva come modelli Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa. Nel clima bembiano la poesia di Petrarca, a differenza della poesia cortigiana del sec. XV, non venne ridotta ad arido repertorio di motivi poetici da imitare retoricamente, ma fu intesa nel suo intreccio inscindibile di armonia formale e di armonia spirituale. Tra i poeti di area veneziana furono petrarchisti, oltre Bembo, G. Stampa (1523-1554), V. Franco (1546-1591), C. Magno (1536-1602). Tra i poeti fiorentini, dominò la figura di G. Della Casa, il maggiore dei lirici petrarchisti per compiutezza di stile e ricchezza di sentimento; a parte si colloca M. Buonarroti per il linguaggio aspro e oscuro e per la sofferta e drammatica religiosità delle sue rime. Nel Meridione, infine, si distinse per intensità di sentimento il cosentino Galeazzo di Tarsia (ca. 1520-1553). Da uno stato d'animo di disarmonia psicologica e morale sorse la protesta contro il petrarchismo di F. Berni (1498-1535), la cui poesia burlesca, viziata di letterarietà, rimane tuttavia confinata nei limiti di un'elegante e abile canzonatura. L'imitazione di Boccaccio, fissato da Bembo come modello linguistico per la prosa, dominò nella novellistica: il maggiore novelliere fu A. Firenzuola (1493-1543), che alla semplicità della materia favolistica della sua Prima veste dei discorsi degli animali congiunge un'estrema raffinatezza dello stile. Ma l'influsso del Decameron è ancor più visibile nelle commedie cinquecentesche, la più festevole e brillante delle quali è la Calandria di B. Dovizi da Bibbiena (1470-1520). La tendenza all'armonia avvicina L. Ariosto (1474- 1533) alla letteratura idealizzante, mentre il suo interesse concreto per la realtà lo colloca accanto a scrittori liberi e spregiudicati come Machiavelli e Guicciardini. Fin dalle opere minori, Ariosto mostra un profondo senso della realtà. L'amore è da lui inteso come possesso fisico e come irrazionalità nei Carmina e nelle Rime, anche se certi momenti più appassionati fanno intravedere gli amori intensi e travolgenti del Furioso. Nelle Commedie c'è già quel gusto dell'intrigo che prelude alla sapienza compositiva del capolavoro, mentre, nelle Satire, Ariosto esprime la consapevolezza della sua misconosciuta condizione di poeta, contemplando con una punta di amara ironia le disavventure di ogni giorno. Brusco appare il passaggio da questa mediocrità quotidiana alle vertiginose altezze fantastiche dell'Orlando furioso, ma un'attenta lettura dimostra come il poema ariostesco non si riduca a un libro di evasione dalla realtà nell'universo della poesia: a parte i continui riferimenti storici, nella ricchezza psicologica dei personaggi creati dalla sua fantasia, Ariosto si è dimostrato uno scrittore essenzialmente realista. Accanto all'impegno realistico c'è tuttavia nel poema un dilettoso abbandono al sogno fantastico: basti pensare agli episodi del palazzo di Atlante o di Astolfo nella Luna. Tutti questi aspetti reali o fantastici sono però contemplati con occhio distaccato e superiore, che consente ad Ariosto di cogliere quella visione dialettica della realtà che è nota con la definizione crociana di “armonia”; e l'ironia è il mezzo di cui si serve il poeta per equilibrare realtà e fantasia. Tale ironia non è però rivolta alla dissoluzione del mondo cavalleresco, secondo la nota interpretazione hegeliana, ma sorge dalla consapevolezza dei limiti stessi della natura umana: Ariosto, il cui orizzonte ideologico è quello di una totale immanenza, è l'unico grande esponente del Rinascimento che abbia esaltato i sentimenti naturali, non nascondendosi gli inesorabili limiti e gli irrimediabili errori connessi con la condizione stessa dell'uomo e contemplandoli con saggezza disincantata e serena. Se Ariosto è un poeta puro, N. Machiavelli (1469-1527) è un puro politico: ma in entrambi è uguale il punto di partenza, e cioè il superamento della concezione trascendente del mondo. Anche per Machiavelli, tuttavia, come per Ariosto, la visione totalmente immanente della realtà lascia oscuri molti lati di essa, sui quali si dispiega l'opera capricciosa della fortuna. L'azione politica si configura pertanto come una lotta della virtù del principe contro l'arbitrio della fortuna: in tal modo, la politica diventa monopolio di grandi personalità, di uomini di genio; ma ciò corrisponde perfettamente alla situazione storica di transizione tra l'estrema sopravvivenza della tradizione comunale e repubblicana e l'avvento dell'assolutismo sulla scena europea. Il cuore e il pensiero di Machiavelli furono per la repubblica popolare; ma i tempi corrotti e la fragilità degli Stati italiani sotto l'incalzare della minaccia straniera gli fecero vagheggiare la figura di un “principe nuovo” che realizzasse il suo grande sogno della liberazione dell'Italia dai “barbari”. Il Principe si inserisce pertanto nella più ampia trattazione dei Discorsi, come una riflessione suggerita da una situazione contingente e da un improvviso entusiasmo passionale, sempre però controllato da una ferrea logica che ordina la trattazione secondo un metodo rigorosamente scientifico: dall'osservazione della realtà si risale alla teoria e se ne cerca infine una verifica nella prassi. La scienza politica, a sua volta, si fonda su una scienza dell'uomo, la cui natura, nella meccanica delle passioni e dei sentimenti, è immutabile. Questa impostazione ha come conseguenza l'autonomia della politica dalla morale: per la prima volta, la storia è considerata seguendo la “verità effettuale delle cose” e non “l'immaginazione di essa”. La spregiudicata osservazione della realtà si ripete con la Mandragola: qui, però, mancando l'impegno politico che solo può mutare il reale, non resta che la malvagità e la corruzione degli uomini, contemplata con doloroso e amaro distacco. Alla convinzione di Machiavelli che dalla lezione degli antichi si potessero ricavare le regole fondamentali della politica, F. Guicciardini (1483-1540) contrappose il suo disilluso realismo, chiudendosi nel proprio “particulare”. L'attività del politico si riduce così, per Guicciardini, a mera empiria, rinunciando a quella scientificità che costituisce la parte più valida e geniale del pensiero machiavelliano. Se, come teorico, Guicciardini è inferiore a Machiavelli, gli è però superiore come storico, per l'esclusiva attenzione ai fatti e lo scrupolo documentario che fanno della Storia d'Italia l'opera con cui nasce la moderna storiografia. Accanto alle contrapposte tendenze dell'idealismo platonizzante di Bembo e Castiglione e del realismo politico di Machiavelli e Guicciardini, la cultura rinascimentale si mosse su un terzo piano, in cui si registrò una polemica, spinta fino alla rottura, nei confronti del classicismo egemone. Tale polemica, nella produzione di P. Aretino (1492-1556), si ridusse a un gusto di sperimentazione linguistica che si esplicò soprattutto nel compiacimento dell'osceno, anche se non va dimenticata l'opera di eversione dei rapporti cortigiani condotta dal “flagello dei principi”. Di una vera e propria “letteratura d'opposizione” al classicismo è lecito parlare solo a proposito di B. Cellini (1500-1571), per il suo stile vigoroso e incisivo, di un'efficacia robustamente popolaresca, e soprattutto del Folengo e del Ruzzante, nei quali la rottura della consueta forma linguistica coincise con un sostanziale rifiuto dei valori ideologici e culturali del Rinascimento. Nel Baldus, T. Folengo (1491-1544) fece del latino maccheronico una lingua originalissima volta a parodiare la tradizione letteraria classicistica; ma, accanto all'elemento parodistico, è presente nel poema una vivace ispirazione realistica, che si manifesta nella scoperta del mondo subalterno della campagna, visto non più come oggetto d'ironia, ma come realtà sociale in cui si nasconde una forte carica di ribellione contro lo sfruttamento operato dal mondo cittadino. Ma l'esperienza più valida e significativa in questa direzione è quella del padovano A. Beolco detto il Ruzzante (ca. 1496-1542), che, nel trittico del Reduce, del Bilora e della Moscheta, analizza acutamente le reazioni psicologiche e morali del contadino quando è strappato dal suo isolamento rustico e costretto a operare nella dimensione alienante del mondo storico.
Letteratura: la crisi del Rinascimento
Il secondo Cinquecento coincise con un'epoca di crisi e di transizione in cui giunse al suo esaurimento la felice stagione rinascimentale e si gettarono le basi dell'età barocca. Molteplici sono i fattori dell'“autunno del Rinascimento”: dalla decadenza politica alla stagnazione economica, dalla cristallizzazione degli squilibri sociali all'influsso della Riforma e della Controriforma. In letteratura, la mutata atmosfera si manifestò nell'intrecciarsi di una sensualità torbida e malata con accenti di autentica e sofferta ansia religiosa, mentre si accentuò la riflessione critica che codificò la produzione letteraria in una rigida e scolastica precettistica. L'ambiguità dell'epoca si riflette nelle opere degli storici, che, con l'espediente del “tacitismo”, cercarono di risolvere la contraddizione tra il ripudio teorico di Machiavelli e l'accettazione pratica del machiavellismo, e degli studiosi di politica, come G. Botero (1540-1617), che tentò di conciliare artificiosamente politica e morale. Il principio di autorità, vigorosamente sostenuto dalla Controriforma, si riflette, sul piano culturale, nel prolificare delle Accademie (celebre l'Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583) e nel culto di Aristotele, che subentrò al platonismo del primo Cinquecento: la pubblicazione della Poetica di Aristotele (1536) diede luogo a un vivace dibattito sui “generi letterari” e particolarmente sulla tragedia, di cui furono fissate rigidamente le tre unità di luogo, di tempo, di azione. Nella lirica, il tono decoroso ed elegante della moda petrarchesco-bembiana cedette a effetti di artificioso cerebralismo o di abbandonata voluttà: basti ricordare il venosino L. Tansillo (1510-1568), alla cui mollezza ed esuberanza d'immagini si ispirò Marino. Anche nel campo della poesia epico-cavalleresca venne meno l'armonioso equilibrio dell'Orlando furioso, pedantescamente accusato di non rispettare alcun criterio di unità. Ma, in seguito all'esito infelice di un poema di stretta osservanza aristotelica come l'Italia liberata dai Goti di G. Trissino (1478-1550), si cercò una soluzione di compromesso, conciliando la molteplicità delle azioni con l'unità del protagonista: su questa linea si muove l'Amadigi di B. Tasso (1493-1569), mentre A. Caro (1507-1566), con la sua ottima traduzione dell'Eneide, saggiò fino in fondo le capacità espressive della lingua italiana, precorrendo la sensibilità barocca. Anche nella novellistica si anticipò il barocco con il gusto del romanzesco, inaugurato da M. Bandello (1485-1561) con le sue Novelle, che si allontanano dalla tradizione boccacciana per il loro tono cronachistico. La politica senechiana del macabro e dell'orrido domina le tragedie di G. B. Giraldi Cinzio (1504-1573): nella più celebre, l'Orbecche, si prelude a quel tipo di teatro tenebroso e solenne che avrà la sua massima espressione nel secolo successivo. La coscienza della mutevolezza delle forme letterarie, che fu tipica del barocco, si avvertiva già in quella sintesi di tragedia e di commedia che è costituita dalla favola pastorale, il cui esempio migliore, a parte l'Aminta di Tasso, è il Pastor fido di G. B. Guarini (1538-1612). Una voce solitaria, in un'età caratterizzata dall'infatuazione per le regole aristoteliche, fu infine quella di G. Bruno (1548-1600), il quale, negli Eroici furori, sostiene che la poesia non nasce dalle regole, ma queste dalla poesia, e, nella commedia Il candelaio, satireggia acremente ogni forma di pedanteria. Accanto a Bruno, un'altra vittima illustre della crisi rinascimentale fu T. Tasso (1544-1595): il principio di autorità, nella sua duplice veste culturale (l'aristotelismo) e religiosa (la Controriforma), fu la tragedia della sua vita. Radicalizzando la concezione edonistica del Rinascimento, Tasso isolò nell'Aminta il motivo dell'amore, colto nel suo primo sbocciare, in una cornice di natura primaverile, mentre, sullo sfondo del paesaggio tenebroso del Torrismondo, rappresentò il crollo della dolce illusione amorosa; tra le due opere si colloca la Gerusalemme liberata, in cui l'intensa elegia amorosa si manifesta nel senso della caducità di ogni cosa in cui si proietta lo stato d'animo malinconico e dolente del poeta. Questa ispirazione patetica investe la stessa struttura epico-religiosa del poema, che non si riduce affatto a un'invenzione estrinseca, ma conferisce, nell'urto tra l'amore e il dovere, grandezza drammatica alla poesia tassiana. Tasso, il cui influsso culturale ha un termine di confronto solo in Petrarca, costituì il punto d'incontro delle letterature europee sotto il segno della civiltà barocca, che egli anticipò, pur senza appartenervi.
Letteratura: il barocco
Fu indubbiamente un'epoca di crisi: mentre si aggravava la decadenza politica in coincidenza con la crisi del predominio spagnolo, si verificava, in economia, un ritorno massiccio alla proprietà terriera, con il conseguente passaggio, sul piano culturale, da una fase cosmopolitica a una fase provinciale. Le teorie copernicane, inoltre, non ponevano più l'uomo e la Terra che egli abitava al centro del cosmo: si smarriva la sintesi rinascimentale e veniva meno ogni certezza, tranne quella della presenza del male. Di qui la ricerca del nuovo a tutti i costi, la poetica della “meraviglia”, che si limitava però, il più delle volte, a un semplice artificio retorico. Il poeta più rappresentativo del barocco letterario fu G. Marino (1569-1625), per il quale la poesia non scaturisce da una necessità interiore, ma è frutto di capriccio e di bizzarria; ma, accanto alla meraviglia artificialmente provocata nel lettore, si registra, nell'Adone, un più autentico stupore dinanzi alla riposta magia delle cose, che fa del poema un immenso inventario della realtà esterna, raccolta in un ideale museo. Non lontano dalla poetica mariniana della meraviglia, nonostante il suo proposito di ritorno alla grande tradizione classicistica, è G. Chiabrera (1552-1638), la cui importanza, al di là dei risultati di musicalità piacevole, non priva però di una certa monotonia, dei suoi versi, è quella del suo sperimentalismo metrico e formale. Al classicismo di Chiabrera si ispirò F. Testi (1593-1646), le cui poesie politico-morali sono improntate a una solenne eloquenza. Una diversa e ben più concreta attenzione alle misere condizioni della plebe napoletana è presente nella poesia satirica di S. Rosa (1615-1673), mentre, nella poesia eroicomica di A. Tassoni (1565-1635), tutti i modi consueti del poema eroico sono coinvolti e demistificati. Una sbrigliata libertà fantastica, congiunta a un sanguigno realismo popolaresco, caratterizza il Pentamerone del napoletano G. Basile (1575-1632), che costituisce il testo più significativo della copiosa letteratura dialettale del Seicento. Il motivo dell'orrore del vuoto e della morte costituisce il tema più sotterraneo, ma forse il più autentico, della letteratura barocca: se ne ha consapevolezza maggiore nelle tragedie di F. Della Valle (1560-1628), la cui ispirazione è divisa tra le seduzioni di un colorismo barocco e un senso di intima religiosità e di profonda malinconia. Il compiacimento barocco per l'elemento scenografico caratterizzò le altre forme teatrali del Seicento, dalla Commedia dell'Arte, che, sorta alla fine del secolo precedente, si affermò come forma nuova di spettacolo, non libresca ma fondata sull'esperienza viva degli attori, al melodramma, nel quale parole e musica confluivano al comune risultato del “recitar cantando”: tali nuove esperienze teatrali rappresentarono un originale contributo italiano alla civiltà culturale europea. Di risonanza europea (e tali da riscattare il Seicento dal giudizio negativo che lo accompagnò a lungo in sede storiografica) sono i nomi di Galilei, Campanella, Sarpi, che, consapevoli della crisi del secolo, sono tuttavia da riconnettere allo spirito del barocco. L'opera scientifica di G. Galilei (1564-1642) nacque in un clima antirinascimentale, secondo una nuova impostazione della ricerca scientifica, che rifiutava di anteporre le regole all'originalità dell'esperienza. Se è vero che la prosa galileiana, per la sua chiarezza esemplare, rimane lontana dall'artificioso stile barocco, la lotta contro il principio di autorità, condotta strenuamente nel Saggiatore e nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, si ricollega all'antiaccademismo del Seicento; e tipici dell'epoca sono l'entusiasmo della scoperta, mediante il telescopio, di nuovi mondi, come lo stupore dinanzi alle meraviglie del cosmo rivelate dal microscopio: a differenza che in Marino, però, nel quale la “meraviglia” era consapevole artificio, in Galilei essa nasceva da un'autentica e commossa contemplazione della natura. Vittima, come Galilei, della situazione storica di immobilismo e di chiusura del Seicento fu T. Campanella (1568-1639), che si rifugiò nell'utopia politica della Città del Sole; ma era un'utopia che affondava le sue radici nelle misere condizioni dei contadini calabresi ed era volta a colmare l'abisso tra intellettuali e masse popolari. Anche la poesia campanelliana nasce dall'ottimistica convinzione di poter incidere nella realtà sociale mediante un'opera riformatrice cui l'autore si sentiva chiamato: da tale fervore derivano quelle folgorazioni improvvise, tipicamente barocche, in cui il travaglio intellettuale di Campanella si libera nell'esaltante coscienza della propria vocazione. Una lucida consapevolezza dell'impossibilità di modificare la realtà è in P. Sarpi (1552-1623) che, a differenza di Galilei e di Campanella, rinunziò all'azione e rimase esclusivamente un uomo di cultura, ricercatore appassionato e tenace della verità. Il motivo essenziale della nuova ricerca storica barocca, e cioè la minuziosa cura filologica nella ricostruzione degli eventi, trovò la sua celebrazione nell'Istoria del Concilio Tridentino, il cui stile è solo in apparenza freddo e disadorno secondo modi cinquecenteschi: in realtà, la capacità dello scrittore di analizzare la complessa realtà degli intrighi e dei maneggi diplomatici rivela un'eccezionale forza di ritrattista morale e un'acutezza psicologica che è in armonia con le nuove tendenze del secolo. Cadute le resistenze di intellettuali come Galilei, Campanella e Sarpi, la cultura controriformista dilagò nella seconda metà del Seicento grazie all'opera tenace dei gesuitii, che cercarono di conciliare la cultura laica con il magistero ecclesiastico. Gli stessi gesuiti, anzi, si trasformarono in intellettuali moderni: da E. Tesauro (1592-1675) che integrò nell'ordine controriformistico la rivoluzione estetica del marinismo, a Sforza Pallavicino (1607-1667) che reintrodusse nella storiografia il concetto di Provvidenza, da D. Bartoli (1608-1685) che nell'Istoria della Compagnia di Gesù esaltò la Chiesa come unica depositaria della verità e indicò nella contemplazione religiosa la vera fonte dell'osservazione scientifica, a P. Segneri (1624-1694), il maggiore tra gli oratori sacri del Seicento. Le prime avvisaglie di una nuova sensibilità, orientata verso un ritorno al classicismo, si avvertirono infine, alla fine del secolo, presso gli esponenti della scuola galileiana, dal toscaneggiante F. Redi (1626-1698), paziente osservatore dei fenomeni naturali, a L. Magalotti (1637-1712), il “postiglione d'Europa”, che, con il suo intelligente dilettantismo e la sua fertile curiosità di viaggiatore poliglotta, anticipò il cosmopolitismo del Settecento.
Letteratura: l'Arcadia
Con la guerra di successione spagnola l'Italia, venne a trovarsi di nuovo al centro delle vicende europee; parallelamente si diffuse nella penisola la conoscenza della filosofia cartesiana, intorno alla quale si aprì un vivace dibattito. Mentre la cultura francese subordinava rigidamente, sulle orme di R. Cartesio, la fantasia alla ragione, pronunciando un severo giudizio sulla poesia italiana da Tasso a Marino, i nostri studiosi, pur avvertendo l'esigenza di “esterminare il cattivo gusto” barocco, non erano però disposti a rinunciare agli elementi irrazionali e fantastici: questa esigenza di accordare fantasia e ragione ebbe il suo più convinto sostenitore nel calabrese G. V. Gravina (1664-1718). A Gravina e a G. M. Crescimbeni (1663-1728) si deve la fondazione (1690) dell'Arcadia, il cui programma era quello di opporsi alla “barbarie dell'ultimo secolo”, ritornando alla naturalezza e alla semplicità dei classici. La pretesa di restaurare la tradizione pastorale e la tendenza a evadere in una campagna idealizzata e artificiosa costituiscono gli aspetti negativi dell'Arcadia, il cui merito fu tuttavia quello di aver rivendicato, in un'età razionalistica e impoetica, i diritti della poesia. La riscoperta arcadica di una poesia più semplice e aggraziata portò inoltre a esaltare, fino al limite della svenevolezza e della leziosaggine, l'aspetto musicale e cantabile della tradizione lirica italiana: è questa la tendenza comune dei poeti arcadi (G. F. Zappi, C. I. Frugoni, P. A. Rolli, L. V. Savioli e altri), che, nel maggiore tra di essi, P. Metastasio (1698-1782), trovò la sua più compiuta espressione. Il rinnovamento del primo Settecento non si limitò al movimento arcadico, ma lasciò tracce profonde anche nel campo della storiografia e dell'erudizione: di fondamentale importanza fu, nel quadro di tale rinnovamento, la figura di G. B. Vico (1668-1744). A differenza di Cartesio, Vico indicò, nella Scienza nuova, il criterio della verità non nella scienza matematica, ma nella scienza dell'uomo, cioè nella storia: tale concezione superava di colpo le posizioni antistoriche della successiva generazione illuministica, anticipando la storiografia romantica. Ma Vico fu un geniale anticipatore anche nel campo dell'estetica: opponendosi anche in questo settore alle tendenze intellettualistiche del suo secolo, egli delineò il carattere sentimentale e fantastico della creazione poetica, insieme a quello non razionale ma immaginoso e mitico del linguaggio, che è indissolubilmente congiunto all'espressione poetica. Tale impostazione rivalutava la poesia come facoltà immediata e spontanea e, con essa, i poeti più istintivi e robusti, come Omero e Dante. Al di là di Vico, il rinnovamento culturale italiano si svolse nelle direzioni del giurisdizionalismo e della storiografia. Nella prima direzione, ebbe grande rilievo il pensiero di P. Giannone (1676-1748), che nella Istoria civile del regno di Napoli rivendicò l'autonomia dello Stato nei confronti del potere religioso e, nel Triregno, portò la critica alla Chiesa fino al rifiuto di ogni trascendenza. Nel campo storiografico spicca la figura di L. A. Muratori (1672-1750), che nei monumentali Rerum Italicarum Scriptores lasciò uno strumento eccezionale di studio del Medioevo e, nelleAntiquitates Italicae Medii Aevi, fornì l'esempio di una storiografia nuova, fondata sullo studio della vita soiale, con particolare simpatia per gli oppressi.
Letteratura: l'illuminismo
Lo sforzo di rinnovamento culturale del primo Settecento venne proseguito e approfondito nella seconda metà del secolo, confluendo nella civiltà dell'illuminismo, che si svolse dal nucleo originario del razionalismo cartesiano. A Milano il gruppo illuminista si raccolse intorno al periodico Il Caffè, animato da P. Verri (1728-1797), ed ebbe la sua opera di punta nel libretto Dei delitti e delle pene di C. Beccaria (1738-1794), che suscitò larghissimi consensi in tutta Europa. A Napoli, la tradizione di pensiero di Giannone e di Vico ebbe i suoi continuatori in A. Genovesi (1713-1769), G. Filangieri (1752-1788), F. M. Pagano (1748-1799), mentre un posto a sé per la critica spregiudicata dei motivi utopistici del secolo occupa l'abate F. Galiani (1728-1787), il cui trattato Della moneta piacque a K. Marx. Anche a Venezia non mancò un vivace dibattito culturale, soprattutto a opera di due fecondi poligrafi: F. Algarotti (1712-1764), cui si deve la diffusione di forme espressive più adatte alla divulgazione culturale, come la lettera, il dialogo e il saggio, e G. Gozzi (1713-1786), che, pur scettico nei confronti delle più avanzate posizioni illuministiche, non fu però alieno dall'accogliere talune istanze di rinnovamento, a differenza del fratello C. Gozzi (1720-1806), così tenace nella lotta contro la nuova cultura da risuscitare, nelle Fiabe teatrali, forme e modi del passato. Tra gli innovatori più rappresentativi della seconda metà del secolo spiccano le figure di due critici letterari: il mantovano S. Bettinellii (1718-1808), le cui Lettere virgiliane riflettono l'insofferenza, fino al limite dell'iconoclastia, del razionalismo illuministico nei confronti delle regole e del principio d'imitazione, e il torinese G. Baretti (1719-1789), che compì un'efficace opera di demolizione nei riguardi della stanca tradizione accademica, rivelando nel contempo, con la scoperta di Cellini e la difesa di Shakespeare dalle accuse di Voltaire, un temperamento preromantico. All'interno della cultura illuministica si andava in effetti insinuando una diversa sensibilità, cui ha dato l'avvio la moda della poesia notturna e sepolcrale inglese, diffusa in Italia soprattutto dalla traduzione dei Canti di Ossian del padovano M. Cesarotti (1730-1808). Interprete del nuovo gusto preromantico per le atmosfere lugubri e spettrali, conciliato col tema neoclassico delle rovine, fu A. Verri (1741-1816), autore di un fortunato romanzo archeologico, Le notti romane, mentre un vagheggiamento dell'innocente natura, non privo di risonanze preromantiche rousseauiane, si esprime nella poesia in dialetto siciliano di G. Meli (1740-1815). A Rousseau si può anche ricondurre, per il suo proposito di confessione sincera, il maggiore avventuriero del Settecento, G. G. Casanova (1725-1798), che nei suoi Mémoires ci ha lasciato un ricco e saporoso documento del vitalismo erotico della società settecentesca. La medesima joie de vivre, nel quadro di una ben diversa concezione, che superava la dimensione edonistica per scoprire il valore sociale della città come centro di umana conversazione, anima i Mémoires di un “avventuriero onorato”, C. Goldoni (1707-1793). Ma il senso profondo di quell'autobiografia è nella storia di una missione, e cioè della riforma della Commedia dell'Arte: di questa Goldoni rifiutò i lazzi triviali e gli intrecci stravaganti, conservandone però la vivacità del dialogo, la comicità delle trovate, l'abilità della tecnica teatrale. Non in una novità tecnica, ma nell'attenzione al mondo contemporaneo va tuttavia ricercata l'originalità del teatro goldoniano: basti ricordare come il vizioso e libertino Pantalone della Commedia dell'Arte si trasformi, nelle commedie di Goldoni, nel mercante operoso, fiero della sua dirittura morale, in contrasto con la frivola e oziosa vita nobiliare. E, quando la crisi della società veneziana si consumò e si rivelò l'inettitudine della borghesia mercantile a divenire classe dirigente, l'analisi goldoniana, dopo avere indugiato affettuosamente sulla figura di una popolana nella deliziosa Locandiera, si trasferì all'interno del ceto borghese per mostrare, attraverso il motivo del contrasto generazionale tra vecchi e giovani, l'angustia soffocante della moralità arcigna e retriva dei “rusteghi”. Scosso nel suo fiducioso ottimismo, Goldoni cercò un'evasione nella rappresentazione del mondo popolare: videro così la luce Le baruffe chiozzotte. Anche sul piano linguistico, Goldoni ha operato una vera e propria rivoluzione, riscattando il dialetto dalla sua funzione subalterna ed elevandolo alla dignità della lingua. Più consapevole sul piano ideologico, rispetto all'“illuminismo popolare” di Goldoni, fu l'adesione di G. Parini (1729-1799) alla civiltà illuministica, tenuto conto anche della diversa situazione storica in cui egli si trovò ad agire, nell'ambiente di una Lombardia riformistica, di gran lunga più vivace della chiusa oligarchia veneziana. L'impegno militante caratterizzò tuttavia solo le prime Odi e le prime due parti del Giorno: quando il programma riformatore si esaurì e lampeggiarono i bagliori della Rivoluzione francese, prevalse in Parini un atteggiamento più meditativo e autobiografico, un desiderio di rifugio nell'ideale neoclassico come evasione in un mondo armonico, lontano dalle disarmonie della realtà; alla tagliente ironia del Mattino e del Mezzogiorno subentrò, nel Vespro e ancor più nella Notte, l'affresco della società nobiliare, mentre il linguaggio si disacerbava, attenuando le sue punte più aspre; parallelamente, nelle odi della maturità, emerse la grandezza morale del poeta, con la sua dedizione esclusiva alla Musa. In questa esemplare espressione del mito del poeta-vate, più che nella produzione esplicitamente illuministica, si deve ricercare la validità della poesia pariniana. Cronologicamente vissuto in piena civiltà illuministica, V. Alfieri (1749-1803) appartiene spiritualmente al secolo romantico. Nella sua opera viene meno l'equilibrio illuministico tra natura e ragione e si riscopre la forza inarrestabile della passione, attraverso un drammatico succedersi di contraddizioni. Contraddittorio è soprattutto l'atteggiamento di una mente che accetta le premesse antimetafisiche dell'illuminismo e di un cuore che rifiuta i limiti della natura umana, rivelati dalla ragione, e si rifugia nel mito del titanismo superumano. L'approdo della personalità alfieriana, scissa da questo drammatico conflitto, fu un estremo individualismo, antisociale e anarchico: la lotta dell'eroe contro il tiranno, tema dominante delle tragedie alfieriane, è in realtà la lotta dell'uomo che anela un'assoluta libertà della coscienza, e il problema politico si muta in un problema essenzialmente morale. In questa prospettiva nacquero i due capolavori di Alfieri: il Saul, in cui la figura del re biblico, invano anelante a oltrepassare il limite della realtà personificato dal tremendo dio ebraico, è alla fine travolta dalla follia e dalla morte; e la Mirra, in cui l'inanità della lotta dinanzi a un'orrenda passione accentua la componente pessimistica rispetto a quella titanica. Titanismo e pessimismo furono d'altronde le componenti stesse della febbrile esistenza di Alfieri, assillata dall'ansia della gloria e incupita da una profonda malinconia: i sentimenti che fanno di lui un “protoromantico”.
Letteratura: dal neoclassicismo al romanticismo
I primi quindici anni dell'Ottocento, coincidenti con l'età napoleonica, segnarono il trapasso dall'illuminismo alla nuova civiltà romantica e si identificarono, sul piano letterario, con le correnti del neoclassicismo e nel preromanticismo. Una sintesi di gusto neoclassico e di contenuti preromantici è offerta dall'opera del veronese I. Pindemonte (1753-1828), che, mentre nelle Poesie e prose campestri assunse l'atteggiamento di contemplatore solitario e malinconico, con la versione dell'Odissea fornì un dignitoso esempio di traduzione neoclassica. Ma il rappresentante più qualificato della corrente neoclassica fu V. Monti (1754-1828), per il quale la letteratura era il mondo esclusivo, in cui era possibile trovare un'evasione da una realtà incomprensibile, in mutamento vorticoso. Avvenne così che anche la materia di più scottante attualità si trasformasse per Monti in mito, da contemplare con ingenuo stupore: in tale prospettiva si colloca la splendida traduzione dell'Iliade, suprema espressione del sogno neoclassico. Altro esponente del neoclassicismo fu P. Giordani (1774-1848), stilista insigne e dittatore letterario del suo tempo. Più angusto fu il “purismo” di A. Cesari (1760-1828), che propose un anacronistico ritorno all'italiano del Trecento, e di minore rilievo sono le opere storiche di C. Botta (1766-1837) e di P. Colletta (1775-1831), nelle quali gli interessi stilistico-linguistici finiscono con il prevalere sulla ricerca storiografica. Il vero storico di quell'età, al di fuori del gusto neoclassico, fu V. Cuoco (1770-1823), la cui prosa asciutta e stringata è del tutto aliena da lenocini retorici. Le contraddizioni dell'età napoleonica si rispecchiano nella suggestiva personalità di U. Foscolo (1778-1827). A differenza di Monti, il mondo classico non è presente nell'opera foscoliana come un motivo ornamentale, ma è intimamente sentito come unico rifugio in seguito a un'alta meditazione sulle disarmonie della vita. La giovanile lacerazione tra ragione e passione, che portò Foscolo, nella fase dell'Ortis, a vagheggiare il suicidio, si placa in una nuova e più armoniosa concezione del reale, nella coscienza della validità delle “illusioni”, cioè nelle più alte idealità del vivere, celebrate con un fervore che può dirsi religioso. L'impetuosa passione di Foscolo si disacerba nelle Odi, nella contemplazione della bellezza e si trasfigura nei miti dolenti, ma sereni, dei sonetti maggiori, e alla malinconica aspirazione alla “fatal quiete” subentra, nei Sepolcri, l'opposta tensione dalla morte alla vita: consolato dalla bellezza e dall'amore, dall'eroismo e dalla pietà, l'uomo trova lo scopo dell'esistenza in una laica religiosità e sul pessimismo s'innalza la speranza di un'immortalità da conseguire con “egregie opere”. Nelle Grazie, infine, il poeta si solleva a un sovramondo luminoso, dove la sua fantasia mitica può liberamente spaziare, libera da cupezze passionali. Anche se l'educazione letteraria, profondamente classica, portò Foscolo ad avversare le posizioni della scuola romantica, la sua personalità irrequieta, il senso vichiano della storia, la nostalgia del passato eroico, lo legarono intimamente alla spiritualità romantica. Ormai chiara è, infatti, negli studi la distinzione tra un romanticismo come movimento, che condusse una ben precisa polemica letteraria e civile nella Milano dei primi anni della Restaurazione, e un romanticismo inteso come spiritualità, come modo di sentire la vita e concepire l'arte, che influenzò anche coloro che si professavano indifferenti o avversari della nuova scuola. Se dunque la storia del romanticismo italiano non può essere irrigidita entro una serie di schemi e di atteggiamenti codificati, si possono invece delineare nettamente le istanze che emersero dalla polemica classico-romantica. L'avvio a tale polemica fu dato dalla pubblicazione, sulla Biblioteca Italiana, dell'articolo di M.me de Staël Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. La lettera suscitò le vivaci proteste dei classicisti, che respinsero come inutile e dannosa la proposta di apertura alle letterature straniere. Le posizioni della Staël furono invece sostenute da L. Di Breme, da P. Borsieri, e soprattutto da G. Berchet (1783-1851), la cui Lettera semiseria di Grisostomo è il più noto manifesto della scuola romantica italiana. Alla vecchia letteratura tradizionalistica e accademica veniva contrapposta dai romantici una letteratura viva e popolare (di un popolo inteso come ceto medio), espressione della società, e pertanto libera dalle pastoie delle regole e dall'imitazione della mitologia. Si trattava di posizioni sostanzialmente moderate: il rinnovamento letterario non procedeva infatti, in Italia, di pari passo a un rinnovamento filosofico, come invece accadeva in Germania; mancò pertanto da noi una poesia che fosse inebriante avventura dello spirito e si assegnò alle lettere la funzione di formare ed educare le coscienze in vista di un fine civile, escludendo deliberatamente una più spregiudicata interpretazione del rapporto tra l'uomo e la società.
Letteratura: Manzoni e Leopardi
Di gran lunga superiore a quello dei romantici lombardi appare dunque il coraggio innovativo del loro caposcuola, A. Manzoni (1785-1873), sia in campo ideologico, sia nel campo più specifico dell'invenzione letteraria. La conversione al cattolicesimo non portò Manzoni a rinnegare l'educazione illuministica: egli, anzi, cercò di recuperare gli ideali di eguaglianza, libertà e giustizia all'interno della sua concezione religiosa, che era molto critica e polemica nei riguardi degli atteggiamenti religiosi ufficiali (basti pensare alla sua avversione al potere temporale dei papi). Ma fu soprattutto per il suo pessimismo che Manzoni si distinse dal progressismo ingenuo degli altri romantici: già nell'Adelchi la condizione dell'uomo è considerata nel drammatico rapporto con una legge sciagurata e brutale che s'identifica con la “ragion di Stato”, e, ne I promessi sposi, nonostante il “lieto fine”, prevale una rappresentazione degli aspetti negativi e oppressivi della società e della storia. Motivo principale del romanzo non è infatti l'ottimistica celebrazione della Provvidenza, ma la complessa rappresentazione dello stato di decadimento dell'uomo e dell'assenza di giustizia, considerata con radicale pessimismo, che, nella descrizione dei grandi flagelli, tocca punte apocalittiche e si riscatta soltanto nel rifiuto di ogni compromesso con il male e nell'affidamento totale a Dio. Anche G. Leopardi (1798-1837) mosse, come Manzoni, da un'educazione illuministica per svolgerla in senso romantico: ma il punto d'approdo, lungi dalla manzoniana sintesi di pessimismo religioso e liberalismo politico, è un lucido e disperato materialismo e pessimismo cosmico. Eppure, tale concezione pessimistica non è in contrasto con le esigenze progressiste implicite nella cultura di cui Leopardi si era nutrito: egli anzi conciliò originalmente progressismo e pessimismo, senza vanificare o attenuare né l'uno né l'altro termine. Dalla considerazione della propria infelicità individuale come inevitabile conseguenza della “delusione storica” per la sconfitta della Rivoluzione francese e dell'atmosfera stagnante dell'Italia al tempo della Restaurazione, si sviluppa, attraverso le note dello Zibaldone e le pagine fantastico-razionali delle Operette morali, la tesi più radicale dell'insanabile infelicità dell'uomo, dovuta alla natura matrigna. L'esperienza della deformità e della malattia venne trasformata da Leopardi in un “formidabile strumento conoscitivo” (Timpanaro), che gli consentì di rappresentare il rapporto uomo-natura in termini rigorosamente scientifici, escludendo ogni antropocentrismo e teleologismo. Il progressismo scientifico di Leopardi, risolvendosi in una lotta per liberare l'uomo dal pregiudizio, è intimamente connesso con il progressismo politico-sociale e il Leopardi della Ginestra rese esplicito questo nesso, sostenendo, contro i cattolici liberali, che non c'era libertà politica senza libertà dal dogma e facendo appello a una democratica solidarietà di tutti gli uomini nella lotta contro la natura. Il recupero dei più fecondi elementi dell'ideologia leopardiana, dovuto alla critica più recente, ha portato a una rilettura della poesia dei Canti in chiave eroica e agonistica e alla scoperta del valore drammatico degli stessi “idilli”, nei quali l'incanto della rievocazione favolosa della giovinezza è in continuo rapporto con la coscienza di un desolato presente, dominato dall'“arido vero”.
Letteratura: il Risorgimento
Manzoni e Leopardi sono gli scrittori italiani di statura europea che hanno espresso in modi diversi (l'uno risolvendo la poesia in forme oggettivo-realistiche, l'altro esaltando la qualità intima e soggettiva della lirica) le istanze più profonde del romanticismo: in una sfera più angusta e provinciale si svolse invece, in Italia, la letteratura romantica minore, condizionata sia dalla tradizione classicistica sia dalle arretrate strutture politico-sociali del Paese. Particolare rilievo acquista pertanto la letteratura politica, che di tale arretratezza acquista coscienza e propone di superarla sia richiamando la poesia alla sua funzione di “sacerdozio d'educazione” – è la posizione di G. Mazzini (1805-1872), che con foga enfatica e tribunizia si fece assertore di una laica “religione dell'umanità” – sia riprendendo l'idea nazionalistica del primato italiano e conciliandola con la religione tradizionale, come fece V. Gioberti (1801-1852), scrittore dotato di un'eloquenza fastosa, ma retorica e monotona. Alieno da ogni misticismo fu invece C. Cattaneo (1801-1869), lo scrittore politico che meglio resiste a una rilettura moderna: compenetrando le leggi rigide e nude della natura con l'operosità dell'intelletto umano, egli additò nella ricerca scientifica e nella ricerca storica le vie per realizzare il principio romantico dell'utilità sociale della cultura. In questa direzione si mosse C. Pisacane (1818-1857), che intuì la priorità dei fatti economico-sociali nella determinazione del comportamento umano ed elaborò una teoria rivoluzionaria fondata sul contributo determinante delle grandi masse contadine del Mezzogiorno. Parallelamente alla letteratura politica fiorirono le prose dei memorialisti, tra le quali spiccano alcuni piccoli capolavori: Le mie prigioni di S. Pellico (1789-1854), racconto del ritorno dell'autore alla fede religiosa attraverso le sofferenze del carcere; le Ricordanze della mia vita di L. Settembrini (1813-1876), ricche, nella loro programmatica semplicità, di colore popolaresco; I miei ricordi di M. D'azeglio (1798-1866), un libro suggestivo per la sua moralità bonaria e sorridente e per il felice gusto bozzettistico; in campo poetico, il nesso tra romanticismo e Risorgimento si tradusse nelle figure del poeta-soldato e del poeta-esule: G. Mameli, L. Mercantini, A. Poerio sono tra i più noti esponenti della poesia patriottica, che trovò la sua voce più robusta nel già ricordato G. Berchet, sensibile oltre tutto, sul piano linguistico, alla necessità di trovare forme più aderenti alla parlata popolare. Di questa esigenza, testimoniata dal fiorire delle ballate e delle novelle sentimentali in versi, si fece interprete G. Giusti (1809-1850), che con la satira pungente dei suoi Scherzi, pur limitati nell'angusta prospettiva della piccola provincia toscana, contribuì ad avvicinare la letteratura ai problemi concreti del vivere quotidiano. Ma l'esigenza realistica ebbe la sua più significativa espressione nella poesia dialettale di Porta e di Belli. C. Porta (1775-1821) affrontò in un milanese schietto e cordiale il tema degli umili e degli oppressi, curvi sotto il peso di una secolare soggezione, non arretrando dinanzi agli aspetti più turpi, ma dolorosamente umani, di una realtà che non aveva mai trovato espressione nei moduli illustri e solenni della nostra tradizione lirica; e alla pittura della misera realtà plebea contrappose gli splendidi affreschi del mondo nobiliare e clericale, mescolando umorismo e sarcasmo in una fondamentale unità d'ispirazione, sorretta da una robusta passione morale. Da un fondo più amaro, in connessione con un ambiente soffocante e retrivo come quello dello Stato pontificio, sorse la poesia in romanesco di G. G. Belli (1791-1863), che nell'anarchico desiderio di rompere le norme della società organizzata (in contrasto sconcertante con la sua stessa mentalità di uomo retrivo e amante dell'ordine) sfogò gli istinti repressi della sua natura, compiendo un audace sondaggio negli strati più oscuri della psiche. Ma sulla vena scurrile e profanatrice, sull'istintiva tendenza alla dissacrazione prevale la descrizione oggettiva del mondo squallido e disperato della plebe romana, rappresentata con un gelido furore che preannuncia la fine di un sistema ormai fradicio e putrefatto. Nel campo della narrativa, il genere tipico del romanticismo fu il romanzo storico, fiorito sulla scia dei modelli offerti da W. Scott e, dopo il 1827, dal grande modello manzoniano. Amico di Manzoni era T. Grossi (1790-1853), il cui Marco Visconti, con il suo Medioevo artificioso e il suo languido sentimentalismo, offre un prontuario dei temi cari ai romantici. Vibrante di amor patrio è l'atmosfera pittoresca dei romanzi di D'Azeglio, l'Ettore Fieramosca e il Niccolò de' Lapi, mentre dell'influsso di Byron e del romanticismo nordico hanno risentito i romanzi di F. D. Guerrazzi (1804-1873). Ma l'unica opera narrativa che esprime compiutamente l'epos risorgimentale sono le Confessioni di un italiano di I. Nievo (1831-1861), che tuttavia, al di là dello sfondo patriottico, offrono nella Pisana uno dei personaggi più convincenti della nostra letteratura. Il gusto del ritratto femminile caratterizza anche il romanzo Fede e bellezza di N. Tommaseo (1802-1874), spirito acuto e versatile, la cui produzione lirica e narrativa si svolse tra accensioni sensuali ed esaltazioni mistiche, costituendo il tramite storico tra romanticismo e decadentismo. La coscienza critica del romanticismo si riassume nella geniale opera di F. De Sanctis (1817-1883), che si svolge in due fondamentali direzioni: quella estetica, tendente a riconoscere l'autonomia dell'arte e a identificarla con la “forma”, unità organica in cui si concentra il mondo interiore dell'artista; e quella storicistica, secondo la quale l'opera letteraria rispecchia il momento storico che la esprime: e pertanto la sua Storia della letteratura italiana è anche una storia dell'intera civiltà italiana.
Letteratura: il verismo
Nel clima involutivo che caratterizzò la storia italiana dopo l'unità, quando gli entusiasmi risorgimentali si erano spenti nel grigiore della routine burocratica, la seconda generazione romantica si inserisce in una meccanica ripetizione di temi, rifugiandosi, con i versi di A. Aleardi (1812-1878) e di G. Prati (1814-1884) in un sentimentalismo stucchevole e lacrimoso e in un legittimismo sabaudo non privo di spunti antidemocratici. Un'affettuosa attenzione ai problemi delle classi subalterne si avverte invece negli “stornelli” popolari di F. Dall'Ongaro (1808-1873), nei racconti di ambiente contadino della friulana C. Percoto (1812-1887) e nella produzione in versi e in prosa del prete calabrese V. Padula (1819-1893). Altri manzoniani, invece, ricercano sul versante pedagogico un'identità nazionale: è il caso di E. De Amicis (1846-1908) che, nel Cuore, offrì un prontuario dei miti borghesi e dei tabù sociali dell'età umbertina, passando dal generico solidarismo dello scolaro Enrico a una precisa condanna delle posizioni contestatarie ante litteram dello scolaro Franti; e di C. Collodi (1826-1890) che, al contrario, nel suo Pinocchio, descrivendo la rottura di ogni legge e regola da parte del suo burattino, esprimeva la sua inconscia simpatia per l'indisciplina popolare, che la pedagogia della classe dominante cercava di tenere a freno. Ma la più consapevole ribellione ai miti e alle regole costituite del sistema sociale fu la scapigliatura, che ebbe il suo maggiore centro a Milano nel decennio 1860-70. La battaglia di rinnovamento degli scapigliati non si limitò all'impegno artistico, ma divenne un fatto di costume: stringendosi intorno all'affascinante personalità di G. Rovani (1818-1874), dalle cui memorabili bevute impararono molto più che dalle pagine del suo romanzo Cento anni, gli scapigliati tentarono di smantellare il mito del poeta quale sereno sacerdote della bellezza, per sostituirlo col nuovo mito, d'importazione francese, del “poeta maledetto”. Ma, nei versi di E. Praga (1839-1875), di A. Boito (1842-1918), di G. Camerana (1845-1905), il grande modello baudelairiano fu ripreso solo negli aspetti più facili e superficiali, lasciandone cadere l'ardua e severa lezione stilistica; ne derivò una morbosa compiacenza dell'orrido e del macabro, un gusto stravagante dell'allucinazione e del sogno, una celebrazione della vita sregolata, polemicamente contrapposta al filisteismo borghese: atteggiamenti che, pur introducendo nella nostra cultura la sensibilità decadente, rimangono velleitari sul piano dei concreti risultati artistici. Tuttavia, accanto alla componente decadentistica, c'è anche una componente realistica: nei migliori narratori scapigliati, da C. Boito (1836-1914) a I. U. Tarchetti (1841-1869) , da A. Cantoni (1841-1904) a G. Faldella (1846-1928) e soprattutto nel più estroso tra di essi, C. Dossi (1849-1910), l'unico che abbia raggiunto alti esiti di stile, si nota un'attenzione spregiudicata verso la realtà quotidiana nei suoi aspetti anche più dimessi e deformi, dalla quale presero le mosse gli scrittori veristi. In direzione assai diversa da quella degli scapigliati si mosse la reazione antiromantica di G. Carducci (1835-1907), che alla sensibilità morbida e femminea degli epigoni del romanticismo contrappose un ideale di sanità e di volontà virile; la nostalgia di una vita forte e serena si traduce, nei suoi versi migliori, in immagini di luce, in opulenza di colori, in una diffusa solarità cui si oppone il motivo “notturno” della morte, avvertita come fisica privazione del calore solare. L'alternativa carducciana di paesaggi luminosi e di malinconiche penombre non è tuttavia oscillazione tra serenità classica e tristezza romantica, ma è la manifestazione di una sensibilità tutta romantica, in rapporto diretto con la corrente realistica del romanticismo. Rimane però il fatto che gran parte della poesia carducciana, con la sua oratoria fragorosa e sonante e con il rilancio del mito del poeta-vate, contribuì a congelare la ricerca letteraria intorno all'ipotesi di un classicismo nazionalista, sviandola su posizioni ritardatarie e retoriche. Se Carducci, riproponendo il valore della tradizione e rifugiandosi nostalgicamente nel passato, evadeva dai complessi problemi dell'Italia unita, il verismo ebbe viceversa il merito di colmare in parte l'abisso tra classe colta e paese reale, scoprendo la concreta realtà dell'arretratezza e della miseria delle plebi contadine. I nostri veristi ebbero in comune con ilnaturalismo francese il canone dell'impersonalità dell'opera d'arte; mentre però i naturalisti francesi, rappresentando ambienti urbani e classi sociali più evolute, si sentivano interpreti di esigenze progressiste condivise dal pubblico dei loro lettori, i veristi italiani si trovavano del tutto isolati rispetto alle masse contadine, che non potevano recepire, nella loro desolata ignoranza, un messaggio a esse rivolto: nacque quell'atteggiamento condiscendente e paternalistico, anche se animato da una sincera pietà, con cui gli scrittori veristi si piegarono a contemplare la miseria delle classi subalterne. Esemplari, in questo senso, sono la personalità e l'opera di G. Verga (1840-1922). Dopo essersi trasformato, a contatto con gli scapigliati, da descrittore della società galante a suo critico impietoso, Verga ritornò idealmente alla sua Sicilia e iniziò a realizzare il ciclo dei “vinti”, scrivendo I Malavoglia: dominata dal senso tragico del dolore e della morte, l'opera ha una sua inconfondibile originalità nel panorama delle nostre lettere per la geniale tecnica del “discorso rivissuto”, per la prima volta applicata a un'intera narrazione; ma il pessimismo fatalistico che pervade il libro si spiega solo alla luce di una ideologia conservatrice, che induce lo scrittore a fare di Aci Trezza un microcosmo astorico, dove si vive secondo la necessità immobile della natura. L'abisso tra natura e storia appare colmato nel secondo capolavoro verghiano, il Mastro don Gesualdo, non nel senso che Verga abbia modificato il suo pessimismo, il quale anzi si è incupito, ma perché il passaggio da una società patriarcale a un più mosso contesto sociale consente allo scrittore di denunciare la degenerazione della società italiana uscita dalle lotte del Risorgimento. Una posizione polemica nei confronti della burocrazia accentratrice dell'Italia unita è implicita nel regionalismo degli altri scrittori veristi: da L. Capuana (1839-1915), nella cui produzione prevale una curiosità scientifica per il caso patologico, a F. De Roberto (1861-1927), che ne I Viceré descrive amaramente un mondo feudale in disfacimento; da M. Serao (1857-1927), che offre, nella sua migliore produzione, un mirabile “spaccato” della Napoli dei “bassi” e dei quartieri fatiscenti e brulicanti di un'umanità misera ma vivacissima, a S. Di Giacomo (1860-1934), che conferisce una misura lirica originale e un incanto misterioso e sottile ai tipici motivi dell'anima napoletana; da C. Pascarella (1858-1940), che mostra una particolare inclinazione per il bozzetto drammatico, a M. Pratesi (1842-1921), che compie una pensosa indagine sul mondo oppresso dei contadini e degli artigiani toscani. Quasi tutto d'imitazione francese è il dramma borghese della seconda metà del secolo, che ha il suo maggiore esponente in P. Ferrari (1822-1889). Solo alla fine del secolo, nel clima verista, il dramma riattinge con Verga un classico senso di fatalità e giunge con C. Bertolazzi (1870-1916) a una rappresentazione pungente e amara della società, e con G. Giacosa (1847-1906) si apre a note intime e crepuscolari. Tra scapigliatura e verismo si colloca E. De Marchi (1851-1901), che nel Demetrio Pianelli rispecchia il senso angoscioso di una vita operosa conclusa con la sconfitta, sullo sfondo di una Milano grigia e malinconica, priva di ideali; e tra verismo e decadentismo si iscrive l'arte di G. Deledda (1871-1936), che nella problematica del peccato e del rimorso complica la sua più genuina vena di evocatrice di una società arcaica e di chiuse passioni, formatesi a contatto con una natura aspra e solitaria.
Letteratura: il decadentismo
Negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento, il decadentismo europeo fece breccia nella letteratura italiana, malgrado le resistenze degli ambienti più provinciali e tradizionali; ma le prime esperienze decadentistiche, a causa della persistente arretratezza della nostra cultura, mantennero un carattere più angusto e retrivo rispetto alle analoghe esperienze di altre parti d'Europa. Un primo, significativo esempio di letteratura decadente è il romanzo Malombra di A. Fogazzaro (1842-1911); ma, in Piccolo mondo antico, Fogazzaro cerca nella memoria dei sani valori del passato la salvezza dal baratro dell'inquietudine novecentesca. Un diverso rifugio è quello che G. Pascoli (1855-1912) ricerca nel mondo dell'infanzia da cui era stato violentemente sbalzato dopo l'assassinio del padre. La poetica pascoliana del “fanciullino”, fondata sulla scoperta delle piccole cose della natura, attraverso le quali si perviene a un'intuizione mistica della realtà, è una poetica tipicamente decadente sotto apparenze provinciali e agresti; ma si tratta di un decadentismo più istintivo che consapevole, in contrasto con la formazione umanistica di Pascoli e con la sua tardoromantica voluttà di pianto, che vizia una parte della sua produzione, legata al tema della tragedia familiare. Ma fondamentale è l'apporto di Pascoli alla poesia del Novecento per il linguaggio nuovo, spezzato e frammentario, che liquida in modo definitivo il lessico aulico della tradizione lirica italiana, sostituendolo con un linguaggio dimesso e insieme allusivo, denso di simboli. Più clamorosa ma più superficiale fu l'esperienza decadente di G. D'Annunzio (1863-1938), che, identificando letteratura e vita, blandì la piccola borghesia, insoddisfatta della prosaica realtà dell'Italia giolittiana, con i miti dell'estetismo e del superuomo e si fece strenuo assertore dei principi nazionalistici e imperialistici della guerra e della violenza. Della sua vasta produzione si ricordano oggi soprattutto i miti di Alcyone, dove il sensualismo si fa immedesimazione panica con la natura e la parola si dissolve in una stupenda germinazione di immagini e suoni, e le prose autobiografiche della stagione “notturna”, caratterizzate da uno stile lucido e disincantato, di rarefatta purezza. In campo teatrale, D'Annunzio riporta sulla scena climi poetici e temi inconsueti. In opposizione al dannunzianesimo si esprimono intimisti e crepuscolari, e soprattutto quel teatro tra fantastico e simbolico che fu detto “grottesco” (L. Chiarelli, P. M. Rosso di San Secondo, L. Antonelli). La letteratura del Novecento risente, soprattutto nella sua prima parte, dell'impostazione extrarazionale data al fatto artistico dal decadentismo europeo. La poesia “crepuscolare”, che domina nei primi anni del secolo, porta alle conseguenze estreme motivi che già erano stati preannunciati dal Pascoli delle piccole cose e dal D'Annunzio del Poema paradisiaco. Caratteristica principale dei poeti crepuscolari è la fuga dall'aulicità e dalla retorica verso una patetica mediocrità e un'ostentata incapacità di grandi passioni, e il compiacimento per la realtà più frusta e quotidiana. S. Corazzini (1887-1907) è il rappresentante più caratteristico del movimento; la figura più rilevante è però quella di G. Gozzano (1883-1916), il primo protagonista della poesia del Novecento: l'originalità della sua ispirazione sta nella dialettica tra una nostalgia esotica e un'esigenza di rifugio in un mondo quieto e riposato, tra il senso dell'incombere del tempo e il desiderio di fissarlo nella “stampa”, nel vagheggiamento tenero e ironico del piccolo mondo dell'Ottocento. Ma il movimento che ebbe più vasta eco nel clima artistico del tempo fu quello del futurismo, che in F. T. Marinetti (1876-1944) ebbe il suo più tipico rappresentante. I temi fondamentali del movimento furono individuati da Marinetti nel culto per il coraggio e l'audacia, nell'ammirazione per la velocità, nella lotta contro il passato, nell'esaltazione della guerra, “sola igiene del mondo”. Ne derivava una poetica fondata sulle “parole in libertà”, sciolte da ogni legame con la punteggiatura e la sintassi, che davano vita alla scrittura analogica e all'“immaginazione senza fili”. Se nella liquidazione della sorpassata figura del letterato e nella lotta contro la museificazione dell'arte è da ricercare l'aspetto più innovatore del futurismo, la mancanza di un solido retroterra culturale ne compromette gli effetti e ne prepara l'involuzione fino all'adesione al fascismo e all'accettazione degli allori accademici.
Letteratura: il primo Novecento
Con Marinetti collaborarono scrittori toscani come G. Papini (1881-1956) e A. Soffici (1879-1964), che fondarono a Firenze la rivista Lacerba; ma la più importante rivista di cultura degli anni intorno alla prima guerra mondiale fu La Voce, fondata a Firenze nel 1908 da G. Prezzolini (1882-1982). Gli scrittori “vociani” si diversificavano tra gli “artisti”, come Papini e Soffici, che riducevano la nuova cultura a un problema di stile, ripiegando su posizioni accademiche e retoriche, e i “moralisti”, come C. Michelstaedter (1887-1910), G. Boine (1887-1917), S. Slataper (1888-1915), P. Jahier (1884-1966), che approdarono all'arte sotto lo stimolo di una profonda esigenza morale. Nel 1914 la direzione de La Voce fu assunta da G. De Robertis (1888-1963), che le impresse un carattere esclusivamente letterario; da allora, la rivista promosse il gusto del “frammento”, ponendo le basi della “poesia pura”. La più lucida coscienza critica del periodo vociano fu quella di R. Serra (1884-1915), la cui opera risente del contrasto tra la sua formazione umanistica e una sensibilità decadente. Se la critica si risolve per Serra in confessione lirica, essa è invece, in B. Croce (1866-1952), il riflesso di una salda posizione ideologica: rinnovatore della cultura italiana, che elevò a livello europeo, Croce si riallacciò, attraverso De Sanctis, allo storicismo di Vico, che interpretò immanentisticamente e idealisticamente. Movendo dalla definizione dell'arte come “intuizione lirica”, la critica letteraria deve, secondo Croce, limitarsi a precisare la caratteristica di natura psicologica di un'opera d'arte, distinguendo la poesia dalla non-poesia e le parti poetiche da quelle strutturali. Ma poiché il rapporto tra struttura e poesia si identifica con il rapporto tra storia e poesia, la critica crociana finisce per collocare l'espressione artistica su un piano astorico. Pervasa da un gusto fondamentalmente classicistico, l'estetica crociana incide poco nella letteratura contemporanea, in cui circola ormai pienamente la sensibilità decadente. Non a caso i due maggiori scrittori nei quali è più lucida la coscienza della crisi novecentesca, Pirandello e Svevo, passano inosservati dalla cultura di osservanza crociana. La narrativa di L. Pirandello (1867-1936) ruota attorno ai due ambienti che coincidono con le sue fondamentali esperienze autobiografiche: la Sicilia, osservata con occhio impassibile nelle sue strutture arretrate e nella sua atmosfera stagnante e immobile (si pensi al romanzo I vecchi e i giovani), e il mondo piccolo-borghese romano, visto, in molte delle Novelle per un anno, nella sua situazione di soffocante monotonia, da cui non si evade se non nella dimensione onirica o nella fuga assurda o impossibile. Un'epopea del piccolo borghese è il romanzo Il fu Mattia Pascal, storia di un tentativo fallito di vivere al di fuori dei pregiudizi e dei legami del proprio ceto sociale e delle regole codificate della società. L'angoscia dell'esistenza, il gioco tra finzione e realtà, la tragedia della follia, temi già presenti nella produzione narrativa, si sviluppano in tutta la loro lucidità ed evidenza nel teatro pirandelliano, che rinnova il linguaggio scenico e scardina dalle fondamenta l'edificio del teatro naturalista. I. Svevo (1861-1928) appare vicino, col suo angosciato problematismo, al relativismo di Pirandello. I protagonisti dei suoi primi romanzi sono degli inetti, che si rifugiano in una visione onirica dell'esistenza, rinunciando a lottare o ricercando nell'amore un'illusione alternativa a una precoce senilità. La frattura tra il mondo della coscienza e le forme della vita comune è al centro della Coscienza di Zeno, che segna la clamorosa liquidazione del mito dannunziano del superuomo e l'approdo a una disincantata saggezza, intravista nell'accettazione senza riserve della banalità della vita quotidiana. Al tragico relativismo di Pirandello si contrappone invece il teatro di U. Betti (1892-1953), autore spietato nel mettere a nudo le piaghe e gli istinti più torbidi dell'uomo e della società, ma nella cui opera torna a fermentare l'anelito a una purificazione e a un assoluto. Altri scrittori avvertirono la crisi morale e letteraria del Novecento: A. Panzini (1863-1939), che si avvicina ai crepuscolari per l'inquietudine oscillante tra nostalgia e ironia; A. Palazzeschi (1885-1974), che è passato dal crepuscolarismo al futurismo, ma in realtà è rimasto fedele a una sua originale vena bizzarra e fantastica e a un gusto provocatorio per il buffo e il deforme, e porta così a termine la liquidazione, iniziata dai crepuscolari, del sublime ottocentesco, da lui capovolto nel grottesco; F. Tozzi (1883-1920), i cui romanzi riprendono con ritardo e in una dimensione provinciale i motivi più cupamente fatalistici del naturalismo europeo.
Letteratura: il periodo tra le due guerre
Nel primo dopoguerra, abbastanza chiara è la linea di svolgimento della poesia. C. Govoni (1884-1965) continua antiche esperienze crepuscolari, svolgendole verso un tono più discorsivo, e, attraverso l'adesione al futurismo, approda a esiti surrealistici; alla lezione dei crepuscolari si ricollega anche C. Sbarbaro (1888-1967), che, proclamata la natura “desertica” del mondo, si rifugia in un'amara e disincantata contemplazione di se stesso. Più complessa, e direttamente ispirata alle esperienze dei simbolisti francesi, in particolare di Rimbaud, è la poesia di D. Campana (1885-1932), il cui orfismo si risolve in un'allucinata trasposizione della realtà nel sogno. Divisa tra l'ansia idealistica e religiosa e la ricerca formale è l'opera di C. Rebora (1885-1957), alla quale può essere avvicinata quella di A. Onofri (1885-1928), che introduce consapevolmente la tecnica dell'analogia. Tale tecnica è fondamentale nell'opera di G. Ungaretti (1888-1970), che si sforza di recuperare l'intima essenza della parola in versi di scabra e rarefatta liricità, dove si esprime la pena derivante da una solitudine senza rimedio. Mentre Ungaretti non sempre si sottrae al pericolo di accensioni troppo improvvise e quindi frammentistiche o all'opposto rischio (nella sua ultima produzione) di eccessive indulgenze all'eloquenza, ricca di maggiore coerenza appare l'opera di E. Montale (1896-1981), dotato di indole più riflessiva e assai meno incline ai compiacimenti letterari. Il paesaggio ligure, nella sua piagata fisicità, è contemplato da Montale con uno sguardo assorto e perplesso, volto a un'interpretazione metafisica della realtà e alla presa di coscienza del “male di vivere”, della vanità delle speranze dell'uomo e della sua condizione di prigioniero in un mondo ostile e indecifrabile; e anche quando tale concezione disperata della vita, nel passaggio dagli Ossi di seppia alle Occasioni, subisce qualche incrinatura e consente il recupero del passato attraverso la memoria, il tema fondamentale rimane quello di una lucida e disincantata tristezza. Dopo la raccolta La bufera, in cui il poeta professa la sua fede nell'opera pur disperata dell'uomo, l'ultima poesia montaliana si è aperta a una sentenziosità ironico-epigrammatica, nulla perdendo del suo malinconico realismo. Da Montale ha preso le mosse la poesia ermetica, affermatasi soprattutto negli anni tra il 1930 e il 1940 ed entrata in crisi con la seconda guerra mondiale: gli stessi suoi esponenti, come A. Gatto (1909-1976), M. Luzi (1914-2005), V. Sereni (1913-1983), L. Sinisgalli (1908-1981), S. Solmi (1899-1981), A. Parronchi (n. 1914), P. Bigongiari (1914-1997), G. Caproni (1912-1990) e soprattutto S. Quasimodo (1901-1968), hanno raggiunto i loro esiti migliori negli anni del secondo dopoguerra, quando un nuovo impegno umano e morale si è aggiunto alle conquiste tecniche della ricerca ermetica. Di Quasimodo, in particolare, vanno ricordate le varie stagioni poetiche, dalla prima produzione, caratterizzata dalla sensuale evocazione di una Sicilia mitica e primordiale, alla ricerca di valori storico-sociali come risposta alle angosce e alle speranze del secondo dopoguerra, fino a una nuova ricerca di interiorità come reazione alle delusioni della storia nelle ultime opere. Alquanto isolata è l'esperienza poetica di U. Saba (1883-1957), che giustamente è stato definito il lirico più umano del nostro tempo: formatosi nel composito clima culturale triestino, aperto alle suggestioni freudiane, Saba ha costantemente riproposto la poetica delle cose umili e semplici, nel quadro di un appassionato amore alla vita, pur nella piena consapevolezza del dolore che discende in lui da un “pessimismo semita”. Più complessa, rispetto alla poesia, è nel primo dopoguerra la linea di sviluppo della prosa. Un richiamo all'ordine viene rivolto dalla rivista La Ronda, i cui collaboratori, reagendo al neoromanticismo “vociano”, si propongono di restaurare la tradizione della prosa d'arte, promuovendo un ritorno ai classici e rivalutando l'importanza dello stile. Lo scrittore più rappresentativo de La Ronda è V. Cardarelli (1887-1959), la cui “prosa d'arte” deve la sua forza evocativa al taglio e al ritmo dei periodi; ma l'espressione forse più matura della prosa d'arte si ritrova in una serie di saggi e divagazioni letterarie di E. Cecchi (1884-1966), che si impongono per lo stile esemplare e raffinato, ricco di risonanze simboliche e magiche. Sul piano di una fantasia divagante e allusiva e di una bonaria cordialità si colloca l'opera di A. Baldini (1889-1962); e a una formazione rondista deve essere ricondotto anche R. Bacchelli (1891-1985), che tuttavia arricchisce la propria cultura letteraria di un profondo interesse ai problemi storici e sociali. Ben diverso dal rondista richiamo all'ordine è l'appello rivolto da P. Gobetti (1901-1926), dalle pagine delle sue riviste Energie nove e specialmente de La Rivoluzione liberale e de Il Baretti, per la difesa dei valori letterari contro la pretesa fascista di un'arte asservita al regime. Altre riviste importanti del periodo della dittatura fascista, aperte al confronto con la narrativa europea e americana, furono Solaria, fondata nel 1926 da A. Carocci (1904-1972) e costretta, nel 1936, a cessare le pubblicazioni dalla censura del regime, e Letteratura, che nel 1937 ne raccolse l'eredità, sotto la direzione di A. Bonsanti (1904-1984). Tra gli scrittori pienamente coinvolti con il fascismo sono da ricordare M. Bontempelli (1878-1960), che diede vita al novecentismo, allo scopo di trasferire in Italia le esperienze del surrealismo europeo, e si fece banditore del “realismo magico”, e C. Malaparte (1898-1957), che al cosmopolitismo di “stracittà” di Bontempelli contrappose la polemica nazionalistica e provinciale di “strapaese”. Altri scrittori, viceversa, si opposero alla cultura ufficiale del regime, rifacendosi da una parte alla lezione di Verga e, dall'altra, alla narrativa americana, da Faulkner a Hemingway. Una sfida ideologica all'ottimismo ufficiale della cultura fascista fu Gente in Aspromonte (1930) di C. Alvaro (1895-1956), che rappresentava una Calabria reale, con i suoi pastori, oppressi dalla miseria e dalla solitudine; e non meno provocatorio nei confronti della retorica fascista di un'Italia sana e virile fu il romanzo Gli indifferenti (1929) di A. Moravia (1907-1990), spietato atto d'accusa contro il cinismo di un ambiente piccolo-borghese. Più consapevole fu la letteratura di opposizione al regime di Vittorini e di Pavese. E. Vittorini (1908-1966) è stato uno dei protagonisti del rinnovamento della nostra letteratura più come organizzatore di cultura che come narratore. Il suo nome rimane legato soprattutto alla battaglia d'idee imperniata attraverso la rivista Il Politecnico a favore di una cultura attiva, non di “consolazione”: una ricerca che si ricollega, nella narrativa vittoriniana, alla scoperta dell'uomo che unisce a una primitiva integrità un'operosa energia. Molto diversa da quella di Vittorini è la personalità di C. Pavese (1908-1950), che, in Paesi tuoi e in alcune novelle, ha un suo modo tutto lirico e incalzante di misurarsi con una grigia e dura realtà quotidiana. Ma una forte spinta psicologica e morale porta Pavese, ben al di là del realismo, a filtrare la sua esperienza umana attraverso un'intensa riflessione sul mito e a rappresentare il contrasto tra l'infanzia e la maturità, tra la nostalgia della campagna e l'amara esperienza cittadina: un dissidio che tocca note struggenti ne La luna e i falò. Più appartata è l'esperienza letteraria di C. E. Gadda (1893-1973), che ha raggiunto eccezionali risultati artistici grazie al suo straordinario linguaggio, grottesco e irridente, caratterizzato dalla mescolanza dei dialetti con la lingua arcaica e scientifica, dalla sintassi intricata e dal gioco abbagliante delle metafore. Dalla rappresentazione della società italiana in putrefazione sotto il fascismo (Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana) alla ricerca di un'oscura nevrosi che giunge fino al delitto (La cognizione del dolore), Gadda ha riversato gli acidi corrosivi della sua furia contestatrice, inserendosi autorevolmente nella tradizione degli “irregolari” delle nostre lettere, da Pulci a Folengo, dai barocchi agli scapigliati.
Letteratura: il neorealismo
Il clima letterario degli anni successivi alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza fu caratterizzato da una profonda esigenza di partecipazione e di ricerca di un più stretto contatto con la realtà politico-sociale e con i sentimenti e i problemi delle masse popolari. Questa nuova tematica era stata sorprendentemente anticipata dall'opera di A. Gramsci (1891-1937): ponendosi il problema della funzione stessa dell'intellettuale, Gramsci, in polemica con il pensiero crociano e mettendo a profitto la lezione critica di De Sanctis, teorizzò la necessità di introdurre le classi subalterne nella vita nazionale e di fondare una cultura che fosse autenticamente nazionale e popolare. Si muovevano in tale direzione anche alcuni giovani scrittori, privilegiando la forma del romanzo: A. Greco, E. De Michelis, Moravia con il già ricordato Gli indifferenti e, soprattutto, C. Bernari (1909-1992) con l'opera Tre operai (1934), vero archetipo del romanzo neorealista. In questo retroterra ideologico, nella lezione del nuovo cinema, nell'influenza della letteratura americana contemporanea, nota attraverso l'opera di traduzione di Pavese e di Vittorini (la sua antologia Americana è del 1942) è da cercare il nucleo germinativo del neorealismo, sviluppatosi tra il 1945 (anno di pubblicazione di Uomini e no di Vittorini, salutato come il romanzo della Liberazione) e il 1955 e caratterizzato dall'affrancamento della lingua della prosa da quella della poesia e dalla scelta di soluzioni linguistiche che valorizzavano il dialetto e la lingua parlata. Sotto l'etichetta neorealistica si raccolsero autori e testi diversissimi tra loro: da R. Viganò (1900-1976) con L’Agnese va a morire (1949) a R. Bilenchi (1909-1989) con Conservatorio di Santa Teresa (1940), lirica rievocazione dei ricordi d'infanzia, a G. Berto (1914-1978) con Il cielo è rosso (1947); da D. Rea (1921-1994) con il barocco Spaccanapoli (1947), a I. Calvino (1923-1985) con il fiabesco Il sentiero dei nidi di ragno (1947). Ma i testi esemplari del neorealismo sono Cristo si è fermato a Eboli (1945) di C. Levi (1902-1975), rappresentazione del mondo contadino improntata al gusto dell'arcaico, Le terre del Sacramento (1950) di F. Jovine (1902-1950), un romanzo d'ispirazione gramsciana sulle lotte dei contadini molisani, e i primi romanzi di V. Pratolini (1913-1991), da Cronache di poveri amanti (1947), felice esempio di letteratura populista, a Metello (1955), che segna già la crisi del movimento. Nel quadro dell'esperienza neorealista conobbe grande fortuna anche la produzione più matura di A. Moravia (La romana e La ciociara, Racconti romani). Nell'ambito del realismo, per l'oggetto stesso della loro opera, possono essere annoverati gli scrittori che alimentarono la loro fantasia al tema della guerra e della Resistenza, sia in forma memorialistica (si cita per tutti il P. Levi di Se questo è un uomo, 1947) sia in forma narrativa (si ricorda soprattutto il B. Fenoglio de I ventitré giorni della città di Alba, 1952, vicino a Pavese per temi e movenze, ma di ispirazione più schiettamente contadina). Agli sviluppi del realismo sono legati anche scrittori cattolici, come L. Santucci (1918-1999) e M. Pomilio (1921-1990), e quelli nei quali predomina il gusto puro del racconto, come M. Soldati (1906-1999) e G. Arpino (1927-1987). Ma fu soprattutto la letteratura meridionale a presentarsi come il banco di prova del realismo: dalle più lontane opere di V. Brancati (1907-1954) che, con la satira del gallismo (Don Giovanni in Sicilia), ha lasciato un indimenticabile ritratto della provincia siciliana, e di I. Silone (1900-1978), che ha fatto protagonisti dei suoi primi romanzi i “cafoni” d'Abruzzo (Fontamara), alle prove successive di G. Marotta (1902-1963) e di L. Sciascia (1921-1989), che ha condotto una rigorosa analisi sui legami tra corruzione e potere. Un itinerario inverso a quello finora tracciato seguirono altri scrittori, accomunati da un senso di delusione della storia che li indusse a privilegiare la parola: spicca G. Tomasi di Lampedusa (1896-1957) con Il gattopardo (postumo, 1958); mentre fuga dalla storia e solitudine dell'uomo sono i temi costanti nella narrativa di G. Bassani (1916-2000) e di C. Cassola (1917-1987). La solitudine, venata da un profondo pessimismo cristiano, è anche il tema centrale del romanzo breve Casa d'altri (postumo, 1953) di S. D'Arzo (1920-1952), un autore poco fortunato ai suoi tempi ma ampiamente rivalutato negli ultimi decenni del Novecento, grazie anche a una produzione che spazia dalla prosa alla poesia, dal saggio alla letteratura per l'infanzia. Sul versante della critica letteraria le istanze crociane, sviluppate a opera di A. Momigliano (1883-1952) e F. Flora (1891-1962), si integrarono con lo storicismo di derivazione marxista e trovarono, pur con diverse prospettive, i propri portavoce in N. Sapegno (1901-1990), C. Muscetta (1912-2004) e C. Salinari (1919-1977).
Letteratura: la crisi del neorealismo e la neoavanguardia
A partire dalla metà degli anni Cinquanta, il neorealismo entrò in una fase di crisi irreversibile; le mutate condizioni socio-culturali del Paese rendevano inadeguate, agli occhi di moltissimi intellettuali, le soluzioni narrative praticate negli anni precedenti: cosicché l'uscita di un romanzo di impianto tradizionalmente realista, come il già citato Metello di Pratolini, innescò una polemica molto aspra. L'esigenza di un rinnovamento quasi universalmente avvertita diede luogo a proposte letterarie piuttosto diverse tra loro. Da un lato c'era chi, come gli intellettuali riuniti intorno alle riviste Officina (fondata da Leonetti, Pasolini e Roversi) e Il Menabò (fondata da Vittorini e Calvino), propugnava uno sperimentalismo che non rinnegasse le migliori esperienze precedenti. In questa direzione si mosse P. P. Pasolini (1922-1975) con la sua multiforme attività di poeta (La meglio gioventù), di narratore (Ragazzi di vita e Una vita violenta che hanno come protagonista il sottoproletariato romano di cui lo scrittore reinventa il linguaggio, misto di gergo e dialetto), di regista cinematografico e teatrale (Accattone, Affabulazione), di saggista (Scritti corsari, Lettere luterane). Dall'altro lato c'era chi rifiutava radicalmente gli indirizzi letterari del secondo dopoguerra, guardando alle forme più innovative di tutti i settori intellettuali (non solo artistici), ma contemporaneamente riallacciandosi alle avanguardie primonovecentesche: è la posizione sostenuta nelle pagine del Verri, rivista diretta dal critico e studioso di estetica L. Anceschi (1911-1995). La neoavanguardia diede vita al Gruppo 63, in cui confluirono scrittori di formazione e di temperamento diversi; tra i più importanti ricordiamo: G. Manganelli (1922-1990), A. Giuliani (n. 1924), F. Leonetti (n. 1924), L. Malerba (n. 1927), E. Pagliarani (n. 1927), A. Arbasino (n. 1930), U. Eco (n. 1932), N. Balestrini (n. 1935), A. Porta (1935-1989), E. Sanguineti (n. 1930), probabilmente la figura più rappresentativa del movimento, i cui esponenti, tuttavia, hanno in comune la preminenza data alla ricerca linguistica, la definizione dell'opera moderna come “opera aperta” (come recita il titolo di un fortunato libro di Eco del 1962), la contestazione dei valori codificati dalla società borghese, la ridefinizione del rapporto col lettore, il rifiuto dei consolidati meccanismi del consumo culturale. Molto più unito sui bersagli polemici che sulle proposte operative, il Gruppo 63 (la cui esperienza si è conclusa dopo l'esplosione della contestazione giovanile) ha dato risultati molto disuguali sul piano della resa artistica; tra le opere migliori vanno menzionate le poesie di Pagliarani (La ragazza Carla, Lezione di fisica) e Sanguineti (Triperuno, con il romanzo Capriccio italiano), le prose di Manganelli (Hilarotragoedia, Nuovo commento), in cui spesso si fondono istanze narrative e trattatistiche, legate in una visione del mondo radicalmente nichilistica, e le opere narrative di Malerba (La scoperta dell’alfabeto, Il serpente, Salto mortale), autore che si è cimentato negli anni anche in generi più tradizionali (come il romanzo storico), pur mantenendo sempre una forte tensione sperimentale. Punti di contatto con la neoavanguardia, almeno a livello formale, hanno le poesie di A. Zanzotto (n. 1921), che anzi in alcune raccolte (IX Ecloghe, La beltà) raggiunge esiti di oltranza espressiva paragonabili a quelli delle opere giovanili di Sanguineti; il poeta ha saggiato poi soluzioni anche molto diverse, ma sempre prestando una grande attenzione ai problemi del linguaggio. Anche il narratore G. Pontiggia (1934-2003) ha attraversato negli anni Sessanta una fase sperimentale, che però ha lasciato presto il campo a intrecci romanzeschi più tradizionali, nelle cui pieghe trovano volentieri luogo istanze ironiche e gnomiche, per approdare al termine di una lunghissima attività letteraria, col fortunato Nati due volte (2000), a un documento di vita vissuta (vi si rappresentano le difficoltà di un rapporto con un figlio disabile).
Letteratura: oltre la neoavanguardia
Le esigenze di rinnovamento espresse dal Gruppo 63 furono fatte proprie anche da narratori difficilmente ascrivibili a un gruppo o un movimento. È il caso dei surrealisti D. Buzzati (1906-1972) e T. Landolfi (1908-1979), di A. M. Ortese (1914-1998), sempre in bilico tra realismo e simbolismo e, in particolare, di Calvino (il narratore italiano del dopoguerra più letto e studiato in tutto il mondo), che inaugurò con Le cosmicomiche (1965) una lunga fase di sperimentazione sulle forme narrative che lo ha portato a dar vita a una scrittura “combinatoria” con forti punti di contatto con coeve esperienze francesi (Ti con zero, Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Palomar). Di tono surrealista può considerarsi anche la produzione di G. Rodari (1920-1980), autore di libri per l'infanzia, rinnovatore della fiaba tradizionale calata nella concreta realtà della vita contemporanea: le sue filastrocche e le sue storielle, senza mai perdere il fine pedagogico, sono percorse da una vena di intelligente comicità esegnate da un'evidente e marcata contrapposizione tra il mondo infantile e quello degli adulti. Fortemente critico con il Gruppo 63 fu F. Fortini (1917-1994), poeta e saggista, punto di riferimento per generazioni di giovani di sinistra. Fortini rifiuta il concetto stesso di avanguardia, a cui oppone una visione classica della cultura non disgiunta da una forte tensione etica; gli sviluppi più interessanti della sua attività letteraria si hanno non tanto nella scrittura poetica quanto in quella saggistica, a partire dalla celebre raccolta Verifica dei poteri (1965). Anche tra i poeti che esordirono negli anni Sessanta, alcuni rimasero sempre estranei a qualsiasi corrente. Una figura particolarmente interessante è quella di A. Rosselli (1930-1996), la cui poesia appare legata a esperienze inglesi e francesi più che alla tradizione italiana; nelle sue raccolte (tra cui si ricordano Variazioni belliche e Serie ospedaliera) una violenta deformazione linguistica è posta al servizio della rappresentazione della nevrosi. Nessuna sperimentazione nel linguaggio si rintraccia, invece, nella poesia di G. Giudici (n. 1924), che può ricordare per certi aspetti quella di Saba, ma anche di Gozzano, da cui l'autore riprende il tipico atteggiamento autoironico. Molti critici rintracciano l'esistenza di una rinnovata “linea lombarda”, caratterizzata dalla forte aderenza alla realtà concreta e dal rifiuto di ogni tentazione lirica, a cui apparterrebbero poeti, peraltro molto diversi tra loro, come G. Orelli (n. 1921), L. Erba (n. 1922), G. Majorino (n. 1928), T. Rossi (n. 1935) e G. Raboni (1932-2004), molto noto anche nelle vesti di critico e di traduttore. Prese forma, in questi anni, anche un nuovo filone letterario, quello della “letteratura industriale”, che, legato al boom economico e alla trasformazione dell'Italia in Paese industriale, si è proposto la rappresentazione in sede artistica del fenomeno dell'alienazione, estesosi dal mondo della fabbica a quello del vivere quotidiano. Tra i maggiori esponenti vanno annoverati O. Ottieri (1924-2002), G. Testori (1923-1993), L. Mastronardi (1930-1979) e, soprattutto, P. Volponi (1924-1994) che con il suo Memoriale ha raggiunto i risultati più persuasivi. In questi anni la diffusione nella cultura italiana dello strutturalismo, che trovò un terreno fertile nel formalismo russo e nella stilcritica, il cui massimo esponente era G. Contini (1912-1990), aprì una stagione critica fecondissima che si protrasse sino agli inizi degli anni Ottanta e diede luogo alla cosiddetta corrente strutturalistico-semiologica, rappresentata in particolare da M. Corti (1915-2002), G. Debenedetti (1901-1967) e C. Segre (n. 1928).
Letteratura: il variegato panorama degli anni Settanta
Il senso di incertezza e di disorientamento causato dai violenti cambiamenti in atto nella società e nella cultura ha provocato negli anni Settanta la totale mancanza di linee o correnti in cui gli autori potessero riconoscersi: si è affermata piuttosto la tendenza a una disponibilità individuale e a una più vasta libertà di scelta, ciò che rende arduo anche a distanza di decenni ogni tentativo di storicizzazione. Nel campo della narrativa si registra il fenomeno del ritorno al romanzo di largo respiro – è il caso de La storia di E. Morante (1918-1985), libro di straordinario successo – che risponde all'esigenza di rivalutare il “messaggio” o il “contenuto” dell'opera letteraria. In una direzione pressoché opposta si è avuta un'altra reazione al rifiuto dei significati tipico delle neoavanguardie, che ha dato luogo all'accentuazione della violenza contenutistica, accompagnata da una totale indifferenza per la “forma” e per la stessa grammatica: è nata così la cosiddetta “letteratura selvaggia”, che, sulla scia del romanzo Vogliamo tutto di un ex esponente del Gruppo 63, N. Balestrini, ha rilanciato la tematica operaia. Il disprezzo per le convenzioni linguistiche è esibito anche da G. Celati (n. 1937), il cui stile, che tende a riprodurre un parlato informale caratterizzato da continue violazioni sintattiche, è perfettamente funzionale alla rappresentazione dei personaggi alienati che affollano i suoi primi romanzi. Inversamente, in Padre padrone (1975) di G. Ledda (n. 1938) viene celebrata la conquista del linguaggio e della cultura da parte degli strati emarginati. Il libro dell'ex pastore sardo divenuto scrittore ha costituito un clamoroso caso letterario; negli stessi anni si ebbe un altro caso notevole (ma stavolta con esito tragico), quello del romanziere G. Morselli (1912-1973), morto suicida, i cui testi (tra cui si ricorderà almeno il romanzo Il comunista, 1976), sistematicamente rifiutati dalle case editrici, sono stati pubblicati postumi raccogliendo la convinta adesione della critica. Nel 1975 uscì, accompagnato da un forte battage pubblicitario, il monumentale romanzo Horcynus Orca di S. D'Arrigo (1919-1992), a cui l'autore aveva lavorato per un ventennio, sostenuto da Vittorini e dall'editore Mondadori. Il testo, che si richiama espressamente all'Odissea, mette in scena vicende di pescatori sottoposte a una trasfigurazione mitica; il tutto in uno stile sperimentale che trova la sua cifra nell'uso di un esasperato plurilinguismo. Il confronto con la tradizione linguistica italiana è alla base della scrittura coltissima di un altro siciliano, V. Consolo (n. 1933), che si è imposto all'attenzione con il romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, in cui la tensione espressionistica si rivela strumento adeguato per indagare senza reticenze nelle pieghe più violente e sordide della storia; caratteristiche, queste, che si ritrovano in tutti i suoi libri successivi (tra cui particolarmente significativi sono Retablo e Nottetempo, casa per casa). Spesso accostata a quella di Consolo è la figura di un altro siciliano, G. Bufalino (1920-1996), rivelatosi tardivamente col romanzo Diceria dell’untore (1981); anche Bufalino si serve di un impasto linguistico molto ricco (le cui soluzioni possono ricordare certa prosa d'arte), utilizzato però per costruire una narrativa esistenziale, non priva di slanci lirici. Forti interessi linguistici si rintracciano anche nei romanzi di L. Meneghello (n. 1922), che aveva esordito nel 1963 con l'interessante Libera nos a malo, in cui anzi si può dire che il linguaggio è il protagonista stesso della narrazione.
Letteratura: la spettacolarizzazione della poesia
Alla fine degli anni Settanta si è assistito a una vera e propria esplosione dell'attività poetica in Italia, anche se va detto che nella straordinaria quantità di opere in versi si stenta molto a trovare testi qualitativamente validi. Non sembra giovare alla poesia la marcata spettacolarizzazione attraverso la quale si è voluto rispondere a un bisogno di letteratura più diffuso che in passato nella società. Il fiorire di iniziative come le letture pubbliche e i festival (alcuni dei quali, come quello di Castelporziano del 1979, molto seguiti), se da un lato ha avuto il merito di avvicinare un gran numero di persone, soprattutto giovani, alla poesia, dall'altro ha contribuito pesantemente a ridurre la fruizione poetica, svincolata da qualsiasi reale strategia conoscitiva, a un passatempo come tanti altri. Negli effimeri riti celebrati per un certo periodo con grande frequenza, il poeta ha finito con l'essere niente di più di un intrattenitore, perfettamente inserito nella società dello spettacolo; sono molti, d'altronde, gli scrittori che in questi anni hanno assunto atteggiamenti istrionici o comunque di vuota esibizione di sé. Gli stessi atteggiamenti, peraltro, hanno caratterizzato paradossalmente anche alcuni poeti che sembrerebbero porsi agli antipodi da qualsiasi concessione alla poesia “di massa”, convinti come sono del valore arcano e magico della scrittura, capace di recuperare miti senza tempo e di sottrarsi alla contingenza storica. Di questa linea “neo-orfica”, che trova una sorta di manifesto nell'antologia La parola innamorata (1978), curata da G. Pontiggia ed E. Di Mauro, fanno parte autori come M. De Angelis (n. 1951), R. Mussapi (n. 1952) e G. Conte (n. 1945), la cui raccolta L’oceano e il ragazzo costituisce forse l'esito più conseguente. Tra i poeti affermatisi in questi anni si devono ricordare anche: V. Zeichen (n. 1938), che ha saputo confrontarsi in modo spesso ironico con le forme della comunicazione di massa; G. Manacorda (n. 1941), che ha affiancato da subito alla sua scrittura poetica un'intensa attività saggistica; D. Bellezza (1944-1996), fortemente influenzato dagli scritti e dalla personalità di Pasolini; M. Cucchi (n. 1945), approdato presto a una sorta di neocrepuscolarismo, privo però di qualsiasi ironia. L'autore forse più interessante tra quanti hanno mosso i primi passi negli anni Settanta è V. Magrelli (n. 1957), che ha saputo dar vita, sin dalla prima raccolta (Ora serrata retinae, 1980), a forme poetiche assai originali, in cui emerge una nitida tendenza riflessiva. Negli stessi anni si assiste anche a una forte ripresa della poesia dialettale (che comunque non aveva mai cessato di esistere); tra le figure più importanti ricordiamo almeno il milanese d'adozione F. Loi (n. 1930), il friulano A. Giacomini (n. 1939), l'anconetano F. Scataglini (1930-1994). Un maggiore interesse circonda anche poeti dialettali già attivi da tempo, come il siciliano I. Buttitta (1899-1997), i romagnoli T. Guerra (n. 1920), R. Baldini (1924-2005), il veneto E. Calzavara (1907-2000) e soprattutto A. Pierro (1916-1995), che adotta il dialetto della natia Tursi (in Basilicata), uno dei più conservativi d'Italia, totalmente privo di una tradizione letteraria, per registrare senza alcuna tentazione idillica la voce di un mondo contadino ormai sulla via di scomparire; l'opera di Pierro, più volte candidato al premio Nobel, ha conosciuto una quantità di studi inusitata per un poeta dialettale. Da segnalare inoltre che con un dialetto (quello veneto della natia Pieve di Soligo, per l'esattezza) si è cimentato anche Zanzotto.
Letteratura: gli anni Ottanta e il rilancio della narrativa
Dall'inizio degli anni Ottanta nel campo della narrativa, che negli anni precedenti non aveva visto quasi esordire scrittori di rilievo, si sono imposti all'attenzione molti nuovi autori. Prima di menzionarne alcuni, però, è necessario parlare del romanzo Il nome della rosa (1980) di U. Eco, già molto noto per i suoi studi di estetica e di semiotica e per brillanti interventi su vari aspetti della cultura contemporanea. Nel libro, che ha conosciuto un eccezionale successo mondiale, l'autore ha saputo fondere con innegabile abilità elementi propri di generi testuali differenti (dal giallo al trattato filosofico, dal romanzo storico alla parodia), dando vita a un pastiche in grado di soddisfare tipi diversi di lettori. Il narratore che meglio sembra riflettere il clima culturale degli anni Ottanta è P. V. Tondelli (1955-1991), nei cui romanzi, a partire dal fortunato Altri libertini (1980), trova luogo una rappresentazione quasi picaresca di un mondo giovanile ormai privo di ideali sociali o politici e proiettato verso forme di individualismo consumista, in uno stile che vuole distaccarsi nettamente da ogni tradizione e che si giova di frequenti tentativi di riproduzione del linguaggio parlato; di Tondelli va anche ricordato l'impegno profuso come talent scout. Alcuni punti di contatto con Tondelli si rintracciano nell'opera di A. Busi (n. 1948), scrittore assai abile nelle strategie di autopromozione, la cui narrativa però appare molto più convenzionale di quanto la sua figura pubblica non farebbe supporre. Legati in diverso modo al magistero di Calvino appaiono A. De Carlo (n. 1952) e D. Del Giudice (n. 1949), che hanno avuto un interessante esordio, rispettivamente con Treno di panna e Lo stadio di Wimbledon. Nel 1984, col romanzo Notturno indiano, si è rivelato al grande pubblico A. Tabucchi (n. 1943), già attivo nel campo della narrativa e noto soprattutto come esperto di letteratura portoghese; ma il grande successo è arrivato con Sostiene Pereira (1994), storia di un oscuro giornalista nel Portogallo della dittatura di Salazar. Si può citare qui anche un altro studioso di letterature straniere, C. Magris (n. 1939), che dopo una lunga e apprezzata attività saggistica si è fatto conoscere dal grande pubblico con Danubio (1986); non si tratta di narrativa in senso stretto, ma la fruizione che i lettori fanno di questo libro singolare, in cui si fondono efficacemente generi testuali diversi, assomiglia a quella di un romanzo. Assai interessante è Il poema dei lunatici, il primo libro di E. Cavazzoni (n. 1947), da cui F. Fellini ha tratto il film La voce della luna: le comiche avventure di personaggi marginali descritte da Cavazzoni si inseriscono a pieno titolo nella linea narrativa aperta da Malerba e Celati. Un caso a sé è quello di S. Vassalli (n. 1941), che dopo aver attraversato una lunga fase avanguardistica, poi decisamente rinnegata, è giunto al successo con un romanzo storico di impianto tradizionale (La chimera, 1990), primo di una serie di fortunati volumi. Altri scrittori che hanno esordito, o hanno trovato la notorietà, negli anni Ottanta, sono F. Sanvitale (n. 1928), S. Mannuzzu (n. 1930), R. Loy (n. 1931), G. Rugarli (n. 1932), F. Tomizza (1935-1999), D. Maraini (n. 1936), G. Pressburger (n. 1937), N. Orengo (n. 1944), G. Montefoschi (n. 1946), R. Nigro (n. 1947), E. Rasy (n. 1947), G. Van Straten (n. 1955), E. Albinati (n. 1956), L. Doninelli (n. 1956), M. Lodoli (n. 1956), S. Veronesi (n. 1959), P. Capriolo (n. 1962). Il decennio, qualitativamente tutt'altro che memorabile, trova in chiusura un capolavoro in Le mosche del capitale (1989) del già citato Volponi, un romanzo allegorico che offre una visione disincantata, ma allo stesso tempo non priva di tratti visionari, del potere economico; nella vicenda del protagonista, che cerca invano di introdurre elementi di moderna razionalità nella logica aziendale, è adombrata la sconfitta di un modello capitalistico alternativo (il richiamo all'esperienza di Olivetti è trasparente).
Letteratura: i difficili rapporti tra libro, industria editoriale e nuovi linguaggi
Lungo l'arco degli anni Novanta la produzione letteraria ha continuato a manifestare i segni di un processo involutivo in parte legato allo sviluppo complessivo della società italiana. Lo stato di crisi è dipeso in primo luogo dalla crescente concorrenza che i linguaggi visivi e tecnologici (tra cui un peso sempre maggiore ha assunto Internet) esercitano nei confronti del tradizionale messaggio scritto. La progressiva emarginazione del libro in quanto tale ha esasperato d'altra parte le strategie puramente finanziarie dell'industria editoriale, che ha mostrato un crescente bisogno di “casi” più o meno clamorosi, da contrapporre, in termini di consenso di massa, ai ben più facili successi che si sono aperti alle forme di comunicazione alternative. Da un lato si è assistito così, in campo letterario, a una sostanziale povertà d'idee e di proposte, alla mancata nascita di scuole, gruppi, programmi e in generale di movimenti consapevoli e organizzati. Dall'altro i promotori dell'editoria libraria si sono sforzati in ogni modo di inventare tendenze ed etichette capaci di rilanciare, almeno a breve termine, l'interesse di lettori sempre più svogliati e distratti. Il più vistoso di tali espedienti è stata la caccia disperata al “giovane scrittore”: mai come in questo periodo sono stati corteggiati e imposti con ogni mezzo all'attenzione del pubblico autori rigorosamente under 25, probabilmente considerati i più adatti a cogliere le nuove aspirazioni di una società avanzata, a confrontare e a mescolare il linguaggio specifico della letteratura con quelli provenienti dai settori multimediali ormai dominanti. Dal punto di vista delle vendite, l'esperimento più riuscito del ricorso agli esordienti giovanissimi è stato il libro-rivelazione di E. Brizzi (n. 1974), Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1994), da cui è stato anche tratto un film. Un altro evento fondamentale in tal senso è stata l'uscita dell'antologia provocatoriamente intitolata Gioventù cannibale (1996): accompagnato da un vivace dibattito giornalistico, il volume riunisce un articolato campionario delle varie tendenze giovanili di tipo pulp, cyber e splatter; ma in realtà il movimento che si è voluto creare intorno all'antologia si è rivelato essere una pura operazione commerciale. Va a ogni modo notata la presenza in essa di alcuni tra gli autori più interessanti della nuova generazione, i cui testi si possono però solo con grandi forzature rubricare come “cannibali”: si pensi soprattutto a T. Scarpa (n. 1963), N. Ammaniti (n. 1966), A. Nove (n. 1967), I. Santacroce (n. 1967), S. Ballestra (n. 1969). Su un versante diametralmente opposto, di una narrativa che celebra i buoni sentimenti, non senza tentazioni misticheggianti, si attesta S. Tamaro (n. 1957), il cui libro più famoso, Va’ dove ti porta il cuore, ha costituito il maggiore successo del decennio (e anche la trasposizione cinematografica ha avuto una certa fortuna). Scrittore molto amato dal pubblico (forse anche per le sue doti di affabulatore televisivo) è pure A. Baricco (n. 1958). Tra i narratori che negli anni Novanta e oltre hanno avuto un seguito di pubblico più o meno grande si possono ricordare anche C. Covito (n. 1948), M. Maggiani (n. 1951), P. Mastrocola (n. 1956), D. Voltolini (n. 1959), M. Mazzantini (n. 1961), P. Nori (n. 1963), G. Culicchia (n. 1965), M. Mazzucco (n. 1966). Particolarmente interessante appare la figura di M. Mari (n. 1955), forse l'unico tra gli scrittori che hanno esordito negli ultimi decenni a essere capace di confrontarsi con le risorse linguistiche della tradizione letteraria, come si nota in ognuno dei suoi numerosi libri (tra cui si ricorderà almeno La stiva e l’abisso). Nell'ambito della narrativa di successo, un cenno particolare va fatto al genere giallo e poliziesco, che vanta ormai in Italia una nutrita schiera di cultori, senza peraltro dimenticare precursori come G. Scerbanenco (1911-1969) e soprattutto la coppia Fruttero & Lucentini, autori di libri di grandissimo successo come La donna della domenica, che ha anche conosciuto una trasposizione cinematografica: specialisti come L. Macchiavelli (n. 1934) e R. Olivieri (n. 1925), per esempio, imbastiscono da parecchi anni le loro trame su un livello di più che decorosa dignità letteraria e i loro personaggi non sembrano fare invidia ai più celebri detective internazionali d'invenzione. La figura di gran lunga più nota d'investigatore è quella del commissario Montalbano, protagonista di una serie di romanzi e racconti di A. Camilleri (n. 1925), da cui sono stati ricavati parecchi sceneggiati televisivi seguiti da milioni di telespettatori. Sul valore letterario dei libri di Camilleri (peraltro autore anche di alcuni romanzi storici, che costituiscono forse il meglio della sua produzione) la critica è stata tutt'altro che concorde; viceversa, il pubblico ha decretato immancabilmente il successo di ogni nuova uscita del prolifico scrittore siciliano. Se la narrativa ha tentato diverse soluzioni per reagire allo stato di crisi generale della letteratura inventiva – si veda il caso letterario che ha avuto come protagonista la teen-ager Melissa P. con il suo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire (2003) – la poesia sembra mantenere una sua distaccata e imperturbabile indifferenza alle ragioni del mercato. Anzi, forse proprio la cronica debolezza commerciale del loro prodotto consente agli odierni poeti di coltivare in forma disinteressata e approfondita la scrittura in versi. Quindi, nei limiti di un interesse specialistico o di una passione amatoriale, peraltro incredibilmente diffusa, l'eletto esercizio della composizione poetica resta vitale e a suo modo ricco di prospettive, anche se, nella miriade di poeti che affollano il panorama editoriale si stenta a rintracciare un nome che spicchi nettamente sugli altri. Non va dimenticata, però, la stima di cui continuano a godere riconosciuti maestri del secondo Novecento lirico come Luzi, Giudici o Zanzotto. Nel panorama frammentario e piuttosto confuso della storia letteraria degli ultimi anni resta da fare qualche cenno agli orientamenti della critica, a sua volta spiazzata e spesso fuorviata dalle contraddizioni della scrittura "creativa". Tuttavia, fra tante tentazioni di cedimento, di superficialità e di opportunismo, è faticosamente emersa una tendenza positiva, di richiamo al rigore speculativo e metodologico. Gli eredi delle teorie che avevano dominato il dibattito speculativo nei primi decenni del secondo Novecento, ossia marxismo e strutturalismo, hanno colto lo spunto per riesaminare a fondo le proprie posizioni. Non è mancato neppure qualche critico che, come M. Onofri (Ingrati maestri, 1995), auspica addirittura un ritorno alla chiarezza della lezione crociana. In ogni caso una discussione così ampia e articolata ha contribuito a sgombrare il campo da antichi pregiudizi e faziose incomprensioni, favorendo un più libero e meditato accesso all'oggetto d'indagine. In conclusione sembrano essersi create condizioni favorevoli per recepire l'autorevole invito rivolto con spirito profetico da C. Segre nel volume Notizie dalla crisi. Dove va la critica letteraria (1994): l'analisi testuale e la conoscenza storica sono oggi più che mai strumenti essenziali per un'analisi critica che, rinunciando a ogni velleità "istintuale" e soggettiva, voglia afferrare il nocciolo del suo problema specifico.
Archeologia: generalità
A partire dagli anni Sessanta del Novecento l'archeologia ha subito una vera e propria trasformazione: ha perduto il suo rapporto privilegiato con la storia dell'arte antica e si è trasformata in una disciplina pienamente storica, questo grazie anche al prezioso contributo dell'archeologo italiano S. Moscati. I reperti rinvenuti dagli archeologi, infatti, sono ritenuti oggi tasselli indispensabili nella ricostruzione della storia di un popolo dell'antichità. Allo stesso modo è possibile tracciare un sintetico quadro storico della penisola italiana partendo proprio da una base archeologica. Il panorama della penisola italiana prima della piena romanizzazione, avvenuta alla fine del sec. I a. C., si presentava estremamente variegato: gruppi etnici distinti per lingua, cultura e strutture sociali occupavano il territorio italiano aperto alle influenze che venivano dal Vicino Oriente, dalla Grecia e dall'Europa centrale. L'assetto istituzionale dato alla penisola dall'imperatore Augusto e articolato su undici regioni riesce a dare un'idea della complessità della situazione ricalcando nelle denominazioni i nomi geografici ed etnici tradizionali: I. Latium et Campania; II. Apulia, Calabria, Sallentini et Hirpini; III. Lucania et Bruttii; IV. Sabini et Samnium; V. Picenum; VI. Umbria; VII. Etruria; VIII. Aemilia (Gallia Cispadana); IX. Liguria; X. Venetia et Histria; XI. Gallia Transpadana. Il millennio che precede la romanizzazione ha visto vicende, attestate anche archeologicamente, di straordinario interesse e importanza: la formazione, innanzitutto, delle diverse culture, alla quale contribuirono elementi indigeni, ma anche apporti di gruppi allogeni detentori di un sapere tecnologico superiore. È il caso, per esempio, della civiltà etrusca – la più sviluppata nel quadro della penisola italiana –, al processo formativo della quale contribuirono con sicurezza elementi orientali. Altro evento di grande portata e in grado di condizionare a lungo e in profondità le culture della penisola fu la colonizzazione greca che, iniziata, poco prima della metà dell'VIII sec. a. C. con un insediamento sull'isola di Ischia, interessò in maniera diretta gran parte delle coste dell'Italia meridionale sul versante tirrenico, ionico e adriatico e la Sicilia (Reggio, Catania, Siracusa, Sibari, Crotone, Metaponto, Taranto ecc.). Fenomeni colonizzatori furono portati avanti anche dai Fenici e dai Cartaginesi interessati prevalentemente alla Sicilia e alla Sardegna. L'apporto dei coloni greci fu decisivo e riguardò diverse sfere, da quella della scrittura, con la trasmissione dell'alfabeto, a quella della produzione agricola, con l'introduzione della coltivazione della vite e dell'olivo, e artigianale con, per esempio, il ricorso al tornio nella lavorazione della ceramica. Innovazioni nelle tecniche metallurgiche sembrano essere giunte invece dall'Europa centrale. I coloni greci furono protagonisti di forme di acculturazione delle genti italiche che arrivarono a interessare la religione e la mitologia oltre che i comportamenti sociali. Non mancarono nemmeno occasioni di trasmissione di conoscenze e valori tra i popoli della penisola: l'alfabeto, per limitarci a qualche esempio, fu trasmesso ai Veneti dagli Etruschi, che pure passarono ai Celti l'ideologia del banchetto. Centrale fu anche la scelta del modello d'insediamento: i Latini e gli Etruschi scelsero quello della città-stato (Roma, Tarquinia, Cerveteri, Vulci, Chiusi, Volterra, Populonia, ecc.), mentre altri popoli, Umbri e Sanniti per ricordarne due, ne preferirono uno diverso che prevedeva un popolamento più diffuso nel territorio. Alcuni scelsero poi di creare assetti istituzionali più ampi attraverso la creazione di leghe, sul cui funzionamento non siamo ben informati anche nel caso degli Etruschi che – teste lo storico romano Tito Livio – si riunivano annualmente presso il Fanum Voltumnae, il santuario federale non ancora scoperto, ma probabilmente da localizzare nei pressi di Orvieto. L'esito di una battaglia combattuta a Sentino, presso Sassoferrato nelle Marche, nel 295 a. C. mutò il quadro sinora delineato e portò al controllo politico della penisola da parte di Roma che, nel frattempo, era divenuta una potenza di prima grandezza. A Sentino l'esercito romano sconfisse una coalizione di Etruschi, Umbri, Sanniti e Galli; una vittoria ribadita in un nuovo scontro avvenuto al lago Vadimone (283 a. C.), nei pressi di Orte. Da quegli anni ebbe inizio il processo di romanizzazione, che previde quello cittadino come unico modello d'insediamento e il latino come unica lingua (le classi colte parlavano e scrivevano anche in greco). Il processo può dirsi compiuto – come si è già affermato – al termine del sec. I a. C., e, in questa ottica, va segnalata la generale concessione della cittadinanza romana a seguito della guerra sociale (90-88 a. C.). La storia dell'Italia in epoca imperiale romana vide da un lato un accentramento del potere politico e militare nell'Urbe, dall'altro un decentramento amministrativo in una rete di centri di grandezza diversa, ma assolutamente non paragonabili con Roma (alcuni di essi sono eccezionalmente ben conservati come Pompei ed Ercolano). I nuovi assetti portarono sino al sec. III d. C. a livelli di benessere elevati, che hanno trovato pochi equivalenti nella storia dell'Italia, e quindi a una crisi notevole a fronte dell'emergere di aree economiche divenute molto forti come la Gallia e, successivamente, l'Africa settentrionale e le Province orientali. Una crisi economica che si accompagnò e in parte fu causata da assetti politici deboli, i cui esiti portarono a un profondo indebolimento della penisola italiana e dello stesso ruolo di Roma, è ben testimoniato dalla divisione dell'Impero e dall'individuazione di Costantinopoli come ulteriore capitale (330 d. C.).
Archeologia: i principali siti dell'Italia settentrionale
Il già ricco il panorama archeologico italiano si è ampliato negli ultimi decenni grazie a numerose scoperte e a nuovi studi. Nell'Italia settentrionale la civiltà dei Liguri, occupanti, oltre ovviamente alla Liguria, anche del Piemonte e parte della Lombardia, non ha lasciato molti reperti caratteristici, ma gli scavi della necropoli di Chiavari, della necropoli e dei resti di abitato a Genova e i diversi castellieri – centri fortificati su altura di origine spesso preistorica – chiariscono aspetti finora poco noti della civiltà dei Liguri. Ben più definita è la civiltà dei Veneti, documentata dai ritrovamenti di Este (cultura atestina), da necropoli e depositi votivi di altre località del Veneto (una vasta necropoli del sec. VI-V a. C. presso il canale Piovego, in provincia di Padova ha restituito anche alcune tombe di cavalli) e della Venezia Tridentina e dai castellieri della Venezia Giulia e dell'Istria. Ricca è la documentazione archeologica dell'Etruria padana: Adria e soprattutto Spina furono i porti da cui affluirono dalla Grecia i vasi figurati che, insieme ai bronzi etruschi, costituivano la principale suppellettile tombale delle necropoli emiliane; la ceramica altoadriatica costituisce una tarda imitazione locale dei vasi greci. Il dominio gallico, che si estese dal sec. VI a. C. a tutta la Pianura Padana (Gallia Cisalpina) modificò scarsamente le forme di arte locali, soprattutto in Emilia, e ha lasciato pochi documenti originali. L'archeologia romana è documentata, più che dalle necropoli, dagli avanzi monumentali delle città antiche (tra cui Torino, Aosta, Brescia, Verona, Aquileia, Trieste, Luni, Rimini, Velleia), da ville grandiose (Desenzano, Sirmione, Russi) e, per il territorio, anche dai resti della centuriazione.
Archeologia: i principali siti dell'Italia centrale
L'archeologia dell'Italia centrale preromana è caratterizzata dai resti delle civiltà italica ed etrusca, divise grosso modo dal corso del Tevere. Interessanti ritrovamenti sono stati effettuati nelle Marche (necropoli picena di Numana e tombe di Pitino presso S. Severino Marche), in Abruzzo (necropoli di Campovalano presso Teramo, di Pennapiedimonte in provincia di Chieti, di Fossa nell'Aquilano), nel Molise (cinta muraria di Monte Vairano, probabilmente l'antica Aquilonia) e soprattutto nel Lazio. Nella parte meridionale della regione si sono studiate le cinte fortificate di Atina e Sora e si sono scoperti depositi votivi di diversi santuari. Di maggiore importanza sono i ritrovamenti più vicini a Roma, che danno nuovo valore alle notizie sulla più antica storia della città e al racconto virgiliano dell'Eneide. Si sono identificati centri noti sinora solo da fonti letterarie (per esempio Ficana presso Acilia, Antenne e Crustumerio sulla via Salaria, Collazia sulla via Collatina), alcuni dei quali, come Castel di Decima sulla via Pontina, probabilmente l'antica Politorium, con possenti fortificazioni e principesche tombe orientalizzanti del sec. VIII-VII a. C. rivaleggiavano certo per potenza e ricchezza con Roma. A Lavinio (Pratica di Mare) è stato trovato un heròon, con ogni probabilità da identificare con quello di Enea noto dalle fonti, ma la scoperta più importante è quella del grande deposito votivo (dalla fine del sec. VII al III a. C.) di un santuario di Minerva: di esso fanno parte un centinaio di statue fittili (dalla fine del sec. V al III a. C.) anche di grandi dimensioni – tra cui una statua alta oltre due metri di Minerva in armi affiancata da un Tritone, da identificare con la Tritonia Virgo dell'Eneide e forse riproducente la più antica immagine di Atena Ilìas a Troia – che costituiscono il più importante complesso di statuaria fittile italica sinora noto. Per quanto riguarda la civiltà etrusca le nostre conoscenze si sono accresciute non solo con la scoperta di nuove tombe e zone sepolcrali (Veio, Cerveteri, tombe dei Curunas a Tuscania, tomba intatta dei Cutu a Monteluce presso Perugia; necropoli di Tolle nel territorio di Chiusi) e con lo studio delle necropoli rupestri del Viterbese (Castel d'Asso, Norchia) ma anche e soprattutto con i risultati degli scavi in centri urbani: dall'abitato arcaico di Acquarossa a nord di Viterbo agli scavi delle aree urbane di Tarquinia, Cerveteri, Veio, a quelli dell'acropoli di Volterra, del centro costiero di Regae anticamente collegata a Vulci, di una città (forse l'antica Calusium) in località Doganella presso Magliano in Toscana, del quartiere industriale di Populonia, di un insediameno a carattere manifatturiero presso il lago dell'Accesa (Massa Marittima). La scoperta di una tavola bronzea con una lunga iscrizione in etrusco presso Cortona (Tabula Cortoniensis) ha portato un contributo significativo allo studio di quella lingua. Sempre più importante si dimostra poi la scoperta del grande complesso architettonico distrutto (o forse demolito) ancora in età arcaica – palazzo principesco piuttosto che santuario – di Poggio Civitate (Murlo) presso Siena, ricco di lastre figurate e di statue fittili dell'inizio del sec. VI a. C. La formazione dell'arte romana – cui concorsero apporti italici, etruschi e soprattutto greco-ellenistici – è evidente anzitutto nei monumenti di Roma repubblicana; l'arte romana si diffuse quindi nelle diverse zone con l'estendersi del dominio romano (il maggior numero di monumenti di età repubblicana è pertanto nel Lazio meridionale e nella Campania settentrionale) e raggiunse una sempre maggiore monumentalità, con l'impiego, soprattutto in età imperiale, di nuove tecniche di costruzione. A Roma stessa si possono ricordare gli scavi nella casa abitata da Augusto sul Palatino (pitture parietali, lastre fittili ornate), la scoperta di ampi tratti della pavimentazione del grandioso orologio solare augusteo presso Montecitorio, la ricognizione archeologica del Tevere con la scoperta sulle rive di nuovi grandi magazzini portuali, lo scavo di un nuovo quartiere urbano con importanti edifici di età imperiale in via dei Maroniti, i resti di case a più piani nella zona di San Paolo alla Regola, il ritrovamento di un grande affresco con la raffigurazione di una città, interpretata inizialmente come la stessa Roma, sul Colle Oppio all'interno di un criptoportico delle terme di Traiano. Nel Lazio si può ricordare lo scavo e la sistemazione dei resti di uno dei maggiori santuari di età repubblicana, quello di Ercole a Tivoli.
Archeologia: i principali siti dell'Italia meridionale
Nell'Italia meridionale i centri archeologici più importanti sono quelli delle colonie della Magna Grecia di Cuma, Posidonia-Paestum, Locri, Sibari, (anche per la rimessa in luce di ampia parte della città sovrapposta di Thurii, poi divenuta la colonia romana di Copia), Metaponto, Taranto, dove l'arte greca assunse talora aspetti particolari, come la monumentalità dell'architettura o il gusto per l'ornamentazione. Risonanza eccezionale ha avuto il ritrovamento in mare dei cosiddetti “bronzi di Riace”, due grandi statue bronzee di eroi-guerrieri di fattura greca databili nel sec. V a. C. La civiltà delle antiche popolazioni lucane ci è nota da numerose necropoli e insediamenti (tra cui quello di Serra di Vaglio presso Potenza, con mura del sec. V ma con lastre figurate di un tempio ancora del sec. VII a. C.), ma anche dall'eccezionale ampia serie di pitture delle tombe del sec. IV a. C. della necropoli di Paestum. In Puglia, gli scavi di Cavallino e di Muro Leccese hanno fornito nuovi dati sulla civiltà dei Messapi anche nei loro rapporti con Corfù e la Grecia, mentre il cosiddetto Poseidon di Ugento, identificato come una statua stilita di Zeus, appare il più antico “grande bronzo” proveniente dalla Magna Grecia giunto fino a noi, ancora del 530 a. C. circa. Nella stessa zona del Salento, a Roca Vecchia, è stata scoperta una grotta-santuario con numerose iscrizioni messapiche e anche romane. Più a nord la raccolta di oltre 1200 stele daunie (i Dauni abitavano la zona del Foggiano) fornisce un ampio repertorio sia di elementi decorativi sia di figurazioni di miti di origine greca, ma anche adriatica e orientale. L'archeologia romana ha i suoi centri più importanti lungo le strade consolari (per esempio a Benevento, Canosa e Brindisi sulla via Appia) e in Campania, nella zona dei Campi Flegrei (Baia) e a Pompei ed Ercolano, distrutte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d. C. Qui, oltre a nuove scoperte nelle stesse Pompei, Ercolano, Torre Annunziata (grande villa di Oplonti) di particolare rilevanza è il ritrovamento del grande ninfeo del palazzo imperiale sommerso dalle acque a Baia, con statue di divinità, di personaggi della famiglia giulio-claudia, di gruppi mitologici. In Sicilia gli scavi di Lipari hanno formato con i loro strati successivi un inquadramento delle civiltà preistoriche e protostoriche valido per molte parti d'Italia. Gli studi sulla civiltà fenicia e punica, solo da pochi decenni razionalmente indagata in Italia, si sono arricchiti di nuovi dati con le scoperte di Mozia (notevolissima una statua virile marmorea del sec. V a. C. di chiaro influsso greco), della vicina Trapani (resti di nave punica) e di altre località della Sicilia (per esempio il santuario in grotta di Grotta Regina), mentre l'abitato di Monte Adranone a nord di Sambuca in provincia di Agrigento e il suo santuario di Demetra sembrano costituire un punto di incontro delle civiltà indigena, greca e punica. Per quel che riguarda l'archeologia romana, alla ben nota villa di piazza Armerina si sono aggiunte altre grandiose ville del sec. IV-V d. C. al Tellaro, a sud di Siracusa, e a Patti a ovest di Milazzo, anch'esse con ricchissimi pavimenti a mosaico, probabilmente opera di maestranze africane.In Sardegna numerose le vestigia della civiltà nuragica, durata dall'Età del Bronzo all'età storica, e notevoli sono i documenti di archeologia punica a Tharros e nel Sulcis (Sant'Antioco), nella fortezza di Monte Sirai, nel tempio punico-romano di Sardus Pater ad Antas.
Arte: i periodi paleocristiano e altomedievale
La nascita di un'arte “italiana” è datata tradizionalmente in concomitanza con l'affermarsi del cristianesimo, particolarmente a Roma. La vittoria di Costantino su Massenzio e l'“editto di tolleranza” (313) costituiscono in proposito un sicuro termine di riferimento. Tuttavia di una cultura artistica italiana si può parlare in misura tanto maggiore quanto minore diviene l'importanza di Roma quale centro dell'Impero. Il trasferimento della capitale a Costantinopoli e delle corti a Milano e a Ravenna, accrebbero l'importanza di altre località dando luogo appunto a una cultura artistica italiana e non più romana. Le invasioni barbariche, i saccheggi di Roma, la guerra greco-gotica e infine la conquista longobarda, frantumando l'unità imperiale tardoromana crearono le condizioni per una nuova unità, culturale prima che politica, basata sulle province italiche e sulle forme assunte localmente dal cristianesimo. Da queste vicende è sommariamente definita l'età paleocristiana, che terminò con le invasioni longobarde e con la fine dell'egemonia bizantina in Italia e a Roma. In architettura il modello fondamentale fu costituito dai grandi edifici termali della decadenza, ma soprattutto dalla Basilica di Massenzio, tipica per la concezione additiva degli spazi, strutturati ad assi ortogonali, e per le grandi volte a crociera della navata mediana. Le prime basiliche cristiane (costantiniane) di Roma, come S. Giovanni in Laterano, S. Pietro e S. Paolo, si contrapposero all'architettura imperiale negando i volumi e ostentando piani murari semplici, quasi immateriali, atti a ospitare (sec. V) figurazioni edificanti (S. Sabina, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo fuori le Mura, ecc.). Il prevalere delle superfici sui volumi è evidente anche nelle costruzioni a pianta centrale o accentrata: a Roma (Mausoleo di S. Costanza, Battistero Lateranense, S. Stefano Rotondo), a Milano (S. Lorenzo), a Ravenna (Mausoleo di Galla Placidia), ad Albenga (Battistero). La presenza della corte d'occidente a Ravenna (sec. V) e poi l'unificazione giustinianea crearono una cultura artistica specifica, detta ravennate appunto, che non è uguale a quella bizantina costantinopolitana, ma può considerarsi una sua variante e quindi rientrare nel grande alveo dell'arte bizantina. Stilisticamente in quest'ultima fase l'architettura venne sempre più smaterializzata e trasformata in sistema di superfici capaci di generare luce e colore. Ciò è visibile nelle basiliche longitudinali ravennati di S. Apollinare Nuovo e di S. Apollinare in Classe e negli edifici a pianta centrale di quella stessa città (battisteri degli Ortodossi e degli Ariani, S. Vitale). Marmi policromi, stucchi, decorazione musiva e speciali elementi architettonici, come il pulvino, appaiono infine componenti fondamentali di questa trasformazione. Contro questa tendenza smaterializzante urta, proprio a Ravenna, il Mausoleo di Teodorico, edificio volumetrico e megalitico, ambiziosamente romaneggiante eppure barbarico per il sincretismo delle forme e delle funzioni. Ma nella forma ottagona del S. Vitale, sorretta dalle controspinte radiali dei contrafforti esterni (inconcepibili, in quanto radiali, in area costantinopolitana) è implicita una concezione architettonica suscettibile di impensati sviluppi. La scultura paleocristiana vanta uno dei suoi massimi documenti nei rilievi costantiniani dell'Arco di Costantino: frontalità e planarità, prospettiva inversa, guidano la composizione e il modellato come guideranno gli artisti musivi ravennati fino all'epoca giustinianea. La statua del Buon Pastore (Roma, Museo Lateranense), i numerosi e noti sarcofagi delle Grotte Vaticane, del Museo Pio Clementino, del Museo di Siracusa, ecc. rappresentano un filone di naturalismo tardoromano meno radicalmente cristianizzato dei rilievi costantiniani. Tale naturalismo appare depurato, con raffinatissima eleganza, in taluni avori di epoca teodosiana (lipsanoteca di Brescia) e in taluni rilievi di sarcofagi ravennati. La famosa cattedra di Massimiano (Ravenna, Museo Arcivescovile), capolavoro della scultura in avorio del sec. VI, è però il documento di estremi contatti con l'oriente tardoromano, donde fu verosimilmente importata. La pittura parietale continua nel sec. IV a essere documentata in catacombe anche pagane. Nel secolo successivo si smaterializzò in preziose superfici musive a Roma, a Napoli, a Milano, a Ravenna, ma con stile ancora pittorico, determinato dalle sopravvivenze della miniatura tardoromana. La miniatura seguì peraltro a lungo una vicenda stilistica propria sia per la mobilità del supporto sia per la natura tecnica tradizionale (Rotulo di Giosuè, Genesi di Vienna, Codice Purpureo di Rossano, ecc.). L'evoluzione più radicale si effettuò invece a Ravenna, nei mosaici, fino a raggiungere in S. Vitale (sec. VI) una raffinata sintesi tra colorismo di origine naturalistica e trasfigurazione mistica, tra narrazione e stereotipizzazione simbolica, contribuendo a creare il futuro stile bizantino e documentando il contatto con la cultura artistica del cristianesimo orientale. Le dominazioni longobarde portarono da un lato a una sopravvivenza di forme paleocristiane di ascendenza bizantina, dall'altro all'introduzione di tipologie e accenti stilistici derivati dalla figurazione nord-germanica, basata sulle tecniche proprie della lavorazione dei metalli e dell'oreficeria. Anche iconologicamente attraverso i Longobardi si diffusero motivi (l'intreccio, l'animalistica, la forma ambigua) propri delle mitologie nordiche e della religione odinica. Il fenomeno è chiaramente leggibile nelle arti applicate, non nell'architettura, estranea a popolazioni fino allora seminomadi. Tuttavia edifici come il battistero di Lomello, l'abside di S. Pietro in Tuscania, la chiesa di S. Sofia di Benevento, il tempietto di S. Maria in Valle a Cividale testimoniano, tra la fine del sec. VI e la fine dell'VIII, volontà costruttive consapevolmente rivolte a forme schematizzate, estranee all'eredità classica, combinate o alternate a quelle apparentemente ossequienti alla tradizione classica cristiana (S. Salvatore di Brescia, il tempietto di Cividale per la decorazione plastica e pittorica, S. Maria di Castelseprio). La dominazione franca portò, prima con la rinascita carolingia e poi con la cultura ottoniana, a una rielaborazione più sottile e complessa delle forme classiche e a tentativi di sincretismo più accentuati. Muratura a pietrame o mista a cotto, archetti pensili, fornici sotto la gronda delle coperture, irregolarità costruttive, materiale di spoglio nascondono strutture accentrate o longitudinali di stampo classico spesso derivate da elaborazioni oltremontane (battistero di Biella, S. Pietro al Monte in Civate, S. Pietro di Agliate, ecc.). Nella scultura si ridusse il bassorilievo bizantino a intaglio lineare (sarcofago di Teodota nel Museo del Castello di Pavia, pluteo in S. Colombano di Bobbio, altare di Ratchis e battistero nel duomo di Cividale, ecc.), ma in epoca di rinascimento desideriano e carolingio (tempietti di Cividale e di Malles, secchiello eburneo del duomo di Milano) si volle tornare a un maggiore naturalismo. In pittura il monachesimo orientale si ebbe a gran parte e a più riprese a Roma (S. Maria Antiqua, mosaici di molte chiese, ecc.), nel sud della penisola (grotte basiliane), nel nord (affreschi di S. Maria di Castelseprio). La rinascita carolingia implicò tuttavia un mutamento profondo nello stile delle miniature attraverso l'istituzione degli scriptoria. Il monumento più spettacolare del sincretismo tra oreficeria, scultura e pittura e tra narrazione barbarica e tradizione classica è l'altare d'oro e d'argento e smalti di Vuolvinio (sec. IX, S. Ambrogio a Milano).
Arte: il romanico
Nella storia dell'arte il termine romanico designa ormai una fase che va per l'Italia dal sec. XI al XIII, caratterizzata dall'amalgama tra retaggio classico e retaggio barbarico (in parte anche celtico, ma soprattutto germanico), quest'ultimo rivitalizzato dalle invasioni normanne. L'architettura riassume coerentemente tipiche forme tardoromane (coperture a volta, articolazione in campate, valore delle membrature e delle masse murarie), tuttavia accrescendo l'importanza dei pieni sui vuoti e l'apporto fantastico della decorazione plastica, non applicata, ma organicamente inserita e fusa nelle strutture. Paradigmatica è in tal senso la lunga vicenda costruttiva di S. Ambrogio a Milano, dove però traspare l'intento di assorbire anche la concezione additiva degli spazi propria dell'oriente cristiano (bizantino) collocandosi in una posizione di mediazione tra agonismo nordico e irenismo bizantino. La concezione additiva trionfa tuttavia nella basilica di S. Marco a Venezia e nell'Italia meridionale: allo stato originario nell'estrema penisola (Stilo, Roccella Ionica, Lecce, ecc.), commista a influssi islamici in Sicilia (Palermo, Monreale, Cefalù) e sul versante tirrenico (Amalfi, Ravello, Caserta). Componenti orientali bizantine (e persino armene) e islamiche, nordiche barbariche, classiche (sopravvivenza dell'arte romana imperiale e provinciale) costituiscono, combinandosi variamente, la ragione dell'unità e al tempo stesso della grande e affascinante ricchezza e complessità di forme e di tecniche costruttive dell'architettura (e delle altre forme d'arte) del mondo romanico. Più forti appaiono le componenti nordiche in alta Italia (Como, Pavia, Milano, Asti, Torino, Genova) tanto da far parlare di architettura lombarda, ma anche al centro-nord e al centro (Parma, Piacenza, Modena, Arezzo, Spoleto, Perugia, Assisi, Ascoli Piceno) e nel sud (Benevento, Bominaco, Petrella Tifernina, Trani, Troia, Bari). Le componenti orientali appaiono forti sul versante adriatico (Venezia, Torcello, Ancona, senza tener conto della Dalmazia e dell'estrema penisola già ricordata), ma assumono una funzione non trascurabile nell'architettura romanica fiorentina, lucchese e soprattutto pisana (con riferimento al duomo di Pisa, ma anche alla basilica di S. Pietro a Grado), la quale ultima determinò largamente lo svolgersi dell'architettura in Sardegna (Cagliari, Oristano, Borutta, Codrongianus, Porto Torres, ecc.). Le componenti classiche prevalsero attraverso il retaggio basilicale paleocristiano a Roma (chiostri di S. Lorenzo e di S. Paolo, chiesa superiore di S. Clemente, SS. Giovanni e Paolo, ecc.) e nel Lazio (Civita Castellana, Viterbo, Terracina, ecc.), ma furono determinanti spesso anche in Toscana, dove rafforzarono le suggestioni orientali, trasmesse peraltro per lo più attraverso stoffe, miniature, oreficerie. Ciò spiega il frequente trapassare di ogni arte nell'altra, sempre trovando la massima sintesi nell'architettura. Ne sono esempio tipico le scuole romano-laziali dei Cosmati e dei Vassalletto, con le quali culminò nel sec. XIII quel processo di sintesi in cui tecniche musive, scultorie e costruttive si coordinano, diffondendo uno stile originale verso nord (fino a Firenze) e verso sud (fino a Salerno). La scultura romanica seguì vicende analogamente determinate dal variare delle stesse componenti. Di impronta classico-orientale sono gli stucchi del ciborio di S. Ambrogio (fine del sec. XI e inizi del XII) a Milano e i rilievi ai lati del portale di S. Zeno a Verona, scolpiti da Nicolò. L'opera di Wiligelmo, a Modena, fu coeva espressione di una cultura di ispirazione oltremontana, che proseguì in un rigoglioso sviluppo autonomo a Cremona, a Ferrara (duomo), a Fidenza, a Pavia, ecc. e trovò accenti molto simili anche nel sud (cattedra di Elia in S. Nicola di Bari). Direttamente da Bisanzio furono importate le porte ageminate di Monte Sant'Angelo sul Gargano (1076). Per contro furono eseguite da modellatori e fonditori germanici le formelle bronzee di S. Zeno a Verona (sec. XII), analoghe ad altre dell'Europa centrale e del nord, da Hildesheim fino a Novgorod. Ma modellatori e fonditori di cultura classica prepararono certo il terreno su cui emersero nel sec. XII le personalità di Barisano da Trani e di Bonanno, quest'ultimo intento, a Pisa e Monreale, a mediare le forme nordiche e quelle classico-orientali. La ricerca di un equilibrio tra le varie componenti caratterizza la cultura plastica toscana (Biduino, Gruamonte, soprattutto Maestro Guglielmo nel pulpito del duomo di Pisa ora a Cagliari), ma raggiunse uno splendido successo nell'opera dell'Antelami, capace di assorbire nel suo evolversi fin dentro il sec. XIII anche le nuove istanze gotiche. Pittura, miniatura, mosaico, arti applicate non furono da meno nel riflettere allo stato originario o in varia commistione le componenti già indicate. Dagli exultet miniati di chiara ispirazione bizantina, si giunge a cicli a fresco come in S. Pietro al Monte di Civate (sec. XI), cicli musivi come a Monreale, Cefalù, Palermo, Venezia (eseguiti tra il sec. XII e il XIII), tutti ispirati a un bizantinismo aulico o eseguiti addirittura da maestranze orientali. Un'impronta meno aulica hanno invece i cicli di S. Pietro a Ferentillo e di S. Angelo in Formis, presso Capua, e meno ancora quelli di S. Eldrado nella Novalesa. Tra i cicli laziali, in posizione di mediazione tra le varie componenti, deve essere ricordato il ciclo della cripta di Anagni, insigne per ricchezza di motivi e di forme. Il monumento della componente anticlassica è però lo straordinario tappeto costituito dal mosaico pavimentale del duomo di Otranto (1163-66), che si riallaccia ancora direttamente, a distanza di oltre mezzo secolo, ai modi tipicamente normanni dell'arazzo di Bayeux. Le opere dell'Antelami, scultore e architetto a un tempo, appaiono romaniche all'inizio e gotiche alla conclusione: esse rappresentano perciò, anche cronologicamente e in modo caratterizzante, la storia dell'arte italiana dello scorcio del Medioevo.
Arte: il gotico
Mentre tra Normandia, Inghilterra e Île de France le strutture tipiche dell'architettura gotica (proporzioni, coperture a crociera nervate, contrafforti, archi rampanti, pilastri a fascio, archi acuti, cappelle radiali absidali, ecc.) emersero e maturarono tra la fine del sec. XI e la metà del XII, in Italia tutti questi elementi emersero molto più tardi, a cominciare dall'inizio del Duecento, e si svilupparono in modo originale preferendo membrature e scansioni dello spazio semplici e larghe, metricamente percepibili. Se gli interni delle cattedrali gotiche dell'Île de France sono stati paragonati a una selva, quelli delle grandi chiese abbaziali e delle cattedrali del Duecento italiano possono essere paragonati a grandi frutteti chiaramente ordinati quasi entro serre o padiglioni, dove spesso alla volta si preferisce la copertura lignea. Ciò è evidente non tanto e non soltanto nelle prime chiese gotiche che i cistercensi costruirono (secondo moduli già adottati in Francia) a Fossanova (1208), a Casamari (1203-17), Valvisciolo, San Galgano, ecc. quanto nelle chiese di altri ordini monastici, dappertutto francescani e domenicani, in particolare ad Assisi (S. Francesco) e Napoli (S. Chiara) e a Firenze (S. Maria Novella, S. Croce). Tuttavia già all'inizio del Duecento il capolavoro attribuito all'Antelami, il S. Andrea di Vercelli, presenta proprio quei caratteri, e poiché le grandi architetture dello scorcio e della fine del Trecento (si ricordano tra esse S. Maria del Fiore a Firenze, S. Petronio a Bologna, S. Zanipolo a Venezia, e persino il duomo di Milano) obbediscono allo stesso principio, si può ben dire che le caratteristiche specifiche dell'architettura gotica italiana furono interpretate e fissate a Vercelli per almeno due secoli e all'inizio del Duecento. In ogni caso, mai si obliterarono interamente forme e modi dell'età precedente e quasi mai si addivenne ad accettare tutti gli elementi gotici del linguaggio architettonico in un sistema rigorosamente coerente. Ne è prova il curioso pastiche costituito a Padova dal S. Antonio, combinazione di temi bizantini, romanici e gotici di stampo francese. Caratteristica saliente dell'età gotica italiana fu anche lo sviluppo assunto in architettura dai temi profani: il palazzo della Ragione (Padova), il palazzo comunale (Firenze, Siena, Piacenza, ecc.), il palazzo dei Priori (Perugia), il palazzo dei Consoli (Gubbio), il Broletto (Como), il Bargello (Firenze), la Loggia dei Mercanti (Bologna, Firenze), il palazzo del Capitano del Popolo (Orvieto, Mantova), il palazzo signorile (Visconteo a Pavia, palazzo Davanzati a Firenze, Steri a Palermo, casetorri di Lucca, S. Gimignano, Bologna, ecc.), il palazzo Ducale (Venezia, Genova), la porta e la cinta fortificata (ve ne sono numerosissime e famose, tra cui ancora ben visibili quelle di Lucera, Siena, San Gimignano, Monteriggioni, Pisa, Montagnana, ecc.), il castello principesco (dai federiciani Castello Ursino a Catania, Castel del Monte del 1240 ca. presso Andria, a quello di S. Giorgio a Mantova, da Serralunga d'Alba a Fenis in Val d'Aosta). Nella scultura, a cominciare dagli inizi del Duecento e già nell'Antelami più tardo, entrarono modi sviluppatisi nell'Île de France, ma dovettero attendere a lungo prima di affermarsi perché Guido da Como e altri (a Pistoia, a Lucca, a Volterra, ecc.) continuarono ad attenersi a schemi classicheggianti, ma rigidi e ancora romanici. Questi schemi furono rotti da Nicola Pisano (seconda metà del sec. XIII), ma per giungere a un recupero più che mai forte di modi classici, tardoromani o paleocristiani (pergamo del battistero di Pisa). Però egli progressivamente accolse le suggestioni francesi di movimento e di finezza di resa naturalistica (già a Siena, nel pulpito del duomo). Il figlio Giovanni (ca. 1245-dopo il 1314) elevò quelle suggestioni a drammatica potenza espressiva, ma sfrondandole di ogni lezioso particolarismo, nelle sue opere di Pisa, Pistoia, Padova, parallelamente all'evolversi della pittura giottesca. Da componenti analoghe a quelle di Nicola derivò l'arte di Arnolfo (ca. 1245-prima del 1310), ma escludendo la componente francese e con accenti più rudi, simili a quelli del primo Giotto (ca. 1267-1337). Dalla fine del Duecento la storia della scultura, degli avori, dell'oreficeria è difficilmente districabile da quella della pittura, se si bada alle linee di fondo della concezione spaziale e alle tipologie e talvolta anche dall'architettura, se si tien conto dei tabernacoli di Arnolfo a Roma e dei suoi lavori per S. Maria del Fiore (1296), e ancora del campanile iniziato da Giotto nel 1334. A parte la presenza non casuale di Nicola Pisano (dopo 1264) tra gli architetti del duomo di Siena e la compresenza di Giotto e Giovanni Pisano a Padova nella cappella degli Scrovegni, strette affinità e quasi una continuità caratterizzano in pieno Trecento la scultura di Tino di Camaino (ca. 1285-ca. 1337), di Nino e Andrea Pisano, di Lorenzo Maitani (ca. 1270-1330), di Giovanni di Balduccio, di Giovanni d'Agostino (metà del sec. XIV) e l'opera di orafi come Ugolino di Vieri, autore del famoso reliquiario del Corporale (duomo di Orvieto), uno dei capolavori dell'oreficeria di tutti i tempi. Nessi anche più precisi possono ravvisarsi tra le volumetrie di Tino di Camaino e quelle di Ambrogio Lorenzetti (ca. 1285-ca. 1348), tra il raffinato colorismo di Simone Martini (ca. 1284-1344) e il sottile rilievo di Lorenzo Maitani e così via. Certo, il nesso Pisa-Siena-Firenze appare determinante tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento per la storia della scultura italiana, diffondendo uno stile omogeneo dovunque (si pensi a Goro di Gregorio, autore della tomba de' Tabiatis a Messina), e anche nella terra d'origine se ne conservò a lungo l'impronta, fino ai primi decenni del Quattrocento, non solo attraverso l'opera di Andrea Pisano, ma anche attraverso quella di Iacopo della Quercia (ca. 1371-1438), di Francesco di Valdambrino e di Lorenzo Ghiberti (1378-1455). Fuori di questo nesso si svolsero scuole periferiche: dei Maestri Campionesi, attivi a Milano e a Verona; dei maestri veneti (Andriolo de Sanctis, Pier Paolo e Iacobello Dalle Masegne), attivi tra Padova, Venezia, Bologna; degli Embriachi, famiglia di famosi intagliatori. La pittura del Duecento oscilla tra una persistente adesione all'iconismo tradizionale, mediato da Bisanzio anche attraverso le miniature, e l'intento di superarlo accogliendo grafismi di origine non classica. Sia l'adesione sia il superamento sembrano svolgersi su due piani: uno volgare, quando iconismo tradizionale e grafismi vengono piegati a fini narrativi; uno aulico, quando l'iconismo antico viene recuperato al di là delle schematizzazioni bizantine e i grafismi vengono filtrati e raffinati attraverso i modelli francesi. In questa complessa dialettica è chiaramente distinguibile la linea che da Alberto Sozio, Bonaventura Berlinghieri, Margaritone e innumerevoli altri sconosciuti autori di tavole dipinte e partecipanti all'esecuzione dei grandi cicli musici e a fresco (Parma, Venezia, Firenze, ecc.) giunge fino a Giunta Pisano e Coppo di Marcovaldo. Cimabue segnò invece, accanto a Guido da Siena, l'accoglimento dei modelli gotici francesi, seguito da Duccio di Buoninsegna (ca. 1255-ca. 1318), che in questa direzione rappresenta il punto più alto di fusione tra retaggio aulico bizantino e forme gotiche. Il recupero aulico dell'iconismo antico è, per contro, il grande raggiungimento di Pietro Cavallini (sec. XIII-XIV), soprattutto nelle opere romane. La singolarità di Giotto sta nell'aver portato all'estremo tutte le componenti di quella dialettica, individuandone la sostanza al di là delle apparenze formali: perciò recuperando dietro il retaggio iconico classico-bizantino la rigorosa volumetria, dietro i grafismi anticlassici lo schematismo drammatico franco-germanico, dietro il volgare l'osservazione diretta, dietro la raffinatezza aulica l'estremo rigore esecutivo. Si spiega così come quasi tutta la pittura del Trecento sia condizionata da Giotto e dalla sua scuola: ad Assisi fino alle vele della chiesa inferiore di S. Francesco; a Rimini e in tutta l'Emilia dal Baronzio a Vitale da Bologna e altri minori; in Lombardia e in Toscana da Giovanni da Milano ai fratelli Gaddi; a Padova dal Guariento a Giusto dei Menabuoi, ecc. Una sintesi in parte simile a quella giottesca fu operata dai grandi maestri senesi del Trecento: Ambrogio e Pietro (ca. 1280-ca. 1348) Lorenzetti, Simone Martini. Soprattutto nell'ultimo prevalse tuttavia l'attenzione ai modelli francesi, attenuandosi l'interesse volumetrico e drammatico. Fino a Taddeo di Bartolo nel Trecento, ma ancora fino a metà Quattrocento, la pittura senese subordinò poi sempre questi valori all'eleganza smaltata e preziosa delle superfici dipinte. Nei castelli dell'Italia settentrionale si sviluppò nel Trecento una pittura più direttamente e formalmente ispirata a modelli d'oltralpe, dando luogo a uno stile gotico cortese o tardogotico, narrativo e calligrafico a un tempo, che si svolse a lungo nel secolo successivo: ciclo del Castello della Manta presso Saluzzo, opere di Giovannino De Grassi, Michelino da Besozzo, ecc. fino a Stefano da Verona (ca. 1379-dopo il 1438), Pisanello (notizie dal 1395 al 1455), Bonifacio Bembo, Belbello da Pavia, Gentile da Fabriano (ca. 1370-1427). A questo si connette anche lo stile di Masolino da Panicale (ca. 1383-ca. 1440). Le forme tardogotiche e quel particolare gotico cortese che fu detto anche gotico internazionale per gli addentellati e le analogie con l'arte d'oltralpe (francese, fiamminga, renana, boema) giunsero a far dimenticare e quasi a sommergere per poco meno di un secolo la sintesi giottesca.
Arte: il Rinascimento
La sintesi giottesca fu recuperata e insieme superata largamente a Firenze agli inizi del Quattrocento dagli artisti che si raccolsero attorno a F. Brunelleschi (1377-1446): anzitutto Masaccio (1401-1428) e Donatello (ca. 1386-1466). Con loro architettura e oreficeria, scultura e pittura si integrarono reciprocamente poggiando su un procedimento operativo comune: la progettazione attraverso il modello in scala e il disegno prospettico. Il primo mezzo era in uso da antica data, ma il secondo, messo in atto con geniale pragmatismo da F. Brunelleschi, esprimeva in sintesi relazioni geometricamente certe tra spazio e rappresentazione e l'identità percettiva tra rappresentazione e visione. Narrazione drammatica e osservazione dal vero, volumetria e iconismo e, insieme, retaggio gotico e retaggio classico trovavano così un nuovo inaudito punto di fusione. Si spiega perciò il grande successo della prospettiva brunelleschiana e la considerazione per Masaccio, interpretato come un “Giotto redivivo”. A questo radicale recupero dell'iconismo classico si aggiungeva l'analisi sistematica quasi archeologica degli elementi linguistici dell'architettura e della scultura antica e il suo trasferimento nel linguaggio moderno. Donde il termine Rinascimento, riferibile a tutto il periodo in cui, fino alla fine del Cinquecento, fu vivo quel processo. Subito dopo il Brunelleschi, L. B. Alberti (1404-1472) fu, in architettura, il teorico e sperimentatore principe degli ordini e delle proporzioni antiche, ma ispirandosi particolarmente ai tipi romani e determinando soprattutto con opere proprie la svolta della metà del Quattrocento a Rimini, a Mantova, a Firenze, a Roma, sia direttamente sia indirettamente attraverso esecutori e seguaci. Il suo trattato sull'architettura fu infatti pubblicato e conosciuto molto tardi (fine del sec. XV), in concomitanza con il fiorire di un'abbondante trattatistica (Francesco di Giorgio Martini), che poi si sviluppò fino al Palladio (1508-1580) e al Vignola (1507-1573). L'Alberti influì profondamente su pittori e scultori prima ancora che sugli architetti con i suoi esperimenti e i suoi scritti sulla pittura (1435) e sulla scultura, teorizzando la prospettiva e la composizione pittorica e la tecnica statuaria. Si ispirò a lui in gran parte la corrente pittorica di F. Lippi (ca. 1406-1469), del Pollaiolo (ca. 1431-1498), del Botticelli (1445-1510), di Piero di Cosimo (1461/62-1521) e la scultura di Agostino di Duccio (ca. 1418-ca. 1481). Caratteristica saliente del primo Rinascimento fu lo sviluppo o la nascita di centri creativi e organici grandi e piccoli e di forme artistiche nuove attorno a papi (Pio II a Roma, a Siena, a Pienza; Sisto IV a Roma), a grandi famiglie di mercanti e banchieri (i Medici a Firenze), a condottieri (Federico II di Montefeltro a Urbino), principi (i Visconti e gli Sforza a Milano; i Malatesta a Rimini; gli Estensi a Ferrara; i Gonzaga a Mantova), alle corti reali e vicereali d'Aragona e di Francia a Napoli e a Milano. Il fenomeno fu tanto accentuato che si può parlare talvolta di un vero e proprio stile riferito a una località (stile urbinate). Le repubbliche che mantennero per qualche tempo una base di potere meno personalizzata, come Genova, Siena, Perugia, Venezia, tardarono ad accettare e assimilare le forme rinascimentali. Ma mentre Genova quasi mancò di un'arte propria nel Quattrocento, Siena mantenne la sua alta tradizione produttiva sia pure indugiando a lungo su forme tardogotiche, e Venezia, sempre conservando suggestioni bizantine, combinò fino al Quattrocento inoltrato le suggestioni tardogotiche italiane con quelle d'oltralpe, particolarmente dei Paesi boemi e tedeschi, per i quali costituì poi sempre un tramite.
Arte: il Rinascimento: l'architettura
Nonostante la estrema complessità di questo quadro, la storia architettonica del Rinascimento italiano è in larga misura la storia dell'irradiazione dell'arte fiorentina combinata con il classicismo romano. Su questa linea di sviluppo si colloca via via l'opera di Michelozzo (1396-1472) a Firenze, a Pistoia, a Milano e soprattutto di Bernardo Rossellino (1409-1464; duomo e palazzi principali di Pienza, 1459-62). Lo stesso può dirsi di A. Averlino, detto il Filarete (ca. 1400-ca. 1469) a Milano, di Meo del Caprina (1430-1501) a Torino, di Giuliano da Maiano (1432-1490) a Napoli, del Coducci (1440-1504) a Venezia, di L. Laurana (ca. 1420-1479) a Urbino, di Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) a Siena, Urbino, Cortona e altrove, di Giuliano da Sangallo (ca. 1443-1516) a Roma e in Toscana, di Biagio Rossetti (1447-1516) a Ferrara. Bramante (1444-1514), formatosi come pittore nell'ambiente umbro-marchigiano dominato da Piero della Francesca (1415/20-1492), trasferitosi a Milano impose un'architettura ricca di sollecitazioni percettive, fatta di diaframmi traforati, mossa da scatto fantastico, sfidando talvolta la statica. A Roma Bramante modellò con più semplicità e sugli esempi antichi (tempietto di S. Pietro in Montorio, chiostro di S. Maria della Pace, cortile del Belvedere in Vaticano, ecc.). Per S. Pietro in Vaticano concepì un'ambiziosa fusione di forme classiche, mai realizzata. Dopo la sua morte, sulla fabbrica di S. Pietro si misurarono gli altri grandi del Rinascimento: Fra' Giocondo (1433-1515), Raffaello (1483-1520), i da Sangallo, B. Peruzzi (1481-1536), Michelangelo (1475-1564), sempre tentando la pianta accentrata a croce greca e solo in subordine l'iconografia longitudinale a croce latina, che però alla fine s'impose per volere di Paolo V a opera di C. Maderno (1612). Dopo la morte di Michelangelo, misero mano a S. Pietro Giacomo Della Porta, P. Ligorio, il Vignola, D. Fontana. La fabbrica di S. Pietro nelle sue varie fasi fu paradigma a innumerevoli opere, anche fuori d'Italia e per secoli. Ambiva fondere motivi cristiano-orientali, motivi classico-romani, motivi cristiani occidentali. Per contro fu occasione del più grande scisma della cristianità. Il suo schema iconografico alla fase iniziale trovò eco nella basilica genovese (S. Maria di Carignano) dell'Alessi (1512-1572), donde si trasmise a sua volta all'Escorial. L'Alessi equilibrò gli spunti bramanteschi, raffaelleschi e peruzziani con quelli michelangioleschi, schivando il rigorismo strutturale e proponendo una sobria decorazione manieristica a Genova e soprattutto in Lombardia. Qui fu tuttavia sopravanzato in lussureggiante oratoria dal Tibaldi (1527-1596). A Genova le suggestioni alessiane favorirono la creazione di “strada nuova” (l'attuale via Garibaldi), uno dei centri architettonici, plastici e pittorici più insigni del manierismo europeo. Urbanisticamente quella strada espresse l'estrema aspirazione alla “città rinascimentale”, contraddetta dalla “città rituale” che la Controriforma intanto voleva e preparava (la Milano dei Borromeo, la Roma di Sisto V. Contrariamente a Michelangelo, che progettò mirando a esprimere potenza plastica, strutturale e simbologica, il Palladio, ma fu in parte preceduto dal Sanmicheli, fu attratto dal senso cromatico dei piani e dei volumi, dall'euritmia e musicalità delle proporzioni, piegando in tal senso i modelli classici, pur attentamente e direttamente studiati. Vie intermedie seguirono Giulio Romano (ca. 1499-1546), il Sanmicheli (1484-1559) maturo, il Sansovino (1486-1570), lo Scamozzi (1552-1616) e numerosi altri. L'arte delle fortificazioni è, nella storia dell'architettura italiana, un capitolo importante: L. Laurana, Baccio Pontelli (ca.1450-1495) e soprattutto Francesco di Giorgio Martini operarono fino all'invenzione del fronte bastionato. Leonardo da Vinci (1452-1519) ha certo importanza come teorico dell'architettura, ma i suoi pensieri più geniali sono forse nel campo delle fortificazioni. Antonio da Sangallo e Michelangelo ne rappresentano evoluzioni significative.
Arte: il Rinascimento: la scultura
La scultura del Rinascimento seguì vicende che s'intrecciarono in parte con quelle dell'architettura. A Ghiberti, che rimane tardogotico, nonostante le apparenze, ancora a metà Quattrocento (porta del Paradiso nel battistero di Firenze), si oppone Donatello, radicalmente iconico, drammatico, attento a un vero solo raramente idealizzato. La sua arte si irradiò dovunque in Italia attraverso le opere di Padova, Siena, Firenze, Napoli, Roma. Ne svolsero le premesse stilistiche innumerevoli scultori, tra cui l'Averlino, Agostino di Duccio, il Vecchietta (ca. 1412-1480), Desiderio da Settignano (ca. 1430-1464), Antonio Rossellino (1427-1479), Benedetto da Maiano (1442-1497), Antonio Pollaiolo, il Verrocchio (1435-1488), Francesco di Giorgio Martini, lo stesso Leonardo. Sia nelle sculture in marmo, sia nelle terrecotte policrome e invetriate L. Della Robbia (ca. 1400-1482) espresse i suoi ideali in purismo classico, di morbido plasticismo. Una rottura fu operata ai primi del Cinquecento da Michelangelo, che impose superfici nette e “mentali” attraverso le opere giovanili (Pietà di S. Pietro a Roma, Madonna di Bruges), il “non-finito” e valori luministici attraverso opere mature e tarde (Pietà Rondanini, Milano, Castello Sforzesco). Dar forma ai corpi significa trasferire sulla materia l'impronta dell'ispirazione divina sull'anima umana: l'artista in tal senso è quasi un intermediario tra Dio e gli uomini. La mitizzazione dell'artista attraverso questa teoria neoplatonica è uno dei tratti caratteristici dell'arte del tardo Rinascimento e della poetica del Vasari: nessuno la incarnò più intensamente di Michelangelo. Con Andrea e Iacopo Sansovino, il Giambologna (1529-1608), Guglielmo Della Porta e altri, è completo un quadro sommario della scultura del Cinquecento.
Arte: il Rinascimento: la pittura e le arti minori
È luogo comune, ma non per ciò meno vero, dire che la pittura toscana fu fondata sul disegno e sul chiaroscuro e quella veneta sul colore. Con ciò si vuole però indicare la prevalenza di una componente, non la sua esclusività. L'impianto prospettico e chiaroscurale studiato da Masaccio e poi da Andrea del Castagno (ca. 1421-1457), Paolo Uccello (1397-1475), Piero della Francesca tollerò un colore spesso molto ricco, anzi il Beato Angelico (ca. 1400-1455) ne studiò mirabilmente le variazioni sotto la luce (cangianti). Esempi fiamminghi (Van der Weyden, Van der Goes) rafforzarono a Firenze il valore della descrizione naturalistica minuziosa e preziosa. Il Mantegna (1431-1506) a Padova tradusse l'insegnamento plastico prospettico di Donatello, di F. Lippi, di A. del Castagno e di Paolo Uccello in una pittura nuova, ricca di colore veneto, e diede il via al superamento a Venezia delle compromissioni bizantine e tardogotiche. Così ad Antonio Vivarini e Jacopo Bellini (inizio sec. XV-ca. 1470) subentrarono Giovanni Bellini (ca. 1430-1516), il primo Lorenzo Lotto (ca. 1480-1556), Carpaccio (ca. 1465-1525 o 1526). Nell'Italia nord-ccidentale il fenomeno fu analogo: a Milano si passò dal Foppa (ca. 1427 o 1430-ca. 1516) giovane a Bramante; infine Leonardo vi propagò le novità sullo sfumato. Tra Piemonte, Lombardia e Liguria fu forte tuttavia la componente franco-fiamminga e tedesca, come attestano via via le opere del Braccesco, di Ludovico Brea (ca. 1450-ca. 1522), del Bergognone, di Defendente e Gaudenzio Ferrari (ca. 1475-1546), ecc. L'influenza aragonese-catalana lasciò nel Quattrocento tracce cospicue in Sardegna (Figuera, Muru), in Campania, in Sicilia: ma Antonello da Messina (ca. 1430-1479) sovrasta solitario in pieno secolo, proponendo dal Sud al Nord lo smaltato verismo lenticolare fiammingo, che permaneva incompreso, fondendolo mirabilmente con il luminismo prospettico pierfrancescano. La svolta dei primi anni del Cinquecento è incomprensibile senza il prepotente accentramento in quel periodo di ricchezze e di artisti a Roma. Qui si erano già trovati uniti umbri e toscani, Botticelli, Signorelli (ca. 1445-1523), Perugino (ca. 1445/50-1523), ecc. sulle pareti della Sistina. A Roma, per lavorare alle Stanze giunse Raffaello, straordinario assimilatore di suggestioni altrui. Nel Vaticano Michelangelo s'incontrò con Giulio Romano, B. Cellini (1500-1571), con Sebastiano del Piombo (ca. 1485-1547) e con Leonardo. Veneti, toscani, umbro-marchigiani si mescolarono così nel crogiuolo infocato dalle sconfinate ambizioni papali. Di fatto si creò uno stile romano-toscano che si irradiò dovunque l'impronta veneta non avesse il predominio. Questo predominio era indubbio a Brescia con il Moretto (ca. 1498-1554) e il Romanino (ca. 1484/87-dopo il 1559), incerto per il Pordenone (ca. 1483-1539), dubbio a Ferrara, dove Dosso Dossi (ca. 1490-1542) mediò Giorgione con Raffaello. Ma era indiscusso a Verona e Venezia: qui Giorgione (ca. 1477-1510), assimilando anche la lezione di Leonardo, creò la pittura di tono, trionfalmente svolta da Tiziano (ca. 1490-1576), dal Veronese (1528-1588), dai Bassano (soprattutto Jacopo, 1510 o 1515-1592). Tintoretto (1518-1594) tentò la sintesi tra il chiaroscuro toscano e il colore veneto giungendo a estremi capolavori (Crocifissione e altri “teleri” della Scuola di S. Rocco a Venezia). L'unilaterale plasticismo di Michelangelo giunto al Giudizio e alla Paolina determinò una larga produzione ideologizzante e arida, un manierismo rituale e controriformistico, diverso da quello di taluni irrequieti artisti del primo Cinquecento come Pontormo (1494-1556), Andrea del Sarto (1486-1530), Beccafumi (ca. 1484-1551). La preziosità raffinata del Vasari (1511-1574) non si sollevò molto su questo livello. Singolare fu Luca Cambiaso (1527-1585), attivo a Genova, morto all'Escorial, volto a combinare curiosamente rigorismo controriformistico, luminismo e schematismi popolareschi. In Emilia il Correggio (ca. 1489-1534), precorrendo lo squisito naturalismo del Parmigianino (1503-1540) e del Mazzola Bedoli (ca. 1500-ca. 1569), unì in sintesi colore veneto e sfumato leonardesco, disegno toscano e idealizzazione umbra. Ricercando il movimento nelle grandi composizioni a fresco pose già nel primo Cinquecento le premesse dei “cieli” barocchi del secolo successivo. Il Rinascimento fu un periodo fiorentissimo anche per le arti minori. L'oreficeria ebbe i suoi massimi esponenti in artisti come il Ghiberti, il Verrocchio, il Pollaiolo, Maso Finiguerra (1426-1464), B. Cellini; la medaglistica rifulse con il Pisanello e Matteo de' Pasti (m. 1486). I mobili rinascimentali, funzionali ed eleganti a un tempo (non per nulla molti di essi furono disegnati da celebri architetti), erano riccamente decorati a intarsio e intaglio; solo a Firenze nella seconda metà del Quattrocento esistevano oltre 80 botteghe di intagliatori e intarsiatori. La ceramica fiorì a Faenza (Bergantini, Casa Pirota), a Firenze (Della Robbia), Cafaggiolo, Deruta, Urbino, Casteldurante (N. Pellipario, ca. 1480-1540/47), Gubbio (Giorgio di Pietro Andreoli, ca. 1465-1553); i vetri veneziani (lattimi, vetri colorati, trasparenti, “mille fiori”, incisi, ecc.) divennero famosi. Nel Cinquecento si sviluppò a Venezia l'arte della trina ad ago, che doveva diventare nel Seicento una vera e propria industria. Nella stessa città fiorì la trina a fuselli, che fu prodotta anche a Milano, a Genova e in tutta la Riviera ligure, a Napoli, a Pescocostanzo, all'Aquila, in Sicilia, ecc.
Arte: l'età barocca
Nel linguaggio michelangiolesco basato sulla grandiosità, la malleabilità e la potenza dinamica delle membrature architettoniche sono in gran parte già implicite le principali caratteristiche barocche: la parete ondulata, il gigantismo degli ordini architettonici, la predilezione per le forme ellittiche, percettivamente assai più dinamiche delle circolari. L'ellisse, adottata sporadicamente all'inizio del Cinquecento (Bramante nel Belvedere e Michelangelo in pianta nel disegno per la tomba di Giulio II), propagata attraverso la pittura da Correggio, realizzata in edifici dello scorcio del secolo (Vignola) guidò a Roma in forma approssimativa o geometricamente esplicita piante e prospetti di Pietro da Cortona (1596-1669; SS. Luca e Martina), di G. L. Bernini (1598-1680, S. Andrea al Quirinale, colonnato di S. Pietro), del Borromini (1599-1667, Oratorio dei Filippini, S. Carlino). Eco della nuova concezione (Keplero, Galileo) dell'ordine cosmico, la nuova architettura si diffuse per circa un secolo e mezzo, esprimendo contraddittoriamente a un tempo il pensiero moderno e il trionfalismo del potere papale, che – attraverso la Controriforma – lo reprimeva. C. Fontana(1634-1714), F. De Sanctis (1693-1740), G. Valvassori (1683-1761), G. Sardi (1680-1753), F. Raguzzini (ca. 1680-1771) e D. Gregorini (1700-1777) a Roma e nel Lazio; G. Guarini (1624-1683), F. Juvara (1678-1736), B. Vittone (1705-1770), B. Alfieri (1700-1767) in Piemonte; L. Vanvitelli (1700-1773) a Napoli si attennero chi più chi meno alla linea barocca. Tuttavia una linea relativamente classicista non venne mai meno, né a Roma con D. Fontana (1543-1607), C. Maderno (1556-1629), C. Rainaldi (1611-1691), N. Salvi (1697-1751), A. Specchi (1668-1729), A. Galilei (1691-1737), F. Fuga (1699-1781), C. Marchionni (1702-1786), né altrove con C. Fanzago (1591-1678) e poi lo stesso Vanvitelli a Napoli, A. di Castellamonte (1618-1683) a Torino, B. Bianco (ca. 1590-1657) a Genova, F. M. Richini (1584-1658) a Milano, G. Silvani (1579-1675) a Firenze, ecc. A Venezia la massima concessione alle idee romane fu rappresentata dal Longhena (1598-1682), che tuttavia non per caso nella chiesa della Salute riesumò piante ravennati, cupole tardobizantine e strutture palladiane. Al Palladio si tornò poi ancora più strettamente nel Settecento con G. A. Scalfarotto (1700-1764), T. Temanza (1705-1789), ecc. fino alla congiunzione con il neoclassicismo vero e proprio. La scultura barocca fu dominata in modo prepotente per quasi due secoli dal genio di G. L. Bernini. La sua abilità e velocità nella lavorazione del marmo, la sicurezza e l'audacia ideativa ed esecutiva furono quasi prodigiose. Espresse dell'arte barocca il simbolismo, il senso di moto senza fine, il trapassare delle forme l'una nell'altra, l'assenza di confini tra realtà e illusione, tra coscienza e sogno (Apollo e Dafne, 1622-25; Beata Ludovica Albertoni, 1671-74). Invano ne emularono l'una o l'altra qualità E. A. Raggi (1624-1686), E. Ferrata (1610-1686), G. F. Parodi (1630-1702), C. Rusconi (1658-1728), P. Bracci (1700-1773), P. Le Gros (1666-1719), G. Sammartino (1720-1793), F. Queirolo (1704-1762). Persino nel Veneto gli furono in qualche modo tributari A. Brustolon (1660-1732) e G. M. Morlaiter (1699-1781). Lo stesso Puget non può essere compreso senza il Bernini. Nonostante ciò la linea classica di S. Maderno (1576-1636) sopravvisse, rappresentata da A. Algardi (1595-1654), che però non sfuggì a talune suggestioni berniniane. Una mediazione gentile e festosa tra le due direttrici fu attuata in Sicilia dal Serpotta (1656-1732), nei suoi famosi stucchi, alla fine dell'età barocca. Il luminismo come tema pittorico (effetti notturni, luci di torce e candele, ecc.) aveva permeato gran parte della pittura del Cinquecento (da Raffaello al Greco, Tintoretto, Bassano). Caricandosi di contenuto drammatico e simbolico, quale ricerca demitizzante di verità non-solare, divenne il motivo di fondo di uno dei massimi innovatori della pittura, Caravaggio (1571-1610). Da questo realismo “dialettico”, alla cui base era lo studio diretto del vero, ma anche una profonda capacità trasfigurante, si sviluppò il filone realista di tutta l'età barocca, e non solo in Italia ma in più parti d'Europa. Roma in particolare fu il grande crocevia dove passarono o sostarono artisti di ogni provenienza, dando vita a un linguaggio ricco e vario di portata internazionale. Il veneto C. Saraceni (ca. 1579-1620) e soprattutto il toscano O. Gentileschi (1563-1639) elaborarono in modo geniale e autonomo il tema della verità delle luci e delle forme. Caravaggeschi in senso più stretto furono G. Baglione (ca. 1573-1664), G. B. Caracciolo (ca. 1578-1635), B. Manfredi (ca. 1580-ca. 1620), il primo G. Reni (1575-1642), e – a dispetto delle dimensioni ridotte, ma trapassando nel generismo – i cosiddetti bamboccianti (M. Cerquozzi, 1602-1660). Variamente dipendenti dallo stesso ceppo sono molti altri: O. Borgianni (1578-1616), A. Gentileschi (1593-1651/52), G. Serodine (1600-1630), G. Assereto (1600-1649). A. Vaccaro (1604-1670), B. Cavallino (1616-ca. 1656), D. Fetti (ca. 1588-1623), J. Liss (ca. 1597-1631), M. Preti (1613-1699). Caratteristica conseguenza del realismo caravaggesco furono la natura morta (fiorentissima, ebbe famosi esponenti nei napoletani G. Recco, 1634-1695, e G. B. Ruoppolo, 1620-1685), le battaglie (S. Rosa, 1615-1673), il ritratto (G. B. Carbone, 1616-1683).
Arte: il Settecento: la pittura
Nel Settecento il filone realista non dipende più dal caravaggismo, salvo che per pochi come G. M. Crespi (1665-1747), M. Benefial (1684-1764), G. Bonito (1707-1789), G. Traversi (ca. 1732-1769), ma si presenta come verismo, dai pittori lombardi “della realtà” come E. Baschenis (1617-1677), V. Ghislandi (1655-1743) e soprattutto G. Ceruti, ai numerosi paesaggisti, come il grande G. P. Pannini (ca. 1691-1765), il modesto ma incisivo G. van Wittel (1653-1736) e i mirabili B. Bellotto (1721-1780) e A. Canaletto (1697-1768), che giunsero a metodi di sistematico rilevamento ottico. Al realismo si opposero sempre una linea classicista eclettica, aulica e ideologizzante, e una linea altrettanto classicista, ma oratoria e trionfalistica, spesso fantasiosa ed estrosa, propriamente barocca. La prima ebbe i suoi antesignani nei bolognesi, dai Carracci a G. Lanfranco (1582-1647), G. Reni, Domenichino (1581-1641), Guercino (1591-1666), F. Albani (1578-1660) e in taluni romani come A. Sacchi (1599-1661), C. Maratta (1625-1713). La seconda trovò la sua massima espressione in Pietro da Cortona, L. Giordano (1634-1705), G. Carpioni (ca. 1613-1674), G. B. Gaulli (1639-1709), A. Pozzo (1642-1709). Luca Giordano fu il degno corrispettivo di G. L. Bernini: di audacia e sicurezza tecnica senza pari, grandioso nell'inventiva, portò la musicalità della sua multiforme e incredibile sintesi pittorica (scuole napoletana, romana, toscana, veneta, ecc.) fino all'Escorial, precorrendo Goya. Dal Giordano furono condizionati gli estremi prosecutori settecenteschi del filone barocco nel Meridione: F. Solimena (1657-1747), F. De Mura (1696-1784), C. Giaquinto (1703-1765). Nel Veneto il dinamismo barocco ebbe nel Settecento sviluppi impensati, fondendo chiaroscuro e colore nell'opera di S. Ricci (1659-1734), G. B. Piazzetta (1683-1754), G. B. Pittoni (1687-1767), G. B. Tiepolo (1696-1770), G. D. Tiepolo (1727-1804). G. B. Tiepolo non fu da meno del Giordano in sicurezza, audacia e inventiva, puntando su un colore sfolgorante, una luminosità diffusa, un chiaroscuro ridotto ad aerea trama disegnativa. Condizionò in tal modo l'arte delle corti europee del Settecento da Würzburg a Madrid, sopravanzando tutti i grandi decoratori tardobarocchi di altre regioni: G. De Ferrari (1647-1726), E. Haffner (1640-1702), D. Piola (1627-1703), i Gandolfi, F. Trevisani (1656-1746), C. F. Beaumont (1694-1766), C. van Loo (1705-1765). Alcuni pittori cercarono una sintesi necessariamente difficile, talvolta acrobatica, tra verismo, idealizzazione classicista, dinamismo e oratoria, e di conseguenza tra pittura di storia e pittura di genere. Questa ricerca fu manifesta in più luoghi, ma animò personalità altrimenti non inquadrabili come quella di S. Rosa e soprattutto di A. Magnasco (1667-1749). Fu peraltro diffusa nella scuola genovese (B. Strozzi, 1581-1644; G. B. Castiglione, 1609-1664; V. Castello, 1624-1659); in taluni bolognesi (parte dell'opera di G. M. Crespi), in taluni veneti (M. Ricci, 1676-1730; F. Guardi, 1712-1793; A. Longhi, 1733-1813; P. Longhi, 1702-1785; R. Carriera, 1675-1757; F. Zuccarelli, 1702-1788, ecc.). Tra i veneti giganteggia tuttavia G. B. Piranesi (1720-1778), che con la sua dirompente produzione grafica portò all'estremo, esaurendole, tutte quelle possibilità di atteggiamento, e diede inizio al neoclassicismo archeologico della fine del Settecento. Per ciò che riguarda le arti minori, nel Sei-Settecento la ceramica ebbe i suoi maggiori centri a Castelli (per opera dei Grue), a Bassano, a Montelupo, a Lodi; la porcellana fiorì a Venezia, a Doccia, a Capodimonte, alle Nove di Bassano. Ebanisti come F. Caffieri (1634-1716), Brustolon, Parodi, Maggiolini (1738-1814) produssero mobili fastosi, splendidamente intagliati (frequente la rappresentazione della figura umana e la decorazione floreale), dorati e laccati (Venezia), arricchiti di connessi di legno pregiato, pietre dure e metalli preziosi. Grande fioritura ebbero l'oreficeria e, a Venezia, i lavori in filigrana.
Arte: il neoclassicismo
I monumenti di Roma antica pubblicati dal Piranesi, la sua architettura di S. Maria del Priorato a Roma, gli scavi di Ercolano e Pompei e le pubblicazioni relative, il conseguente goût à la grecque diffuso in Francia e a Roma e incoraggiato dalla circolazione degli artisti, dei collezionisti e antiquari e dei viaggiatori stranieri in visita per il Grand Tour e di transito per i Balcani e la Grecia, l'opera di numerosi storici e teorici tra cui il Winckelmann e il Milizia, determinarono la svolta culturale nota con il nome di neoclassicismo che investì anche tutti i settori delle arti. Ancora una volta Roma fu grande crocevia culturale internazionale e difficilmente sono distinguibili gli apporti italiani dagli stranieri. In architettura l'idea che occorresse tornare alle forme d'origine escludendo tutte le rielaborazioni medievali, rinascimentali e barocche portò alla riesumazione delle proporzioni vitruviane e dell'ordine dorico e poi egizio (G. Valadier, 1762-1839; L. Canina, 1795-1856); indusse a vagheggiare falansteri e città ideali, pantheon e templi anziché chiese (canoviano a Possagno). Le imprese napoleoniche fecero sì che si erigessero fori (G. A. Antolini, 1756-1841, a Milano) e archi di trionfo (L. Cagnola, 1762-1833). Il ritorno agli ordini antichi rispondeva a un bisogno ideologico laico, illuministico e razionalistico e poi a un bisogno politico. Caduto Napoleone si tornò apertamente ad apprezzare l'arte delle epoche “cristiane” e dunque quella romanza, paleocristiana, romanica, gotica e del primo Rinascimento (donde il romanticismo). La pittura neoclassica italiana ebbe ufficialmente inizio grazie ad apporti stranieri: l'opera di A. R. Mengs (che proseguì poi l'opera del Tiepolo a Madrid), l'esposizione degli Orazi di J.-L. David a Roma nel 1785. Tuttavia già a metà Settecento P. Batoni (1708-1787) aveva trovato accenti decisamente neoclassici e li aveva svolti a un livello qualitativamente ancora sottovalutato. Nell'Italia settentrionale le circostanze politiche non ostacolarono un neoclassicismo privo di autonomia rispetto ai modelli francesi: emersero il grande A. Appiani (1754-1817) e F. Giani (1758-1823), cui si accompagnò in modo naturale l'opera soprattutto grafica di B. Pinelli (1781-1835). A Roma V. Camuccini (1771-1844) seguì rudimentalmente le forme del primo David, adattandole poi a un neoraffaellismo, ma lo contraddissero per tutto il primo Ottocento i puristi, guidati in sordina da Ingres, e raccolti attorno ai nazareni tedeschi (J. F. Overbeck, ecc.) e T. Minardi (1787-1871). Cercarono una sintesi di colore e disegno e pittura di tocco a impianto narrativo i romantici F. Hayez (1791-1882), G. Carnovali (1804-1873), A. Inganni (1807-1880), Domenico (1815-1878) e Girolamo (1825-1890) Induno, G. Gigante (1806-1876) e molti altri che non riuscirono tuttavia a superare il limite di una formazione provinciale. Rappresentata dalla gentile sensualità del Canova (1757-1822), la scultura neoclassica italiana evitò il rigorismo archeologico e le idealizzazioni schematiche dei molti adoratori del nudo greco-romano. Il purismo italiano post-neoclassico è rappresentato da Lorenzo Bartolini (1777-1850), propugnatore a Firenze di un vero che, a metà Ottocento, fu stimolo non secondario a uscire dalle convenzioni romantiche.
Arte: l'architettura dal neoclassicismo al monumentalismo fascista
Superato il periodo neoclassico, l'architettura italiana non ebbe un indirizzo unitario e si ispirò alle diverse espressioni del passato. Per tutto l'Ottocento gli stili architettonici furono considerati una sorta di fondale teatrale e perciò intercambiabili, non necessariamente legati alla contemporaneità. Ciò diede qualche spazio al funzionalismo e all'architettura del ferro che la rivoluzione industriale andava intanto imponendo in Europa, ma dapprima, in Italia come altrove, solo per strutture come ponti, serre e padiglioni di giardini, mercati e stazioni ferroviarie. Quale miglior frutto, si ebbero nel secondo Ottocento le coperture delle molte gallerie cittadine (galleria Vittorio Emanuele II a Milano opera di G. Mengoni). Curioso prodotto dell'uso di tecniche miste nuove e tradizionali fu la Mole torinese di A. Antonelli (1798-1888), una delle costruzioni più ardite del tempo. Nel nostro Paese, però, il peso delle grandi tradizioni del passato e la difficoltà di inserimento e adattamento di edifici nuovi nei centri storici monumentali condizionarono lo sviluppo di un'architettura moderna. Il neorinascimentalismo della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, che ebbe il suo esempio più significativo nel monumento a Vittorio Emanuele II a Roma di G. Sacconi (1854-1905), fu appena intaccato dal florealismo, eco italiana dell'Art Nouveau, che ebbe le sue più notevoli realizzazioni in villa Florio, a Palermo, di E. Basile (1857-1932), in villa Faccanoni, a Sarnico, di G. Sommaruga (1867-1917), e nel complesso per l'Esposizione di Torino del 1902 di R. D'Aronco (1857-1932), l'architetto italiano forse più vicino alla secessione viennese. L'influenza del florealismo si avverte anche nella pittura e nella grafica di M. Dudovich (1878-1962), A. Martini (1889-1947) e A. De Carolis (1874-1928). Dopo il periodo liberty i primi sforzi per il rinnovamento dell'architettura, come di tutte le altre arti, coincisero con il futurismo anche se non si andò oltre i disegni di A. Sant'Elia (1888-1916). Nel 1926 sette giovani architetti, tra i quali G. Terragni (1904-1943) e A. Libera (1903-1963), introdussero in Italia, con la costituzione del “Gruppo 7”, le basi dell'architettura razionalista, critica verso l'Art Nouveau e fautrice di una più stretta adesione alle esigenze poste dalla società industriale e dal nuovo ruolo che in essa assume la città. Dall'attività del gruppo si sviluppò il MIAR (1931) che ebbe ancora in Libera e in G. Pagano (1896-1945) alcune tra le sue maggiori personalità. Il ventennio fascista appare però dominato dalla personalità di M. Piacentini (1881-1960), coordinatore dei maggiori progetti urbanistici dell'epoca (E 42, Università di Roma). Il fascismo, passato da un iniziale appoggio alle nuove tendenze a una sostanziale indifferenza, favorì poi, per esigenza di consenso politico, la grandiosità monumentale e la reviviscenza dell'arte romana. Piacentini, pur adottando un'architettura monumentale, nei grandi progetti da lui pianificati, fu mediatore e compositore di diversi indirizzi e accolse suggestioni razionaliste come, del resto, i razionalisti non furono esenti da suggestioni monumentali: si veda per esempio Terragni nel monumento ai caduti di Como.
Arte: dai macchiaioli al divisionismo
Dalla seconda metà dell'Ottocento, mentre il realismo diventava una componente importante della ricerca artistica europea, l'arte italiana, improntata a una buona dose di retorica, cominciava ad accumulare un certo ritardo culturale nei confronti del resto d'Europa e della Francia in particolare. L'eccezione più significativa fu costituita dal gruppo dei macchiaioli riunito a Firenze tra il 1855 e il 1867: ne fecero parte, tra gli altri, i toscani C. Banti (1824-1904), G. Fattori (1825-1908), S. De Tivoli (1826-1892), T. Signorini (1835-1901), A. Cecioni (1836-1886), V. D'Ancona (1825-1884), gli emiliani S. Lega (1826-1895) e G. Boldini (1842-1931), il romano G. Costa (1826-1903), il veneto V. Cabianca (1827-1902), il napoletano G. Abbati (1836-1868). Gli scambi più intensi del gruppo avvennero con gli artisti napoletani e meridionali soprattutto quando Cecioni insieme a G. De Nittis (1846-1884), M. De Gregorio (1829-1876) e F. Rossano (1835-1912) fondò a Napoli una scuola di paesaggio, nota come Scuola di Resina. I temi prediletti dai macchiaioli erano il paesaggio, le scene di vita quotidiana e la storia, trattati semplificando la rappresentazione pittorica e traducendo la sensazione visiva in una serie di “macchie”. Dopo il 1870 il realismo entrò in crisi e si svilupparono il movimento della scapigliatura e, alla fine del secolo sempre a Milano, il divisionismo, teorizzato da G. Previati (1852-1920) e fondato sui principi della scomposizione del colore attraverso l'uso di una pennellata filamentosa. A. Morbelli (1853-1919), G. Segantini (1858-1899), E. Longoni (1859-1932), P. Nomellini (1866-1943), G. Pellizza da Volpedo (1868-1907) adottarono la luce come tema delle loro ricerche, simbolo dell'immaterialità dell'emozione, del pensiero, dell'ideale fusione uomo-natura. Con il tempo affrontarono sia l'indagine e i temi sociali sia tematiche allegoriche più strettamente legate al simbolismo. Dalle vicende pittoriche trassero spunti per un trattamento mosso e scabro della forma gli scultori del secondo Ottocento e del primo Novecento: G. D. Grandi (1843-1894), P. Troubetzkoy (1866-1938), A. D'Orsi (1845-1929). L'artista che raccolse veramente le migliori suggestioni di Grandi fu M. Rosso (1858-1928) di solito collegato al movimento impressionista per il suo luminismo. Nello stesso ambiente napoletano in cui operò D'Orsi si inserisce invece V. Gemito (1852-1929), scultore di gusto più classico.
Arte: le avanguardie
Il futurismo e la pittura metafisica costituiscono i due più importanti contributi dell'arte italiana all'evoluzione delle avanguardie europee. Il futurismo nacque nel 1909 per iniziativa di F. T. Marinetti (1876-1944): vi aderirono G. Balla (1871-1958), C. Carrà (1881-1966), U. Boccioni (1882-1916), G. Severini (1883-1966), L. Russolo (1885-1947). Il futurismo si presenta come proposta integrale di rinnovamento artistico, culturale e di comportamenti, improntati a sfrenato dinamismo e attivismo vitalistico, di cui discende la totale identità tra arte-vita, che gli permette di operare una grande rivoluzione: l'estensione del concetto di arte a ogni contesto dell'esistenza. Per contro la pittura metafisica aspira a superare i limiti del visibile e a scoprire il senso profondo, spesso inquietante delle cose; ne fu massimo esponente G. De Chirico (1888-1978). Nato in Grecia da genitori italiani, dopo un soggiorno a Milano e a Firenze, nel 1911, si trasferì a Parigi, dove, in un clima di fervida sperimentazione e dopo gli incontri con Picasso e Apollinaire, portò a maturazione la sua poetica. La sua pittura si precisa e si arricchisce sul piano iconografico e si combina in atmosfere prima rarefatte e malinconiche, poi, con l'approssimarsi della guerra, sempre più cupe e angoscianti. La prima guerra mondiale determinò in molti protagonisti delle cosiddette avanguardie storiche una profonda crisi artistica: costoro avevano in molti casi partecipato alle vicende belliche, spesso sostenendo la necessità della guerra o addirittura esaltandone le valenze estetiche; posti di fronte all'orrore della guerra molti cambiarono idea, sicché si assiste a un generale movimento di "ritorno all'ordine". Si trattò di un periodo di riflessione per la cultura europea, che avvertì il bisogno di ritrovare nella tradizione o nella storia quei "valori" antichi e solidi sui quali si fonda l'attività artistica. La rivista che meglio espresse il nuovo clima di ricerca fu Valori Plastici fondata da Mario Broglio, il cui primo numero uscì nel novembre del 1918. I più attivi collaboratori furono i già ricordati C. Carrà e G. De Chirico e G. Severini accanto a G. Morandi (1890-1964), le cui opere tra il 1914 e il 1925 segnarono il passaggio dalla metafisica al realismo magico, A. Savinio (1891-1952), A. Martini, che esplora la scultura cinese e quella etrusca, i bronzi ellenistici e le terrecotte, con spirito originale. Un altro esponente significativo di tale ricerca, fu il torinese F. Casorati (1886-1963), che riflette sulla lezione di Piero della Francesca, mentre a Milano M. Sironi (1885-1961), approdato a una pittura dominata dalla malinconia e dalla geometria (L'Allieva, 1924), partecipava, nel 1922, alla fondazione del gruppo che si definì Sette pittori del Novecento, sostenuto dalla critica d'arte e scrittrice M. Sarfatti. Ne facevano parte, oltre a lui, P. Marussig (1879-1937), G. L. Malerba (1880-1926), L. Dudreville (1885-1975), A. Bucci (1887-1955), U. Oppi (1889-1942), A. Funi (1890-1972). Il gruppo ebbe vita breve, ma fu il primo passo verso il tentativo della Sarfatti di creare un movimento su scala nazionale, il Novecento Italiano, che verso la fine degli anni Venti dominò il panorama artistico nazionale. Le mostre in Italia e all'estero, le importanti commissioni nel campo della pittura murale, il tanto decantato ritorno ai valori "classici e mediterranei", finirono per far nascere uno stile retorico e monumentale, molto spesso asservito agli scopi politici del regime. Una delle prime reazioni a questo stato di fatto venne da un gruppo di giovani artisti romani, la cosiddetta Scuola di via Cavour che riuniva le ricerche espressioniste di M. Mafai (1902-1965), di Scipione Bonichi (1904-1933), di A. Raphaël (1900-1975) e di M. Mazzacurati (1908-1969). La rapida maturazione artistica del gruppo, la cui storia si colloca tra il 1924 e il 1933 (anno della morte prematura di Scipione), fu favorita da un clima molto stimolante nato dal desiderio di raccogliere l'eredità più autentica delle ricerche italiane del primo dopoguerra e, insieme, di lavorare in una dimensione europea. Numerosi artisti italiani si trasferirono così a Parigi, acquisendo una particolare identità culturale; il rapporto tra gli artisti italiani e la cultura francese, però, non fu sempre facile: alcuni, come L. Viani, ebbero difficoltà di adattamento ma altri trovarono nella capitale francese un ambiente congeniale e fecondo: M. Rosso, A. Modigliani, G. Severini, G. De Chirico, A. Savinio. Anche un piccolo gruppo di artisti astratti che esponevano presso la galleria milanese "Il Milione" negli anni Trenta fece proprio il tentativo di abbandonare la retorica dell'arte classica italiana: O. Licini (1894-1958), A. Soldati (1896-1953), M. Reggiani (1897-1980), V. Ghiringhelli (1898-1964), L. Fontana (1899-1968), F. Melotti (1901-1986), L. Veronesi (1908-1998); a Como troviamo un grande architetto della corrente razionalista, G. Terragni accanto ai pittori M. Radice (1900-1987) e M. Rho (1901-1957). Un altro tentativo di rompere con la tradizione di Novecento, fu quello del gruppo dei Sei pittori, che si formò a Torino nel 1928 costituito da J. Boswell (1881-1956), N. Galante (1883-1969), L. Chessa (1898-1935), F. Menzio (1899-1979), E. Paulucci Delle Roncole (1901-1999) e C. Levi (1902-1975). Costoro si trovarono a operare in un clima culturale molto vivace e aperto, in contatto con personalità di primo piano, quali A. Gramsci, P. Gobetti, L. Venturi, E. Persico. Nell'ambito di questa nuova dimensione di ricerca si pongono anche i cosiddetti "chiaristi" lombardi, Lilloni e Del Bon, e il cosiddetto "tonalismo" romano. Tra il 1931 e il 1933 la compagine della Scuola Romana si precisò in quelli che ne furono i primi e più originali interpreti: R. Melli (1885-1958), F. Pirandello (1899-1975), G. Capogrossi (1900-1972), M. Mafai, A. Ziveri (1908-1990), C. Cagli (1910-1976), Mirko (1910-1969) e Afro Basaldella (1912-1976) . Una serie di avvenimenti, quali la guerra d'Etiopia, le sanzioni economiche, la proclamazione dell'impero, la guerra di Spagna, l'accordo con la Germania di Hitler, l'emanazione delle leggi razziali, finirono però per incrinare la fiducia nel regime fascista e per diffondere un senso di inquietudine nella società che presto si avvertì anche nell'arte traducendosi in un desiderio di maggiore aderenza alla realtà. La pittura e la scultura riportarono il centro dell'interesse sulla linea che dal romanticismo conduce al realismo e all'espressionismo, rivendicando l'importanza della partecipazione alla storia e dell'impegno sociale e politico. Nel 1938 apparve a Milano la rivista Corrente di vita giovanile, fondata dal diciottenne Ernesto Treccani, che riunì numerosi artisti giovani. L'attività di Corrente fu in parte finanziata dall'industriale e collezionista Alberto Della Ragione, in parte si autofinanziava ed era appoggiata da critici militanti come R. De Grada (1885-1957), M. De Micheli (1914-2004), D. Morosini. Il lavoro dei giovani artisti di Corrente coinvolgeva parallelamente i contenuti e le forme espressive: i temi preferiti tendevano a essere quelli ritenuti "emblematici" del presente. In questo periodo le avanguardie pittoriche romane e milanesi avvertirono la necessità di un più stretto confronto e R. Guttuso (1912-1987) fu certamente uno dei maggiori tramiti. Rompendo con il pittoricismo e con i rabeschi musicali del florealismo (L. Bistolfi, 1859-1933), i futuristi diedero alla scultura italiana idee e stimoli soprattutto attraverso il dinamismo plastico di U. Boccioni. Il richiamo all'ordine intervenuto durante e dopo la prima guerra mondiale favorì un classicismo riformato, arcaista ed estroso nelle sue punte migliori (A. Martini).
Arte: la ricerca artistica nel secondo dopoguerra
Alla fine della seconda guerra mondiale il moltiplicarsi dei contatti internazionali e la complessa vicenda politica rimescolarono gli schieramenti e generarono aspre polemiche. I giovani artisti, in particolare, sentirono l'esigenza di "rifondare" il linguaggio artistico confrontandosi con l'Europa, con gli Stati Uniti e con l'avanguardia storica del cubismo e di collegare la prassi artistica a un'azione politica orientata a sinistra. Tra il 1945 e il 1950 si formarono e si sciolsero vari gruppi che spesso accompagnarono e “spiegarono” le loro opere con dichiarazioni di intenti e manifesti. Elementi di innovazione sono contenuti nelle ricerche di L. Fontana e di A. Burri (1915-1995). Nel 1949 Fontana realizzava, a Milano, il primo Ambiente spaziale a luce nera di Wood e sperimentava le possibilità dei suoi celebri "buchi" e “tagli", ai quali ultimi lavorò dal 1964 alla morte. Come avviene nell'action painting, anche in questo caso la tela va intesa come luogo di un evento: bucando ripetutamente la tela, Fontana applica la sua "energia" a una superficie che, così, diviene trasparente, lascia passare la luce o fa intuire quello che c'è al di là. Per quel che riguarda Burri, egli all'inizio lavorò soprattutto sulle proprietà fisiche dei colori modificandole: nacquero così i Neri, in cui l'artista gioca con la qualità, la consistenza, la maggiore o minore opacità, le screpolature delle vernici; le Muffe, in cui degli additivi presenti nel pigmento, creano fioriture di colore simili a culture batteriche e i Catrami, che già nel 1951 propongono il fascino della materia monocroma. Allo stesso periodo risalgono i Gobbi, in cui dei rami inseriti tra tela e telaio danno alle pitture un inquietante rilievo scultoreo e i celeberrimi Sacchi. La serie delle sue straordinarie invenzioni prosegue con le Combustioni e i Ferri alla fine degli anni Cinquanta, poi vengono i Legni e le Plastiche dall'inizio degli anni Sessanta, i Cellotex, i Cretti e infine le ultime coloratissime pitture sintetiche. Il suo lavoro è la storia di un lungo dialogo con la materia. Si rammentano poi le ricerche di E. Vedova (n. 1919), Afro Basaldella, G. Capogrossi, che molto presto stringono rapporti con l'Europa e gli Stati Uniti. Alla fine degli anni Cinquanta la realtà sociale e politica italiana era in in rapida trasformazione: sono gli anni del "miracolo economico", della vertiginosa industrializzazione e modernizzazione. Lo strumento più idoneo a combattere i nuovi miti della società dei consumi è lo spirito dissacrante, ironico, blasfemo adottato da alcuni artisti. Una via estremamente radicale è quella percorsa da P. Manzoni (1934-1963), che prende le mosse dalle soluzioni più estreme di Fontana. Manzoni "presenta", togliendoli dal loro contesto abituale, oggetti come il pane o le pietre, e anche elementi base dell'operazione artistica, come la linea. L'artista fa poi i conti con il pubblico e con il mercato dell'arte, producendosi in una serie di performances: realizza le famose scatolette di escrementi vendendole letteralmente "a peso d'oro", cioè al prezzo corrente giornaliero dell'oro; inventa le "basi magiche" che trasformano in opera d'arte qualsiasi cosa venga a trovarcisi sopra. Manzoni "firma" le persone che salgono sulla sua base e rilascia una ricevuta di autenticità. Infine, la “base del mondo", un parallelepipedo di ferro collocato nel parco di Herning, presenta capovolta la scritta: Socle du monde, socle magic n. 3 de Piero Manzoni-1961 Hommage a Galileo.
Arte: l’architettura dall’eclettismo del dopoguerra al postmoderno
Nel dopoguerra la fase più feconda del razionalismo italiano poteva dirsi conclusa, anche se il patrimonio di esperienze ha offerto un importante contributo alle tendenze maturate successivamente; echi dell'architettura “organica” e neoliberty (B. Zevi, 1918-2000), alternandosi a proposte neofunzionaliste (P. L. Nervi, 1891-1979; R. Morandi, 1902-1989) o neorazionaliste (L. Quaroni, 1911-1987) hanno cercato, purtroppo con esito dubbio, di salvare l'architettura moderna italiana dalla mancanza di un'organica pianificazione urbanistica e territoriale. Ed è proprio nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica che, a partire da questi anni, si è svolto il dibattito politico e culturale più intenso. La crescita demografica e quella dimensionale delle città, infatti, costituivano ormai continua materia di riflessione teorica e progettuale per l'architetto considerato come “regista dello spazio”: in quest'ambito assume un particolare rilievo la figura di A. Rossi (1931-1997), cui si può ascrivere la nascita di un “secondo” razionalismo italiano, che prende l'avvio nel 1966 con la pubblicazione di L’Architettura della città (l'altro testo fondamentale per il movimento, La costruzione logica dell’architettura, venne pubblicato da G. Grassi l'anno successivo) in cui lo studioso sottolinea l'esigenza di mettere in relazione analisi urbana e progettazione architettonica. Tra i suoi numerosi progetti si ricordano l'unità residenziale al quartiere Gallaratese a Milano (1969-73), il cimitero di Modena (1971-78) e il Teatro del Mondo a Venezia (1979-80). Il più noto progettista della “scuola ticinese”, di matrice neorazionalista, è M. Botta (n. 1943), che propone un'architettura di forme pure e il ricorso a nuovi materiali (di lui si ricorda il Mart di Rovereto, 2002). A partire dagli anni Settanta l'azione di denuncia di vari architetti-urbanisti (C. Aymonino, n. 1926; L. Piccinato, 1899-1983; G. Samonà, 1898-1983) e il nuovo peso assunto dagli enti locali nell'amministrazione del territorio hanno impresso un'inversione di tendenza rispetto alla caotica e talora illegale espansione edilizia degli anni Sessanta; si è iniziato a operare secondo una linea di programmazione territoriale, di salvaguardia e ristrutturazione dei centri storici, di contenimento dell'espansione irrazionale delle periferie urbane, di controllo sugli insediamenti residenziali nelle zone turistiche, per salvare, dove è possibile, quell'equilibrio di natura e cultura che ha caratterizzato nel tempo l'immagine migliore del Paese. Questi sono stati anche gli anni di incubazione del postmodernismo, diffusosi negli anni Ottanta, a livello internazionale. Un ruolo importante nell'affermazione del movimento postmoderno in Italia, e in Europa, è stato svolto da P. Portoghesi (n. 1931) che, con la prima Mostra Internazionale di Architettura, intitolata “La presenza del passato”, allestita alla Biennale di Venezia del 1980, ha ufficializzato la nascita del movimento. Caratteristiche essenziali ne sono un atteggiamento di recupero critico della storia, delle tradizioni locali, e una riflessione sulle forme e sui codici ereditati dal passato in aperta polemica con la condizione “moderna” che invece aveva prediletto l'esaltazione della tecnologia e del progresso. Lo stesso Portoghesi con le sue realizzazioni, tra cui casa Baldi (1959) e la moschea di Roma (1976), supera i rigidi canoni modernisti attraverso il recupero della tradizione come espressione sia della memoria collettiva sia della libertà compositiva. Ma sono l'apertura di nuovi musei e la trasformazione di vecchi edifici in moderne sedi espositive ad assumere un ruolo decisivo nella riqualificazione urbanistica. La propensione a realizzare, ingrandire e trasformare le istituzioni museali ha segnato una svolta cruciale nell'attuale concezione dell'architettura della città, ne è un esempio la trasformazione in tal senso delle Scuderie del palazzo del Quirinale a Roma (1999) a opera dell'architetto italiano G. Aulenti (n. 1927), che già precedentemente aveva trasformato a Parigi una stazione ferroviaria della fine dell'Ottocento, la Gare in museo (Musée d'Orsay, 1980-87). Alla fine del Novecento si può parlare di un “nuovo internazionalismo” diverso nei linguaggi ma con idee critiche comuni nei confronti della storia, della modernità e dello spazio urbano. Questo internazionalismo, globale e globalizzante, ha però bisogno di un più ampio nutrimento locale, laddove l'architettura italiana manifesta un forte disagio derivante sia dalla struttura conservativa del mercato edilizio sia dall'evoluzione lenta delle istituzioni culturali, accademiche e amministrative. Fatta eccezione per il successo internazionale degli incarichi commissionati a R. Piano (n. 1937), dal Lingotto di Torino (1983-95) all'Auditorium Parco della Musica di Roma (1994-2003) alla chiesa edificata a San Giovanni Rotondo a Foggia (1991-2004;), per l'attività isolata di M. Fuksas (n. 1944) più attivo all'estero che in Italia (Centro Congressi Italia a Roma, 1999-2004) e per quella di F. Purini (n. 1941), forse l'unico capace di dialogare con le ricerche della “nuova avanguardia” internazionale sul piano del discorso architettonico e urbano (complesso residenziale Marianella a Napoli insieme a L. Thermes con la quale si è associato nel 1966), non sono molti gli architetti italiani che hanno prodotto idee originali e progetti di livello internazionale. Il dibattito sulle scelte da operare nelle realtà urbane, la riqualificazione delle periferie, il restauro, l'attenzione alle nuove tecnologie sono ormai i grandi temi su cui l'architettura si deve interrogare.
Arte: lo sviluppo del design
Con l'affermarsi del razionalismo l'industrial design iniziò ad acquisire una propria identità e autonomia, anche se fu solo a partire dal secondo dopoguerra che si registrarono le produzioni più interessanti che determinarono l'ascesa del nostro Paese a un ruolo di leadership internazionale. Il settore dell'autovettura con G. Bertone (1914-1997), Pininfarina e G. Giugiaro (n. 1938), quello del mobile con Acerbis, M. Bellini (n. 1935), V. Magistretti (1920-2006), gli oggetti d'uso elettrici ed elettronici di Achille (1918-2002) e Pier Giacomo (1913-1968) Castiglioni, di Casati, di Ponzio, di M. Zanuso (1916-2001) che coniugano il portato tecnologico con le esigenze dell'arredamento, le fonti di luce destinate a costituire oggetti d'arredamento anche da spente con P. Manzù (1939-1969), B. Munari (1907-1998) e G. Colombo (1937-1993) sono state le punte avanzate del design italiano. Dalla seconda metà degli anni Sessanta esso cominciò a seguire due fondamentali direzioni: da un lato, in contrapposizione al razionalismo, sentì l'esigenza di confrontarsi con altre tipologie e forme del passato; dall'altro si fece carico di istanze tipiche dei movimenti artistici d'avanguardia che andavano dal futurismo alla pop art. Un'esperienza limitata nel tempo, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, ma importante per i successivi esiti postmoderni del design è rappresentata dal radical design dei gruppi fiorentini Archizoom, Superstudio e UFO e del torinese Studio 65. Nel passaggio dalla modernità alla postmodernità ha avuto un enorme rilevanza E. Sottsass (n. 1917), la cui infaticabile attività ha spesso tracciato la strada ai più importanti designers del nostro Paese. L'intervento dell'informatica, dell'elettronica e l'impiego dei nuovi materiali che si sono affacciati nella progettazione sia degli oggetti d'uso domestico sia delle autovetture, introducendo il controllo e la programmazione delle funzioni, ha aperto nuove possibilità trasformando i tradizionali oggetti d'uso (si pensi al televisore dallo schermo ultrapiatto).
Arte: tra Gestalt e pop art
Gli anni Sessanta rappresentano uno dei momenti più vitali e originali nella vicenda dell'arte contemporanea. Un segno preciso di questo desiderio di ricominciare da capo, di ritrovare una specie di "verginità" per l'operazione artistica è dato dalla diffusione del "monocromo" in pittura e delle "strutture primarie" nella scultura (Scarpitta, Uncini, Castellani, Lo Savio, Paolini, Festa, Schifano, Angeli, Mauri). Da questa ricerca si dipartono due grandi linee di tendenza. La prima viene definita ipotesi gestaltica (Gestalt=forma) e in essa confluiscono le ricerche di arte programmata, arte cinetica e lo studio delle strutture primarie in scultura. Il gestaltismo, nel pensiero di Argan, è in fondo l'ultima manifestazione di quella utopia razionalista della quale lo storico ricostruiva, in quel periodo, il percorso dal neoclassicismo al Bauhaus, a Mondrian, in alternativa al "barocco moderno" rappresentato dalla pop art e dalle sue derivazioni europee. A fronte di questo indirizzo se ne sviluppa un altro, strettamente collegato con la pop art internazionale, anche se su un piano di grande originalità. Gli artisti che ne fanno parte, da Schifano ad Angeli, da Festa a Pascali, vivono la loro condizione di artisti in modo molto più "romantico", assorbono e divorano i miti della propria epoca, consumano la loro esperienza con un ritmo esistenziale e frenetico, che in alcuni casi li conduce alla morte precoce. In questo caso disimpegno significa non avere più certezze, neanche nei nuovi miti della società di massa. Questa ideologia spiega l'atteggiamento critico anche nei confronti della pop art americana e un certo pessimismo di fondo. La Koka-kola di Schifano è molto più "dura" della coca-cola di Andy Warhol, perchè in fondo è la coca-cola di un paese colonizzato dall'America. L'altro elemento di distinzione rispetto al movimento americano è la presenza della storia e soprattutto della storia dell'arte, elementi dominanti nel nostro Paese attraverso la riproduzione in serie, fino ad assumere lo stesso valore visivo e sociale dei prodotti industriali. Per fare un esempio le immagini della Cappella Sistina moltiplicate da T. Festa (1938-1988), hanno lo stesso valore delle saponette o della coca-cola. Il forte rapporto con la storia si avverte anche sul piano linguistico. I giovani artisti della Scuola di piazza del Popolo si volgono con spirito rapace e vitale al futurismo e alla metafisica. M. Schifano (1934-1998) studia G. Balla, le sue linee di forza compaiono in molti dipinti dei primi anni Sessanta, e anche i "paesaggi" risentono di una visione dinamica: sono i paesaggi frammentari intravisti dal finestrino di una automobile in corsa, magari su quell'autostrada del Sole che, inaugurata nel 1963, modifica profondamente la fruizione visiva del paesaggio italiano. Tra i primi a rendersi conto delle nuove strade che si aprono con l'annullamento delle barriere tra pittura e scultura, tra oggetto dipinto e oggetto trovato, è P. Pascali (1935-1968). Utilizzando l'environment, le Armi e il Mare propongono un nuovo rapporto tra il pubblico e l'opera d'arte: lo spettatore è invitato a entrare in contatto fisico con l'opera. Verso la fine degli anni Sessanta si assiste in Europa e negli Stati Uniti a una tendenza comune verso un superamento dei confini tra il mondo dell'arte e quello della vita.
Arte: lo sviluppo dell'arte povera e di quella concettuale
Nel 1967 il critico d'arte G. Cèlant, riferendosi al teatro povero di Jerzy Grotowski, coniò il termine arte povera per designare quel movimento che include, tra gli altri, M. Merz (n. 1931), M. Pistoletto (n. 1933), A. Boetti (1940-1994), e anche, inizialmente, M. Ceroli (n. 1938), P. Gilardi (n. 1942) e molti altri. Si tratta di un'area di ricerca strettamente legata alle esperienze europee e statunitensi della process art, land art e della conceptual art. L'arte povera intende svolgere una riflessione su temi fondamentali dell'esistenza umana: il rapporto con la natura e con i suoi elementi primari (terra, acqua, fuoco, aria, animali); la conoscenza e il pensiero, la morte; la cultura umana e la storia; è ‘povera' in quanto cerca di ritornare alle radici, alle situazioni elementari. Una delle creazioni più emblematiche di questa nuova ricerca sono gli Igloo di M. Merz, costruiti con pezzi di vetri rotti, pezzi di lamiera, neon, fascine, pelli, portiere di automobili. L'idea è quella ‘primordiale' (povera) del nomade che progetta ogni giorno la propria esistenza, riciclando, nel caso di Merz, i materiali della società industriale. Molto forte, all'interno delle ricerche di arte povera, è la tensione dialettica che si realizza tra la materia, o meglio le materie con le loro energie specifiche, i loro significati simbolici e mitici e il pensiero, come energia organizzatrice. In effetti il modello al quale si rifanno molti artisti dell'arte povera è l'alchimia, sia nelle sue radici storiche sia nella sua versione moderna elaborata da Duchamp. Per esempio, Pascali propone una nuova versione del Mare, non più "scolpito" ma evocato con dell'acqua tinta all'anilina e inserita in eleganti percorsi geometrici. M. Pistoletto, nel 1962, ha cominciato a produrre la serie delle opere "a specchio", nelle quali le figure fotografate e ritagliate vengono applicate su lastre di acciaio lucido e riflettente: in questo modo l'immagine perde la sua fissità e viene integrata dalla presenza dello spettatore e dallo spazio esterno. In molti casi l'elemento intellettuale dell'operazione artistica è talmente forte che si è parlato di arte concettuale, e proprio l'aspetto concettuale è divenuto, specie nel corso degli anni Settanta, dominante. Si pensi alle realizzazioni di Boetti o a quelle degli epigoni dell'americano Joseph Kosuth. Del primo si vuole ricordare Manifesto, un poster su cui sono scritti i nomi di sedici artisti, a ciascuno dei quali è abbinata una serie di massimo quattro simboli. Quando fu esposta l'opera suscitò un vivace interesse, tuttavia Boetti non rivelò mai la chiave di interpretazione dei segni, depositata presso un notaio. Per quel che riguarda i secondi essi imparano a giocare con il linguaggio, proponendo percorsi dalla parola, all'immagine, all'oggetto. Si va dagli esperimenti di poesia visiva, come quelli di E. Isgrò (n. 1937), a opere basate su giochi di parole come Mozzarella in carrozza di G. De Dominicis (1947-1998), che non è altro che la traduzione fattuale di una definizione (una vera mozzarella in una vera carrozza). Tra i più convincenti protagonisti dell'arte concettuale va ricordato G. Paolini (n. 1940), che indaga sui meccanismi di visione e di fruizione dell'opera d'arte. Partendo (tra il 1960 e il 1965) da una lucida analisi degli strumenti del dipingere e dei rapporti tra chi guarda e l'opera stessa, egli ha analizzato i grandi enigmi dell'arte: il doppio, la specularità (Mimesi) la permanenza di immagini "senza tempo" (i calchi delle statue classiche), il rifiuto del "finito" (la frantumazione de Lo sguardo della Medusa).
Arte: le tendenze più recenti dell'arte contemporanea
Verso la fine degli anni Settanta si delineò una reazione al clima di ricerca fortemente concettuale. Dopo gli ultimi fuochi del terrorismo, con la sua inutile e controproducente esibizione di violenza, in Italia si assiste a un'altrettanto deprimente corsa verso i nuovi miti del successo, dello "yuppismo", dell'"edonismo reaganiano", stimolati dalla forte ripresa economica. A interpretare questa nuova fase culturale c'è la cosiddetta transavanguardia, promossa da A. Bonito-Oliva, che sceglie appena cinque artisti: S. Chia (n. 1946), M. Paladino (n. 1948), E. Cucchi (n. 1950), F. Clemente (n. 1952), N. De Maria (n. 1954). Il prefisso "trans" vuole dare l'idea dell'"attraversamento" dell'arte in tutte le direzioni: l'arte appare come un patrimonio sterminato da esplorare e da saccheggiare, viaggiando nello spazio e nel tempo e anche in linguaggi diversi, tutto può essere usato per i propri fini. Il quadro funziona da "domasguardi", cioè doma lo sguardo inquieto dello spettatore, perdendo così il lato problematico, tanto caro all'arte degli anni Sessanta e Settanta. In S. Chia manualità e concetto, volubilità dello stile, opulenza, cura del particolare, linguaggi cosmopoliti differenti (dai fauves ai simbolisti, da Chagall a Picasso e poi Cézanne, De Chirico, Carrà, Sironi, ecc.), si mescolano per creare una sorta di "macchina della pittura" produttrice di immagini appagate dalla materia di cui sono costituite. M. Paladino fa emergere nella sua pittura i miti e le leggende della sua terra d'origine, la Campania, tornando spesso sul tema del "banchetto rituale". Anche nel suo caso ci troviamo di fronte a un eclettismo sfrenato, che coniuga Matisse e Malevič, i graffiti newyorkesi e la cultura dell'Italia meridionale. Anche più eclettico appare F. Clemente, che sceglie addirittura di vivere in una dimensione sdoppiata: un po' a New York, un po' in un villaggio dell'India, dove può imparare dagli artigiani del luogo un approccio "tradizionale", rifacendo delle antiche miniature e datandole tranquillamente "1581-1981". Cucchi è certamente uno dei maggiori esponenti in questi ultimi anni. Dotato di un grande potere inventivo, lavora benissimo sia nelle piccole dimensioni del disegno, riempiendo centinaia di fogli con le sue invenzioni, sia in quelle grandissime della pittura ambientale. Un fenomeno molto comune nelle ricerche degli anni Ottanta è quello della "citazione", ovvero la ripresa evidente di stili o di iconografie del passato antico e recente. Per esempio L. Ontani (n. 1943), utilizza generi espressivi diversi: dal tablaux vivant alla fotografia, dalla pittura al simulacro in terracotta policroma, fino al video. Egli cita la storia dell'arte, la mitologia, la storia, la religione e perfino il mondo del fumetto e della musica lirica; ma ben presto comincia a citare se stesso. Il "ritorno" alla pittura e alla scultura ha una delle sue manifestazioni più eclatanti, nel corso degli anni Ottanta, nel fenomeno del cosidetto ipermanierismo, conosciuto anche con altri nomi, quali anacronismo, pittura colta o nuova maniera. L'ipermanierismo nasce da una costola dell'arte concettuale: oltre a G. Paolini vanno ricordati i concettuali V. Pisani, C. Parmiggiani e C. M. Mariani. La nascita del movimento è piuttosto complessa. Un ruolo pioneristico va riconosciuto al gallerista P. De Martiis, che già nel 1978 invitò a esporre F. Piruca nella sua galleria, La Tartaruga. Un altro gruppo si forma, nel 1980-81, con l'appoggio di M. Calvesi, che conia l'etichetta di anacronisti. Altro critico interessato al fenomeno fu I. Mussa, che nel 1982 organizza a Roma una collettiva di C. M. Mariani (n. 1931), R. Barni (n. 1939), U. Bartolini (n. 1944), A. Abate (n. 1946) intitolandola "La pittura colta". Dagli anni Ottanta si nota un veloce e costante ricambio generazionale che porta alla ribalta artisti come M. Cattelan e V. Beecroft, i quali si dividono con grande successo tra l'Italia e New York. Altri artisti da non trascurare, solo per fare qualche esempio, sono Cristiano Pintaldi, Adrian Tranquilli, Stefano Arienti. Infine vanno citate le ricerche nel campo dell'arte elettronica, di cui un valore certo è il gruppo milanese Studio Azzurro.
Musica: dal canto gregoriano alle frottole
I secoli più antichi della musica in Italia coincidono con la formazione del repertorio liturgico cattolico. Nel suo filone principale esso prende il nome di canto gregoriano, mentre a partire dal sec. IV si sviluppa a Milano come tradizione in parte indipendente il canto ambrosiano. Le origini del canto gregoriano, canto liturgico ufficiale della Chiesa cattolica romana, sono oggetto di discussioni: c'è chi mette in dubbio il contributo di Gregorio Magno (ca. 540-604) alla codificazione del repertorio. Resta comunque il fatto che nel periodo di massima fioritura del canto detto gregoriano i principali centri italiani (i conventi di Nonantola, Bobbio e Montecassino) non ebbero l'importanza dei maggiori conventi tedeschi, svizzeri e francesi. Italiano è invece Guido d'Arezzo (forse 997-1050), cui si devono la sistemazione dell'esacordo e la definitiva introduzione del rigo nella notazione. Di origine italiana sono anche alcune sequenze tarde, come il Dies irae di Tommaso da Celano (ca. 1190-ca. 1260) e lo Stabat mater di Iacopone da Todi (ca. 1236-1306); nel sec. XIV è testimoniata anche una ricca fioritura di drammi liturgici. In campo profano si hanno scarse testimonianze anteriori al sec. XIII. Nell'Italia settentrionale e in Sicilia vi fu una certa diffusione della civiltà trovadorica, con Sordello da Goito (ca. 1200-ca. 1269) e Lanfranco Cigala (m. 1257/58). A radici popolari si legò invece il fenomeno tipicamente italiano delle laude, canti monodici in volgare ispirati a una visione religiosa che traeva origine dal movimento francescano, diffuse soprattutto in Umbria e tramandate da laudari come quello di Cortona (sec. XIII) e il Magliabechiano di Firenze (sec. XIV). Le melodie fondevano elementi di ascendenza gregoriana e inflessioni di carattere più popolare e profano. Il momento culminante e conclusivo della musica italiana nel Medioevo fu senza dubbio la fioritura dell'Ars nova nel sec. XIV, con caratteri originali rispetto a quella contemporanea francese. Mancò in Italia un centro culturale predominante, una capitale come Parigi: i musicisti dell'Ars nova operarono in diverse sedi in tutta Italia, in particolare in quella centro-settentrionale (tra i centri maggiori furono Bologna e Firenze). La polifonia del Trecento italiano ebbe carattere quasi esclusivamente profano e si espresse nei generi del madrigale, della caccia e della ballata. Tra i principali musicisti furono Iacopo da Bologna (sec. XIV), Gherardello da Firenze (m. 1362/64), Giovanni da Cascia (o da Firenze, sec. XIV), F. Landino (1325/35-1397). La scrittura polifonica non ebbe in Italia un carattere astrattamente speculativo e si improntò spesso a una singolare morbidezza melodica. I principali teorici in questo periodo furono Marchetto da Padova (sec. XIII-XIV) e Prosdocimo de Beldemandis (1380-1420). Verso la fine del sec. XIV ebbe luogo un più intenso scambio tra Ars nova italiana e francese, che portò a una maggiore complessità la notazione e gli artifici compositivi. Tra il 1420 e il 1470 si ebbe una sorta di scomparsa dalla scena dei compositori italiani. Durante questo cinquantennio operarono in Italia musicisti stranieri come G. Dufay (ca. 1400-1474), J. Obrecht (ca. 1450-1505), H. Isaac (ca. 1450-1517), J. Després (ca. 1440-ca. 1521) e altri fiamminghi, ai quali era affidata la musica ufficiale, di carattere colto. Accanto a essa fiorirono forme popolaresche e improvvisatorie, che assunsero particolare rilievo a fine secolo e nel secolo successivo: odi, strambotti, canzoni, ballate, le rudimentali forme polifoniche dei canti carnascialeschi a Firenze, delle giustiniane e delle villotte a Venezia, delle villanelle a Napoli, delle laude polifoniche a Firenze, Venezia e Roma, e delle frottole a Mantova, dove verso la fine del secolo alla corte di Isabella d'Este si radunarono compositori come M. Cara (m. ca. 1527), B. Tromboncino (ca. 1470-dopo il 1535) e altri iniziatori di questo genere, la cui fortuna nel primo Cinquecento è largamente testimoniata dalle edizioni di O. Petrucci (primo stampatore musicale con il sistema a caratteri mobili), le cui pubblicazioni sono una significativa testimonianza della situazione musicale italiana tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento.
Musica: il madrigale e la polifonia
I generi popolari come la frottola interessarono nel Cinquecento anche i musicisti più colti, italiani e stranieri. La grande fioritura musicale cinquecentesca ebbe come premessa anche la fusione tra lo spirito costruttivo rigoroso della scuola franco-fiamminga e le suggestioni di cantabilità e immediatezza espressiva della musica italiana “minore”. La maggior personalità di compositore italiano alla fine del Quattrocento fu F. Gaffurio (1451-1522), maestro di cappella a Milano, autore anche di importanti opere teoriche. Il Cinquecento fu una delle epoche di massimo splendore per la musica in Italia e segnò l'inizio di un lungo periodo (fino a metà del Settecento) in cui questo Paese ebbe una funzione di primo piano nella storia della musica europea. Nella musica profana, accanto alla diffusione dei generi popolareschi già citati, va ricordata la splendida fioritura del madrigale, frutto raffinatissimo della civiltà delle corti italiane rinascimentali, che culminò nell'opera di L. Marenzio (ca. 1553-1599) e C. Gesualdo (ca. 1560-1613) e soprattutto di C. Monteverdi (1567-1643), con il quale si compì una radicale trasformazione stilistica. Scrissero madrigali molti dei maggiori compositori europei del tempo. Tra gli italiani vanno menzionati C. Festa (ca. 1480-1545), F. Corteccia (1502-1571), V. Ruffo (ca. 1510-1587), Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594), M. A. Ingegneri (1547-1592), Andrea (ca. 1510-1586) e Giovanni Gabrieli (1554/57-1612). Nella fase conclusiva della civiltà madrigalistica si colloca il burlesco madrigale dialogico, rappresentato da O. Vecchi (1550-1605), A. Banchieri (1568-1634), A. Striggio (ca. 1535-ca. 1589), G. Croce (1557-1609). Carattere giocoso e popolareggiante ebbero anche la canzonetta e il balletto. Nell'intensa vita musicale dell'Italia del Cinquecento occuparono una posizione di particolare rilievo i centri di Roma e Venezia. A Roma, sede delle cappelle papali, ricevette preminente impulso la musica sacra e in questo ambito prevalse un atteggiamento severo e sostanzialmente conservatore. La grande tradizione polifonica a cappella dei franco-fiamminghi culminò nelle messe e nei mottetti di Palestrina, il cui supremo equilibrio e la cui perfezione stilistica divennero modello dello stile detto appunto “palestriniano”; a esso si improntò poi la scuola romana con i Nanino, Felice (ca. 1560-1614) e Giovanni Francesco Anerio (1567-1630) e F. Soriano (1549-1621). L'adesione ai principi della Controriforma, che escludevano tra l'altro dalla chiesa tutti gli strumenti tranne l'organo, si fece sentire con particolare vigore nell'ambiente romano ed è questo uno degli aspetti che più chiaramente differenziarono la scuola romana da quella veneziana. A Venezia infatti la musica sacra non ebbe alcuna prevalenza esclusiva e assunse comunque un diverso carattere puntando su sontuosi effetti coloristici, sugli esiti di solenne e ampia architettura sonora, nascenti dall'uso della policoralità, della contrapposizione cioè dei “cori spezzati” e dell'unione di voci e strumenti. Al servizio della cappella di S. Marco operarono i fiamminghi A. Willaert (ca. 1490-1562) e C. de Rore (ca. 1516-1565) e inoltre G. Zarlino (1517-1590), B. Donati, G. Croce, A. e G. Gabrieli, nella cui produzione culminò lo sfarzoso colorismo veneziano. Nell'ambiente veneziano furono inoltre attivi alcuni dei primi maestri che contribuirono in modo determinante al formarsi di un'autonoma tradizione organistica, come Andrea e Giovanni Gabrieli, C. Merula (1533-1604), Marco Antonio (ca. 1490-ca. 1570) e G. Cavazzoni (ca. 1510-ca. 1565), G. Parabosco (ca. 1524-1557), Annibale Padovano (1527-1575). L'organo e il clavicembalo furono, con il liuto, i primi strumenti per i quali si sviluppò nell'Italia del Cinquecento una specifica letteratura. Per quanto riguarda la musica per liuto, in gran parte anonima, va ricordato Francesco da Milano (1497-ca. 1543). Altri centri della vita musicale del Cinquecento furono le corti dei Gonzaga a Mantova e degli Estensi a Ferrara, dove operarono N. Vicentino (1511-1572/76) e L. Luzzaschi (ca. 1540-1607), la città di Milano, la cui cappella vide attivo, fra gli altri, V. Ruffo (che attenendosi alle indicazioni del cardinale Borromeo applicò con particolare rigore i criteri della Controriforma sulla musica liturgica); Bologna (con O. Vecchi e A. Banchieri), Brescia e Cremona, dove si svilupparono insigni scuole di organari (gli Antegnati) e di liuteria (gli Amati); Torino (con i Ferrabosco), Padova, Vicenza e Verona (con G. M. Asola, 1524-1609; e C. Porta, ca. 1529-1601). Centro egemonico dell'Italia meridionale fu Napoli (dove dominò Gesualdo di Venosa), mentre originari della Sicilia, ma operanti al Nord, furono P. Vinci e S. D'India (ca. 1580-1629). Infine una menzione a parte richiede Firenze, dove accanto ai canti carnascialeschi e alle sacre rappresentazioni fiorì un genere particolarmente caro alla corte medicea, quello degli intermedi, e dove un gruppo di musicisti riuniti nella Camerata fiorentina affrontò i problemi legati all'affermarsi della monodia e alle origini del melodramma.
Musica: il melodramma, l'oratorio e la cantata
V. Galilei (ca. 1520-1591), J. Peri (1561-1633), G. Caccini (ca. 1550-1618), Emilio dei Cavalieri (m. 1602) furono i protagonisti del dibattito sul “recitar cantando”, sul nuovo stile della monodia accompagnata che poneva estrema cura nel sillabare chiaramente le parole, da essi contrapposto alla tradizione polifonica e al “laceramento della poesia” prodotto secondo loro dal contrappunto. La polemica dei fiorentini e il loro ideale del “recitar cantando” (ispirato al mitico modello della tragedia greca) si inserirono nel contesto di una profonda trasformazione stilistica che si compì tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento con l'affermarsi della monodia accompagnata dal basso continuo: alle risorse della polifonia rinascimentale si contrapponevano così quelle della melodia solistica sostenuta da accordi. Al nuovo stile monodico (che non implicò affatto la scomparsa di quello polifonico) si ricollegarono in Italia alcuni generi che, nati all'inizio del Seicento, furono tra i più rappresentativi dell'età barocca: il melodramma, l'oratorio e la cantata. Le prime esperienze operistiche furono compiute nell'ambiente fiorentino, e a Firenze fu rappresentata nel 1600 l'Euridice di J. Peri (su testo di O. Rinuccini musicato anche da Caccini). Al di sopra delle opere di Peri, Caccini, Marco da Gagliano (1582-1643) ed E. dei Cavalieri si collocano i capolavori teatrali di Monteverdi dall'Orfeo (1607) all'Incoronazione di Poppea (1642), che con le sue ultime opere, rappresentate a Venezia (dove nel 1637 era stato aperto il primo teatro destinato a un pubblico pagante), diede l'avvio alla scuola operistica veneziana. Il melodramma, nato come spettacolo di corte, squisitamente aristocratico, legato per molti aspetti al gusto del dramma pastorale e degli intermedi, si trasformò con l'apertura dei teatri pubblici in uno spettacolo destinato a un uditorio assai più vasto, popolare, e perse i legami con l'aristocratico dramma pastorale per rivolgersi a soggetti storico-mitologici con ricchezza e varietà d'azione e d'effetti scenografici. Sulla scia di Monteverdi si formò a Venezia una scuola di operisti che ebbe in F. Cavalli (1602-1676) e in G. Legrenzi (1626-1690) i maggiori rappresentanti: insieme con loro emerse, tra gli operisti italiani della seconda metà del Seicento, A. Cesti (1623-1669). Anche a Roma si sviluppò, tra il 1620 e il 1660 ca., una notevole attività nel campo del melodramma, con L. Rossi (1598-1653), S. Landi (ca. 1590-1639), V. Mazzocchi (1597-1646), M. Marazzoli (ca. 1602/ca. 1608-1662), A. M. Abbatini (ca. 1597-1680). In precedenza la Rappresentazione di Anima et di Corpo (1600) di E. dei Cavalieri era stata la prima azione teatrale interamente musicata rappresentata a Roma. Cavalieri era vicino alle esperienze dei monodisti fiorentini, ma anche all'ambiente dell'Oratorio di San Filippo Neri, e in effetti la sua Rappresentazione non può essere considerata in senso stretto un melodramma, per il carattere del testo, né un oratorio, perché implica un'azione scenica. L'oratorio nacque appunto nell'ambiente romano e trasse origine dai musicisti che nel Cinquecento erano stati vicini a San Filippo Neri (fondatore di due “Oratori”, luoghi dove accanto alla meditazione spirituale anche la musica doveva concorrere all'edificazione religiosa) elaborando una forma di semplice lauda polifonica o monodica, spesso dialogica. Dalla lauda dialogica, e insieme dalle suggestioni del nascente melodramma, nacque dunque l'oratorio in lingua volgare: contemporaneamente si sviluppò l'oratorio in lingua latina, derivato dal mottetto dialogico. I due filoni, latino e volgare, confluirono in breve in un unico genere che, soprattutto a partire dalla metà del Seicento, seguì sempre più da vicino l'evoluzione delle forme e dello stile del melodramma. Mentre a Roma emerse subito la grandissima figura di G. Carissimi (1605-1674), il nuovo genere dell'oratorio trovò fortuna anche a Bologna e a Modena ed ebbe tra i suoi cultori G. A. Perti (1661-1756), G. B. Vitali (1644-1692), G. B. Bassani (ca. 1647-1716), G. B. Bononcini (1670-1747) e A. Stradella (1644-1682). La cantata, l'altro genere nuovo che ebbe grande fortuna nell'Italia del Seicento, va collegata alla trasformazione del madrigale (negli ultimi libri di Monteverdi molti madrigali potrebbero essere considerati cantate: si pensi al celebre Combattimento di Tancredi e Clorinda) e alle arie e madrigali monodici delle Nuove musiche (1602 e 1614) di Caccini. Il termine cantata comparve per la prima volta nel 1629, in una raccolta di A. Grandi, e il genere toccò subito vette assai elevate con Carissimi, L. Rossi, A. Stradella, seguiti da molti altri, tra cui Cavalli, Legrenzi, Cesti, Bononcini, M. Cazzati (ca. 1620-1677), Perti e A. Steffani (1654-1728), cultore anche del duetto da camera e operista notevole, attivo soprattutto in Germania. Inizialmente la cantata non presentava caratteristiche formali rigidamente definite: nella seconda metà del Seicento si codificò la tipica alternanza di arie (in genere di contrastante carattere), ariosi e recitativi, che fu assunta poi nella vasta produzione cantatistica di A. Scarlatti (1660-1725). Dal punto di vista formale l'evoluzione della cantata e dell'oratorio è vicina a quella del melodramma, da cui entrambi i generi furono fortemente influenzati. Dalla sobrietà del “recitar cantando” dei Fiorentini il melodramma passò a un'articolazione musicale sempre più ricca e complessa, lasciando maggiore spazio alle ragioni della musica in rapporto al testo: nella seconda metà del secolo si venne definendo la separazione tra aria e recitativo e si svilupparono le forme chiuse assumendo schemi fissi e strutture regolari. Nell'Italia del Seicento, accanto all'affermarsi della monodia accompagnata non venne meno nella musica sacra lo “stile antico” della polifonia palestriniana. Ma si applicarono anche alla musica da chiesa le nuove risorse dello stile monodico e della scrittura concertante per voci e strumenti. Di questa situazione le raccolte di musica sacra di Monteverdi sono tra gli esempi più significativi. Lo “stile antico” sopravvisse soprattutto nell'ambiente romano, dove ebbe particolare sviluppo la tecnica policorale: adottarono ampi organici, in vista di sontuosi effetti barocchi, musicisti come O. Benevoli (1605-1672), V. Mazzocchi, P. F. Valentini (ca. 1570-1654). A Roma operò anche G. O. Pitoni (1657-1743); tra gli altri autori secenteschi di musica sacra sono da ricordare Ludovico da Viadana (ca. 1560-1627) e i già menzionati Cavalli, Carissimi e Gagliano. Uno degli aspetti più significativi e innovatori del Seicento musicale italiano fu lo sviluppo della musica strumentale. La tradizione clavicembalistica e organistica culminò in G. Frescobaldi (1583-1643). Tra i più notevoli esponenti della generazione successiva vanno menzionati B. Pasquini (1637-1710), M. Rossi (ca. 1600-1656), M. Cazzati. Tuttavia la maggiore novità in campo strumentale fu la scoperta delle possibilità espressive della voce del violino e la conseguente nascita di alcuni generi legati a questo strumento: la sonata per violino e basso continuo, la sonata a tre, il concerto, la suite. La prima fioritura di musica violinistica ebbe luogo nell'Italia settentrionale con G. P. Cima, B. Marini (ca. 1597-1665) e C. Farina (ca. 1600-ca. 1640). Dalla metà del secolo si sviluppò a Bologna una scuola insigne: vi furono attivi G. B. Vitali, G. B. Bassani, G. B. Bononcini e G. Torelli (1658-1709), al quale si fanno risalire gli inizi del concerto solistico. Prima del concerto ebbe la massima diffusione nell'Italia del Seicento e del primo Settecento la sonata a tre (per due violini e basso continuo) che si venne definendo nei due tipi “da camera”, formata da una successione di arie di danza, e “da chiesa”, che evitava riferimenti profani (almeno nel nome). L'organico della sonata a tre fu contrapposto all'insieme degli archi nel concerto grosso, dove formò il “concertino”. Tra i primi grandi musicisti che contribuirono a definire questi generi fu Stradella. Rispetto alla vena esuberante e riccamente fantasiosa di Stradella appare più sobria e ordinata la produzione di A. Corelli (1653-1713), che volle imprimere alla sonata a tre e al concerto grosso un primo suggello di compiuta classicità, di limpida euritmia. A queste premesse si riallaccia la scuola veneziana che con i tre “dilettanti veneti”, T. Albinoni (1671-1750), B. Marcello (1686-1739), F. A. Bonporti (1672-1749), e con la straordinaria personalità di A. Vivaldi (1678-1742), conobbe una fioritura che si concluse solo con G. Tartini (1692-1770). Anche in altri centri italiani la musica strumentale conobbe nel Settecento livelli elevati, soprattutto nella prima metà del secolo: a Firenze operarono A. Veracini (1659-1733) e F. S. Geminiani (ca. 1680-1762), allievo di Corelli: a Torino un altro allievo di Corelli, G. B. Somis (1686-1763), alla cui scuola si formarono G. Pugnani (1731-1798) e G. B. Viotti (1755-1824). Figura di notevole rilievo nello sviluppo della tecnica violinistica fu P. A. Locatelli (1695-1764). Anche nel campo clavicembalistico non mancarono eredi insigni della tradizione secentesca, come D. Zipoli (1688-1726). P. D. Paradisi (1707-1791), G. B. Pescetti (1704-1766), B. Galuppi (1706-1785), G. B. Platti (ca. 1700-1763) e soprattutto D. Scarlatti (1685-1757), uno dei protagonisti europei in campo clavicembalistico. La trasformazione stilistica che portò nel corso del Settecento europeo dal tardo-barocco allo stile galante, al classicismo e al preromanticismo, attraverso l'acquisizione della forma sonata, il rinnovamento della sonorità orchestrale, il superamento del basso continuo e la definizione della sinfonia e dei maggiori generi della musica da camera moderna, tutto questo complesso e ricco articolarsi di fenomeni ebbe tra i protagonisti numerosi musicisti italiani: accanto a quelli già menzionati si devono ricordare G. B. Sammartini (ca. 1700-1775) e poi L. Boccherini (1743-1805) per la sinfonia, F. Giardini (1716-1796), G. G. Cambini (1746-1825) e soprattutto l'appena citato Boccherini per la musica da camera, M. Clementi (1752-1832) per la conquista di un nuovo linguaggio pianistico. Tuttavia occorre ricordare che molti fra questi compositori conclusero la loro vita e svolsero una parte rilevante della loro attività all'estero, dove incontrarono un pubblico e una vita musicale più pronti ad accoglierli. In Italia infatti all'esclusivo successo del melodramma, che poteva contare su tradizioni ormai consolidate e su centri di diffusione avviati, non si accompagnò la maturazione di un pubblico musicale nuovo e di iniziative capaci di sostituire le strutture nobiliari del passato. La grande tradizione strumentale settecentesca non trovò seguito e si avviò fin dagli inizi del sec. XIX a un inarrestabile declino.
Musica: l'opera buffa settecentesca
L'insigne fioritura del melodramma settecentesco ebbe larga diffusione in Italia e in tutta Europa e per un lungo periodo l'opera italiana dominò i maggiori teatri europei. Nella seconda metà del Seicento accanto alla scuola veneziana si era venuta formando quella napoletana che trionfò nel Settecento. Contemporaneo del veneziano A. Caldara (ca. 1670-1736), allievo di Legrenzi, A. Scarlatti fu il primo grande rappresentante di tale scuola. Con lui ricevettero chiara definizione le strutture formali tipiche dell'opera settecentesca, recitativo e aria col da capo e la sinfonia strumentale d'inizio. Alla fioritura della scuola napoletana vanno ricollegati i nomi di N. A. Porpora (1686-1768), L. Vinci (1690/96-1730), F. Feo (1691-1761), G. B. Pergolesi (1710-1736), N. Jommelli (1714-1774), T. Traetta (1727-1779), N. Piccinni (1728-1800), G. Paisiello (1740-1816), D. Cimarosa (1749-1801). Nei primi decenni del sec. XVIII il melodramma italiano ricevette anche una precisa impostazione drammaturgica a opera di librettisti come A. Zeno (1668-1750) e P. Metastasio (1698-1782). L'opera metastasiana nacque da una semplificazione delle complicate strutture drammatiche dell'opera secentesca, che molto concedeva al gusto del “meraviglioso” barocco. In funzione di questa semplificazione e nobilitazione formale vennero anche eliminate le parti buffe. La mescolanza di comico e serio non conveniva infatti al dramma metastasiano, imperniato sul gioco degli affetti galanti e sulle rigide categorie morali e formali dell'aristocrazia settecentesca. L'importanza conferita all'aria con il da capo concedeva largo spazio al gusto virtuosistico dei cantanti, che toccò il vertice nella straordinaria bravura dei castrati (celeberrimi Caffarelli e Farinelli). La scuola del bel canto italiano ebbe diffusione europea, anche attraverso insegnanti e teorici come P. F. Tosi e G. B. Mancini. La vita teatrale italiana settecentesca, caratterizzata da un'attività febbrile e da una fretta legate agli interessi degli impresari e ad allestimenti spesso avventurosi, fu criticata da letterati come F. Algarotti, R. de' Calzabigi e lo stesso Metastasio, e da musicisti come B. Marcello. Le istanze di rinnovamento dell'opera seria metastasiana furono particolarmente avvertite in Italia da compositori come Jommelli e Traetta e trovarono più sistematica attuazione in C. W. von Gluck (1714-1787). Sarebbe tuttavia errato giudicare i valori musicali di questa tradizione sul metro delle opere polemiche degli autori sopra citati. Accanto all'aristocratica opera seria si sviluppò nel Settecento italiano l'opera buffa che, immune da sclerotizzazioni accademiche, rifletteva un ambiente e una realtà diversi, tipicamente borghesi. A chiarirne il carattere innovatore e borghese basterebbe ricordare il favore che incontrò negli ambienti della Francia prerivoluzionaria, presso illuministi ed enciclopedisti ai tempi della Querelle des bouffons. Personaggi e soggetti erano ben più vicini alla realtà quotidiana di quelli dell'opera seria (sempre ispirati ai miti classici o alla storia greco-romana), e ovviamente anche i tipi vocali erano profondamente diversi: non c'era posto per i castrati (il cui timbro asessuato e artificiale si confaceva perfettamente all'estetica dell'opera seria) e ai cantanti si richiedevano anche notevoli qualità di attori. L'evoluzione dell'opera buffa nel corso del Settecento si compì come progressiva trasformazione da un genere originariamente vicino alla farsa popolaresca fino agli esiti della commedia borghese-sentimentale. Un momento significativo in questa evoluzione del gusto fu rappresentato dalla Cecchina (1760) di Piccinni, nel cui libretto Goldoni introdusse motivi della comédie larmoyante e del romanzo sentimentale europeo, aprendo un filone cui si collegarono Paisiello, Cimarosa e altri. L'importante attività librettistica di Goldoni si svolse anche in collaborazione con il compositore veneziano B. Galuppi. Alla fine del Settecento il melodramma era rimasto in Italia l'unico e trionfante genere musicale. Anche in questo campo le chiusure e il provincialismo delle classi dominanti avevano fatto sì che non trovasse alcuna eco il lavoro di compositori come L. C. Cherubini (1760-1842) o G. Spontini (1774-1851), operanti all'estero e particolarmente sensibili a stimoli della cultura europea, che avevano lasciato traccia nella produzione di altri operisti attivi all'estero, come Piccinni, A. M. G. Sacchini (1730-1786) e A. Salieri (1750-1825).
Musica: dal melodramma ottocentesco al tramonto del sistema tonale
Il melodramma italiano continuava ad avere ancora in sé possibilità di rinnovamento, come ebbe a dimostrare la fioritura del sec. XIX. Si può dire che nella prima metà dell'Ottocento la cultura italiana abbia preso parte al romanticismo europeo e ne abbia accolto certe istanze proprio attraverso il melodramma. Se esigenze di novità si possono avvertire nell'opera di F. Päer (1771-1839) e G. S. Mayr (1763-1845), con G. Rossini (1792-1868) si compì una svolta decisiva e si posero le premesse del melodramma ottocentesco. Da un lato egli concluse la tradizione dell'opera buffa, sancendone l'esaurimento in alcuni capolavori comici in cui le strutture tradizionali venivano letteralmente fatte esplodere, dall'altro aprì nuove vie all'opera seria, attraverso un complesso e faticoso travaglio che culminò nelle opere francesi. Le nuove istanze furono portate avanti da V. Bellini (1801-1835) e G. Donizetti (1797-1848) – accanto ai quali va menzionato almeno S. Mercadante (1795-1870) – i cui lavori segnarono la prima compiuta definizione del melodramma italiano romantico attraverso caratteri drammaturgici e stilistici (specie nella scrittura vocale) ormai lontani da quelli settecenteschi. Si apriva così la strada a G. Verdi (1813-1901), la personalità che dominò l'Ottocento musicale in Italia dagli anni Quaranta fin quasi alla fine del secolo. Il carattere popolare del melodramma ottocentesco, e in particolare di quello di Verdi, rivela uno stretto legame tra musicista e pubblico: l'inserimento del melodramma nel tessuto sociale consentiva a questo genere di riflettere la coscienza morale e le aspirazioni civili dell'Italia risorgimentale. Non si può dire altrettanto per la musica strumentale: dopo alcuni elevati lavori di Cherubini e dopo l'affascinante figura di N. Paganini (1782-1840), vennero compositori di limitato rilievo, come i virtuosi A. Rolla (1757-1841), A. Bazzini (1818-1897), G. Bottesini (1821-1889), mentre la produzione strumentale degli operisti ebbe una posizione marginale. Solo nella seconda metà dell'Ottocento iniziò anche in Italia uno sforzo di aggiornamento e di adeguamento delle strutture della vita musicale in vista dell'acquisizione degli esiti più alti della civiltà musicale europea. Conclusosi il periodo risorgimentale e venuto meno nella soluzione borghese e moderata del problema dell'unità nazionale lo slancio popolare che si rifletteva nelle opere del primo Verdi, era logico che la classe dominante facesse valere le proprie istanze culturali e le proprie aspirazioni cosmopolite. Così si cercò di diffondere in Italia la musica sinfonica e da camera d'oltralpe e sorsero in diverse città società concertistiche per la musica da camera (Società del Quartetto, ecc.). Ai modelli strumentali dell'Ottocento tedesco si ispirarono G. Sgambati (1841-1914) e G. Martucci (1856-1909), mentre altri si adoperarono per far conoscere il Wort-Ton-Drama di R. Wagner. Bologna, in particolare, divenne una roccaforte del culto wagneriano. Nelle intenzioni di A. Boito (1842-1918), F. Faccio (1840-1891), L. Mancinelli (1848-1921) e A. Catalani (1854-1893) la tradizione melodrammatica italiana doveva essere sottoposta a un radicale rinnovamento. In concreto, anche se fu importante l'azione di svecchiamento e di sprovincializzazione da essi intrapresa, i risultati non furono all'altezza delle intenzioni, pur se soprattutto la delicata sensibilità tardoromantica di Catalani lo portò a esiti degni di attenzione. Mentre le conseguenze più alte e autenticamente innovatrici di questo clima culturale si ebbero nella prodigiosa evoluzione stilistica dell'ultimo Verdi, alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento si affermò la “giovane scuola”, con il cosiddetto melodramma verista, costituita da P. Mascagni (1863-1945), R. Leoncavallo (1857-1919), F. Cilea (1866-1950), U. Giordano (1867-1948) e, ad altro livello, da G. Puccini (1858-1924), allievo, come Mascagni, di A. Ponchielli (1834-1886). A eccezione di quest'ultimo, che nel tentativo di emanciparsi dal vincolo dei suoi schemi costituisce l'esponente più alto del verismo, tali compositori rappresentarono un fenomeno sostanzialmente provinciale: ricollegandosi saldamente alla tradizione ottocentesca e accogliendo influssi soprattutto francesi (dalla Carmen di Bizet e da Massenet), e molto marginalmente da Wagner, essi furono la voce, non priva di schiettezza e spontaneità, della volontà di potenza della nuova Italia post-risorgimentale e piccolo-borghese, con il loro gusto per la vocalità spiegata, per strutture drammatiche e musicali elementari, con i loro sforzi di affrontare contenuti nuovi con i mezzi del vecchio melodramma ridotti ormai a “gesti” effettistici privati del significato morale. Queste considerazioni di insieme esigerebbero di essere caso per caso circostanziate, perché ci si trova pur sempre di fronte a personalità diverse. L'ingombrante eredità verdiana e pucciniana di stampo naturalista aveva generato un violento movimento di reazione antiverista, cui presero parte compositori tra cui O. Respighi (1879-1936), I. Pizzetti (1880-1968), G. F. Malipiero (1882-1973) e A. Casella (1883-1947). Nella prima metà del Novecento, essi concentrarono i loro sforzi nel tentativo di liberarsi da quella pesante eredità, opponendo un deciso rifiuto sia alle forme chiuse di matrice verdiana sia al leitmotiv di stampo wagneriano, e cercando, con grandi difficoltà e con esiti spesso contraddittori, nuove vie percorribili nell'ambito del repertorio operistico. Il regime fascista aveva inoltre costretto l'Italia a un livello di provincialismo culturale che la rese impreparata ad accogliere in maniera critica e senza traumi l'avvento del postwebernismo, una corrente culturale sorta a Darmstadt intorno a una cerchia ristretta di compositori che, partendo dall'esperienza di Webern, portarono all'estremo la sua rigorosa ricerca, fino a teorizzare il serialismo integrale. Tale tecnica consisteva nell'isolamento di ogni parametro del suono e nella successiva creazione di serie di altezze, intensità, durate e timbri. Le serie, composte da elementi obbligatoriamente differenti, venivano poi lette in vario modo, ma sempre garantendo una sostanziale “uguaglianza” sonora, che annullava ogni possibilità di organizzazione gerarchica. In ogni caso, per ragioni sia politiche sia culturali, in Italia non vi fu una cieca omologazione a tale granitica tendenza, e ciò ebbe anche, da un certo punto di vista, i suoi risvolti positivi. Ci si rese conto, infatti, che non si potevano cancellare dall'oggi al domani alcune delle fondamentali peculiarità della scuola italiana, che da sempre aveva avuto una spiccata sensibilità verso il genere drammatico e aveva prediletto aspetti da esso imprescindibili, quali il lirismo e l'espressività del canto. Così si comprese ben presto che la soluzione al problema non poteva essere la soppressione tout court di tali tendenze, ma la loro ricontestualizzazione in chiave contemporanea, attraverso la ricerca di nuovi sbocchi in una situazione linguistica radicalmente mutata con il tramonto del sistema tonale. Compositori quali G. F. Ghedini (1892-1965) e L. Dallapiccola (1904-1975) cercarono allora, pur nell'ambito di categorie già collaudate, un personale percorso poetico, ricorrendo, sì, ai principi dodecafonici, ma senza rinunciare fondamentalmente alla propria tradizione stilistica.
Musica: le conseguenze dell'atonalità
Muovendosi su un altro versante, F. Busoni (1866-1924) e G. Petrassi (1904-2003) cercarono nel “nuovo classicismo” non tanto il ritorno a qualcosa di perduto da rievocare con nostalgia, quanto piuttosto il recupero, effettuato con assoluta coscienza, di metri e ritmi appartenenti alla tradizione classica: scelta nata dalla convinzione della natura metastorica di certi archetipi musicali, che, sotto spoglie diverse e in contesti affatto rinnovati, riemergono periodicamente come valori significanti. È bene a questo punto aprire un'ampia parentesi concernente le conseguenze radicali e incontrovertibili che l'avvento dell'atonalità portò con sé: innanzitutto, l'impossibilità di individuare correnti estetiche ben delineate, visto che si passò dall'appartenenza a un linguaggio comune e codificato come quello tonale – in cui, seppur nell'ambito di poetiche del tutto personali, ci si muoveva in un medesimo campo semantico – a una reinvenzione linguistica praticamente a ogni opera, con la conseguente riorganizzazione volta per volta di tutte le “regole del gioco”. Come segnala U. Eco nel suo fondamentale saggio Opera aperta (1962), cambiano sostanzialmente le coordinate estetiche: dal rapporto forma-contenuto (quando ancora era possibile confrontarsi con un modello formale di riferimento) si passa a quello proposito-esito (dove ciascun compositore, a ogni opera, reinventa un percorso formale e linguistico, verificandone l'efficacia in relazione alle intenzioni di partenza). La scomparsa della tonalità e l'adesione spesso acritica al postwebernismo darmstadtiano portarono inoltre al programmatico rifiuto di ogni forma di riferimento extramusicale. Tale radicale mutamento di prospettiva, che procede di pari passo con il passaggio dal figurativo all'astratto nelle arti visive, fa sì che al centro della ricerca musicale non ci siano più i parametri ben distinti legati al linguaggio tonale, quali melodia, armonia, ritmo. Si fa quindi largo una concezione più globale della musica, secondo la quale i succitati parametri sono legati inestricabilmente l'uno all'altro. La terminologia stessa subisce un radicale mutamento, emblematico di un modo completamente nuovo di pensare la musica: “melodia” diventa “sequenza”, non più canto con valenze esclusivamente espressive, ma vera e propria cellula germinale di un'architettura di vaste proporzioni; il “ritmo” (inteso come ripetizione costante di un modello di durate nell'ambito di una metrica prestabilita) lascia il posto a concetti quali “tempo” e “durata”, considerati piuttosto come contrappunto, giustapposizione e alternanza di scorrimenti temporali diversi; l'“armonia”, avendo perduto ogni valenza funzionale, si lega indissolubilmente al “timbro” e diviene essa stessa “colore”: tutte componenti che definiscono ormai un insieme complesso di parametri interagenti in diverso modo. In altri frangenti si parla invece di “campo” armonico, cioè uno “spazio” virtuale caratterizzato da tensioni intervallari interne e da distribuzioni energetiche chiaramente direzionate. Tutto quanto precedentemente detto, infine, può essere ascritto al concetto di “suono” o “materiale”, termini con i quali si definisce genericamente qualsiasi tipo di elemento primordiale (una sequenza intervallare, un agglomerato armonico-timbrico, una lista di durate) sul quale viene poi edificata la struttura compositiva. Le nuove tendenze, come ogni radicale rinnovamento, portarono con sé anche alcune conseguenze negative. Alcune posizioni estreme di elitarismo snobistico causarono una profonda rottura con il grande pubblico, molto faticosa a risanarsi. Si rese quindi necessario il recupero della comunicazione, e in quest'ottica furono proprio alcuni compositori italiani tra i primi ad avvertire l'allarme e a cercare una soluzione. Soprattutto in reazione alla diffusione dei procedimenti aleatori applicati alla composizione – introdotti in Europa da J. Cage (1912-1992) e mutuati, seppur con esiti differenti, da personalità quali P. Boulez (n. 1925) e K. Stockhausen (1928-2007) –, procedimenti che portavano a una naturale degenerazione verso atteggiamenti nichilistici basati su una fondamentale rinuncia all'atto del comporre, si riafferma con convinzione il ruolo dell'invenzione, la fiducia nell'atto compositivo, recuperando dunque l'aspetto del “fare” musica inteso come autentico artigianato: Aspetti di artigianato formale è l'emblematico titolo di un celebre scritto di L. Berio. D'altro canto, pur attingendo ancora alle tecniche relative alla serialità integrale, si comincia a prendere coscienza della debolezza di un sistema votato all'appiattimento delle tensioni intervallari e armoniche.
Musica: il superamento dell'atonalità
In questo tentativo di rinascita si possono individuare alcune principali linee guida di carattere estetico e procedurale, che accomunano l'operato di diversi compositori. In primis, l'innovativa logica di B. Maderna (1920-1973), forse alla base di una vera e propria scuola compositiva italiana, che concerne un particolare modo di rapportarsi al “materiale”, inteso come fitta rete di rapporti armonici e intervallari che, sottoposta a manipolazioni di varia natura, prende vita e acquista una direzionalità inequivocabile. Individuando alcune successive fasi di lavoro, tale materiale viene dapprima stimolato da regole dall'esito sovente aleatorio, per poi essere sottoposto a un'analisi tale da metterne in luce eventuali relazioni interne, direzioni ed energie già implicite, la cui “necessità” si afferma con tanta maggior forza in quanto suggerite dal “caso”. Quindi, tratte le dovute conclusioni, tali relazioni vengono impiegate come fondamenta di processi compositivi a differenti livelli formali, dando vita a uno sviluppo di carattere germinativo. Alla base di questa concezione sta il rapporto scelta-caso, volontà-suggestione, legge-libertà, che invita alla conoscenza di sé nell'incessante rapporto con “l'alterità”. Nella stessa direzione si muovono le considerazioni di F. Donatoni (1927-2000), il quale, pur riconoscendo che all'invenzione non si può accedere mediante una disciplina ricevuta dall'esterno, considera potenzialmente utile, all'“inventiva assopita” di un giovane, una qualsivoglia disciplina: “Si voglia intendere qui, per disciplina, la libera accettazione di vincoli restrittivi imposti a se stesso allo scopo di orientare la scelta a un numero limitato di possibilità: in questo contesto l'autodisciplina è un bisogno primario per la definizione di ogni comportamento operativo e non assume alcun significato costrittivo”. Queste riflessioni non si riferiscono soltanto ad aspetti di natura pedagogica, ma coinvolgono soprattutto l'approccio stesso alla composizione, incentrato sul serrato confronto tra legge e libertà, tra vincolo e suo necessario superamento. Su un altro versante si situa S. Sciarrino (n. 1947), la cui estetica ha influenzato un'intera generazione di compositori. Sciarrino lavora organizzando nel tempo gesti musicali a spiccata valenza figurale, dando vita a una vera e propria “regia” degli eventi sonori. Attenzione massima, più che ad aspetti armonici e intervallari, è rivolta alla morfologia di tali eventi, e quindi alla loro connotazione timbrica. Un'estetica quasi del tutto basata sulla distribuzione ragionata di figure nel tempo esige trasparenza e un'estrema chiarezza gestuale. Diviene così necessaria la rinuncia a ogni altro tipo di dialettica tradizionale, come quella armonica, intervallare e ritmica, concentrando tutti gli sforzi nel dosaggio raffinato di colori e sfumature timbriche sempre al confine con la soglia del silenzio. Il compositore siciliano teorizza inoltre la “forma a finestre”, impostazione che rinnega la continuità narrativa di stampo classico, mutuando invece dai mezzi comunicativi contemporanei la sua peculiare forza espressiva (basti pensare a Internet e alle finestre che possono contemporaneamente aprirsi sul mondo anche attraverso la televisione con un semplice zapping). Si tratta, infatti, del passaggio – ex abrupto e con un ragionato tasso di imprevedibilità – da un gesto a un altro, o, per meglio dire, da un luogo (musicale, immaginativo, poetico) a un altro, come se si schiudesse improvvisamente la finestra su un nuovo scenario. Altra strada, percorsa in particolar modo da S. Bussotti (n. 1931), è quella del ricorso a una vera e propria estetica del gesto (di chiara matrice cageana) che, tagliando radicalmente i ponti con la prassi esecutiva consolidata, rivoluziona il modo di percepire l'evento musicale e ne esorcizza i residuali legami con la tradizione. L'interesse, prima limitato ad aspetti timbrici ed effettistici, si estende decisamente verso nuove ricerche in campo visuale e scenico, tanto che il baricentro del dramma, tradizionalmente impiantato sul testo, viene traslato su un versante mimico-gestuale, negando così ogni addentellato col melodramma classico. La figura dello strumentista è sostituita da quella dell'attore, gli stessi strumenti diventano oggetti di scena e la musica sembra fare da cornice a un teatro totale, di raffinato estetismo, non immune talora dal rischio della leziosità. Lorenzaccio (1972), forse l'opera più celebre di Bussotti, rappresenta emblematicamente tale atteggiamento eclettico e impudicamente esibizionista, coordinando all'interno della stessa struttura drammatica parti recitate, cantate, mimate e danzate. Altro interprete di un approccio alla composizione in termini squisitamente drammatici, sebbene con esiti completamente diversi, è L. Berio (1925-2003), il cui apporto è considerevole nel campo dell'interazione musica-parola e dell'azione teatrale. Stimolato dall'amicizia con U. Eco, Berio reinventa la relazione tra testo e musica, ricontestualizzandola dinamicamente nell'incontro-scontro tra significato e significante, e rivolgendo tutta l'attenzione al materiale fonetico, alleggerito dal peso della significazione. Soltanto con tali premesse sarebbe stato possibile il recupero dell'immediatezza del linguaggio e della sua primitiva potenza espressiva, la cui forza comunicativa risiede nell'onomatopea, liberata del fardello della connotazione semantica. Berio stesso definisce l'onomatopea “lo stadio più primitivo dell'espressione musicale spontanea, certamente anteriore alla costituzione del linguaggio organizzato”. Tradotte in termini compositivi, tali riflessioni conducono alla frammentazione testuale in tanti atomi dalle caratteristiche morfologiche affini a quelle del suono strumentale, frammentazione cui naturalmente segue una ridistribuzione secondo criteri formali prestabiliti. Il risultato approda spesso a esiti di funambolico virtuosismo come nella Sequenza III (1966) per voce, composizione dal carattere profondamente gestuale, nella quale un testo, dapprima parcellizzato in singole unità con valenza ora fonetica ora semantica, viene poi articolato in una polifonia di suoni, onomatopee, parole, urla, gemiti e versi di ogni genere. Anche il teatro musicale è ripensato in chiave contemporanea, superando – come nel caso di Bussotti – la concezione tradizionale di teatro d'azione e incentrando il dramma su un unico personaggio, centro catalizzatore ed egli stesso “teatro” di una tragedia completamente rivolta all'interiorità. L'azione non è più soggetta alle leggi della causalità, il tempo non è più pensato in maniera lineare e il senso del teatro è dato piuttosto dalla drammatizzazione di atteggiamenti differenti, scevri da retoriche attoriali codificate e messi in relazione in modo da interagire dinamicamente. Il compositore stesso ci chiarifica la differenza tra opera lirica e azione musicale: la prima “è sorretta da un tipo di narratività aristotelica, che tende a essere prioritaria sullo sviluppo musicale”, mentre nella seconda “è il processo musicale che tiene il timone della storia”. Quello che in sostanza preme di più al compositore non è tanto creare un “sistema di attese” finalizzato a generare tensione in rapporto all'esito, ma piuttosto “controllare lo sviluppo e i rapporti tra i diversi caratteri musicali, i loro conflitti e la densità polifonica dell'insieme”. Altro versante, che manifesta l'emancipazione dall'avanguardia musicale darmstadtiana, è l'impegno e il carattere di denuncia sociale di compositori come L. Nono (1924-1990) e G. Manzoni (n. 1932) che, nonostante possano ascriversi da un punto di vista linguistico all'ambito del serialismo, non rinunciano alla figuratività sonora, considerata elemento fondamentale di un tipo di comunicazione dalla valenza anche etico-politica. Nella conferenza del 1959, “Presenza storica nella musica d'oggi”, che segna l'allontanamento definitivo dall'ambiente di Darmstadt, Nono sintetizza questo radicale atteggiamento affermando l'indipendenza dell'opera d'arte da ogni principio schematico e trovandone la sola ragion d'essere nella sintesi, intesa come risultato dialettico tra un principio e la sua realizzazione nella storia. Secondo tale ottica “la libertà creativa è intesa come capacità coscientemente raggiunta di conoscere e di prendere le decisioni necessarie nel proprio tempo e per il proprio tempo”. I materiali utilizzati possono essere persino desunti da canti popolari a carattere politico e sociale, posto che la citazione non è mai considerata come elemento strutturalmente gravido di possibilità elaborative, quanto piuttosto come “documento” non scalfibile, testimonianza di una situazione intrinsecamente drammatica e quindi significante in quanto tale. A completamento del complesso e variegato panorama musicale italiano del secondo dopoguerra, è doveroso ricordare altri importanti autori che hanno contribuito alla crescita didattica e artistica del Paese: in particolare G. Scelsi (1905-1988), B. Bettinelli (1913-2004), A. Clementi (n. 1925), N. Castiglioni (1932-1996), F. Pennisi (1934-2000), A. Gentilucci (1939-1989), A. Corghi (n. 1937) e, della nuova generazione, F. Vacchi (n. 1949), I. Fedele (n. 1953), L. Francesconi (n. 1956), A. Solbiati (n. 1956).
Musica: diffusione, insegnamento e principali interpreti
Un discorso a parte merita la situazione della vita musicale, dell'istruzione musicale e della ricerca musicologica. Accanto a centri di fama internazionale, esistono in Italia regioni quasi del tutto prive di attività legate alla diffusione e all'insegnamento della musica. L'organizzazione della vita musicale in Italia si basa essenzialmente su enti lirico-sinfonici, tra i quali emergono alcuni teatri d'opera – la Scala di Milano, il Regio di Torino, l'Opera di Roma, il Comunale di Bologna (che svolge un'attività coordinata con gli altri teatri emiliani), il Comunale di Firenze, il San Carlo di Napoli e il Carlo Felice di Genova – e importanti orchestre, quali l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Filarmonica della Scala di Milano e l'orchestra della RAI di Torino. Le manifestazioni degne di maggior nota, sia per la qualità dei programmi presentati, sia per la particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea, sono il Maggio musicale fiorentino e il Festival della Biennale di Venezia. L'istruzione musicale è pressoché assente dalla scuola (con l'eccezione della poverissima “educazione musicale” nelle scuole medie e negli istituti magistrali e dello sviluppo, che stenta a decollare, delle scuole medie a indirizzo sperimentale). L'apprendimento della musica è confinato a scuole specializzate, i conservatori e gli istituti musicali parificati. Numerose istanze tendono a trasformare i rapporti problematici tra musica e cultura. La ricerca musicale è cominciata in Italia assai tardi, verso la fine del sec. XIX, parallelamente allo sforzo di globale svecchiamento e sprovincializzazione cui si è accennato. In tal senso fu preziosa l'attività di riviste come la Rivista Musicale Italiana (fondata a Torino nel 1894) e la Rassegna Musicale (fondata nel 1928), poi entrambe interrotte. Mentre la Rassegna Musicale pubblica saltuariamente Quaderni, la Rivista Italiana di Musicologia (1966) e la Nuova Rivista Musicale Italiana della RAI (dal 1967) cercano di raccogliere l'eredità di quegli insigni periodici. Tralasciando figure di eruditi come G. Baini (1775-1884) e F. Caffi (1778-1874), tra i primi musicologi italiani si possono annoverare L. Torchi (1858-1920), O. Chilesotti (1848-1926) e soprattutto F. A. di Torrefranca (1883-1955), che svolse un'ingente attività per riportare alla luce il passato musicale italiano del Rinascimento e del barocco. Nelle generazioni successive i nomi di musicologi e critici musicali di rilievo divengono più numerosi e la loro attività si fa sempre meno isolata e pionieristica: si possono ricordare G. Cesari (1870-1934), A. Della Corte (1883-1968), G. M. Gatti (1892-1973), L. Ronga (1901-1983), M. Mila (1910-1988), F. D'Amico (1912-1990), L. Rognoni (1913-1986), P. Santi (n. 1923). Nelle generazioni successive si sono segnalati U. Duse (1926-1997), M. Bortolotto (n. 1927), L. Pestalozza (n. 1928), C. Gallico (n. 1929), L. F. Tagliavini (n. 1929), A. Basso (n. 1931), F. A. Gallo (n. 1932), M. Messinis (n. 1932), P. Petrobelli (n. 1932), E. Fubini (n. 1935), Q. Principe (n. 1935), G. Pestelli (n. 1938), F. Degrada (n. 1940), B. Cagli (n. 1942). Nell'ambito del vasto panorama esecutivo, segnaliamo in particolare due tendenze che rappresentano l'aspetto più peculiare degli ultimi decenni del Novecento: da un lato, la grande attenzione rivolta alla ricerca filologica, che ha portato alla ricostruzione e al restauro di strumenti d'epoca, più consoni all'interpretazione di uno specifico repertorio, stimolando di conseguenza lo studio e l'applicazione delle prassi esecutive del passato; dall'altro, l'estrema cura nell'articolazione dei programmi concertistici, organizzati con finalità storico-critiche e pedagogiche, o secondo reciproci rimandi dalle significazioni più profonde. In questo quadro è da intendersi l'affermazione di P. Boulez, secondo il quale concepire un programma di sala costituisce già di per sé un “capolavoro”. L'approccio all'esecuzione si sviluppa così più in senso analitico che meramente virtuosistico, a tutto vantaggio dei contenuti musicali e concettuali. Guidata da tale rinnovata sensibilità una nuova generazione di musicisti si affaccia sulla scena internazionale, tra i quali ricordiamo: C. Abbado (n. 1933), R. Muti (n. 1941), G. Sinopoli (1946-2001) e R. Chailly (n. 1953) nell'ambito della direzione d'orchestra; B. Canino (n. 1935), S. Accardo (n. 1941), D. Ciani (1941-1974), M. Pollini (n. 1942), U. Ughi (n. 1944) e M. Campanella (n. 1947) nel campo dell'esecuzione strumentale.
Danza e balletto: dal Rinascimento al romanticismo
Se gli elementi base della danza teatrale sono da ricercare nella tradizione dell'antica Roma (fabula saltica), il balletto come creazione originale nacque in Italia nel Rinascimento, quando nel clima umanistico proprio di molti centri italiani quattrocenteschi emerse la figura del teorico e maestro di danza. Nell'opera di Domenico da Piacenza, di A. Cornazano e di Guglielmo Ebreo e nella sostanziale identità dei loro insegnamenti è di fatto dimostrata l'esistenza di una corrente già attiva nella danza italiana del sec. XV e, con la formazione di una scuola comune, la tradizione didattica, premessa per la nascita e, soprattutto, per lo sviluppo del balletto. L'origine italiana è inoltre attestata dalla stessa definizione (ballitto oppure ballicto), qui usata per la prima volta in luogo di ballo agli inizi del sec. XVI. Inoltre, proprio in Italia si ebbe il primo importante esempio di azione coreografica unitaria: il Ballo de Hercules, dato a Roma in piazza Santi Apostoli nel 1473 e seguito da un celeberrimo “convivio coreografico” di B. Botta (Tortona, 1489). Italiani furono anche i grandi trattatisti del Cinque-Seicento M. F. Caroso e C. Negri, nelle cui opere sono delineati i primi canoni della danza accademica (dalla riverenza ai numerosissimi passi, ai salti, alla grande batteria), che i francesi avrebbero ripreso e sviluppato un secolo dopo. Fu ancora l'Italia a tenere a battesimo nuovi generi: il balletto melodrammatico (Il ballo delle ingrate di Monteverdi e Rinuccini, 1608, connubio tra danza, recitazione e canto), il balletto a cavallo, la fiorentina “festa d'arme e di ballo” (o abbattimento). Dalle corti italiane la danza passò in Francia, portatavi da ballerini e maestri come Diobono, Negri, Caroso, Baltazarini e vi incontrò grande favore a corte nelle forme della pavane, della courante e della gaillarde, chiaramente derivate dalla padovana, dalla corrente e dalla romanesca. Dopo il prezioso contributo di Filippo San Martino d'Agliè, la cui opera nell'ambito del ballet de cour rappresenta l'anello di congiunzione tra festa cortese (Botta) e spettacolo teatrale moderno (G. B. Lulli), il balletto italiano, inteso come autonoma espressione artistica, ristette sulle posizioni acquisite e visse sulle manifestazioni virtuosistiche del nascente professionismo. A interrompere il lungo periodo di stasi giunse l'opera di G. Angiolini (1731-1803), che con il suo Don Juan ou le festin de pierre (dato a Vienna nel 1761 con la musica di Gluck) offrì il primo saggio di ballet d'action anticipando la riforma noverriana e suscitando una nuova fioritura di ballerini e, soprattutto, di insigni coreografi destinati a sviluppare e riformare il balletto europeo: da A. Rinaldi, che fu maestro e coreografo in Russia e che portò al balletto francese gli insegnamenti della tecnica italiana del salto e della grande batteria ("la fureur de sauter", secondo la definizione di Noverre), a V. Galeotti (1733-1816), pioniere del balletto in Danimarca, e ai Vestris, prevalentemente attivi a Parigi. Dalla fine del Settecento le fortune del balletto italiano risultano legate al Teatro alla Scala (inaugurato a Milano nel 1778) e alla successiva nascita dell'annessa Imperial Regia Accademia di Ballo (1812), che espresse una fioritura di grandi ballerine (Cerrito, Grisi, Fuoco, Cucchi) e che con l'opera di S. Viganò (1769-1821) – con cui il pantomimo di Angiolini divenne coreodramma – e di C. Blasis (1797-1878) esercitò per l'intero secolo un indiscusso predominio in tutta Europa. Dal 1813 Viganò compose per il teatro milanese la serie di balli (Prometeo; poi Mirra, 1817; quindi Otello, Dedalo e La vestale, 1818; infine I titani, 1819) che lo consacrò “sommo tra i coreografi”, iniziatore di un genere che ebbe quale altro autorevole rappresentante il napoletano G. Gioia (1768-1826) e per seguaci un gruppo di coreografi minori. Il periodo di transizione tra il neoclassicismo e il balletto romantico vide operanti alla Scala A. Cortesi (1796-1879) e G. Casati (1811-1895), che tentarono di fondere ai balli di tendenza viganoviana soggetti di carattere romantico. Sempre nell'ambito della Scala si formò e si espresse la famiglia di coreografi e ballerini che faceva capo a F. Taglioni (1777-1871), il quale tradusse nel linguaggio coreografico le istanze di Blasis e diede vita con la figlia Maria (1804-1884) alla “danza sulle punte” o danse aërienne e al balletto romantico. Con l'esaurirsi del movimento romantico il balletto italiano subì ancora una volta una battuta d'arresto. La crisi, che investì peraltro tutto il balletto europeo, fu più forte in Italia, dove mancavano compositori di musica specifica. Il magistero scenotecnico della Scala indusse i coreografi a ricorrere alle formule spettacolari del “ballo grande”, di cui diedero esempi sul finire del secolo G. Pratesi (1863-1938) e soprattutto L. Manzotti (Excelsior, 1881; Amor, 1886; Sport, 1897). Tra il 1870 e il 1890 ancora la Scala espresse una terza generazione di ballerine, creata e ispirata, come le precedenti, al genio didattico di Blasis e formata da danzatrici dotate di eccezionale tecnica virtuosistica, che incontrarono all'estero fama e successo (la Sangalli, la Legnani, la Beretta, la Zambelli). All'estero operò prevalentemente anche il ballerino E. Cecchetti (1850-1928), di belle doti espressive e didatta geniale, che educò nel rigore di un limpido stile accademico, rinvigorito dall'estro tecnico italiano di cui era maestro, intere generazioni di interpreti, molti dei quali costituiscono le pietre angolari della celebre impresa djagileviana mentre altri, più tardi, giocarono un simile ruolo nella nascente tradizione ballettistica britannica.
Danza e balletto: l'età contemporanea
Nei primi decenni del sec. XX sia i fermenti del modernismo sia la grande e feconda stagione dei Ballets Russes non toccarono l'Italia se non tangenzialmente, senza apparentemente suscitare, almeno in un primo momento, echi profondi. Pure, la stagione della danza libera di derivazione duncaniana, la nuova estetica di matrice centroeuropea e il radicale rinnovamento introdotto dall'esperienza dei Ballets Russes non tardarono a produrre anche in Italia i loro frutti. Il modernismo ebbe anzi in un primo momento, nel nostro Paese, una sua singolare variante, legata alle vicende del futurismo, cui si accostò per un breve periodo anche J. Ruskaja (1902-1970), danzatrice di origine russa stabilitasi in Italia negli anni Venti. Le sue danze di ispirazione dalcroziana incontrarono subito largo favore in ambienti altolocati, portandola in breve tempo fino alla direzione del ballo alla Scala (1932-34) e successivamente all'apertura di un'Accademia di Danza (oggi Accademia Nazionale di Danza) interamente finanziata dallo Stato italiano, che avrebbe dovuto formare nuove generazioni di insegnanti e che ebbe però scarso peso nella vita culturale italiana. Assai più incisiva e decisiva azione di rinnovamento e aggiornamento della vita coreutica italiana operò, a partire dal 1936, il maestro ungherese Aurel M. Milloss (1906-1988). Personalità ecclettica, di prodigiosa cultura personale e professionale, formatosi alla danza con Laban (1879-1958) e Cecchetti, Milloss, partito da Napoli, operò per più di trent'anni (oltre che in tutta Europa e in America del Sud) fra Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Palermo, ovunque suscitando nuove energie, formando nuove generazioni di interpreti – quando non interi corpi di ballo – lanciando nuove stelle (prima fra tutte A. Radice (1914-1980), protagonista ideale di molti suoi balletti fino agli anni Cinquanta), legando al balletto personalità eminenti della cultura e dell'arte, collaborando con i migliori compositori, scenografi e pittori italiani, invitando nei teatri e nel corso delle stagioni da lui dirette le grandi compagnie e i maggiori protagonisti della vita ballettistica internazionale. La sua azione ha influenzato anche la nascita di specifici studi coreologici e l'emergere della figura del critico specializzato, che ha avuto, grossomodo nel medesimo quarantennio di attività del maestro, il suo più eminente rappresentante in G. Tani. Gli anni Cinquanta, oltre all'espandersi dell'influenza millossiana, che continuò a dominare largamente, pressoché incontrastata, la vita coreutica italiana per ancora due decenni, videro la nascita di alcune iniziative di prestigio. Fra l'altro la creazione del Festival internazionale del balletto di Nervi (1955) a opera di U. Dell'Ara (n. 1921) e M. Porcile, l'apparizione, nello stesso anno, del primo periodico specializzato, il trimestrale Balletto diretto da A. Ludijdjens, la creazione per il Festival dei Due Mondi di Spoleto della compagnia Ballets USA (1958) di J. Robbins (1918-1998). In mancanza di un'omogenea ed efficace politica culturale che raccogliesse e valorizzasse l'avvenuto rinnovamento e aggiornamento della danza italiana, però, sul finire degli anni Sessanta, l'opera di Milloss e di quanti altri come lui si erano adoperati per la rinascita dell'arte coreutica in Italia, sembrò andare incontro a una progressiva e drammatica dispersione. Allo stesso modo esperienze di portata più limitata ma pure rinnovatrici quali, per esempio, quelle delle sorelle Hutter, di S. Acquarone e di S. Egri a Torino, dei Sacharov a Roma e Siena, si consumarono negli stessi anni senza che nulla intervenisse a valorizzarle o quanto meno a cercare di impedirne il dissolvimento. Ciononostante, gli anni Settanta, vuoi per i nuovi fermenti culturali che percorrevano il Paese, vuoi per la maggiore accessibilità, culturale e geografica, di autori come M. Béjart (n. 1927), provocarono una nuova ondata di interesse, questa volta più largamente popolare, per il balletto. A questa nuova popolarità aveva contribuito in modo determinante oltre che la qualità dell'offerta di tre decenni di attività coreutica, anche l'apparizione sulle scene italiane e internazionali di una stella di prima grandezza come C. Fracci (n. 1936) e, intorno a lei (conseguenza della qualità del lavoro nelle istituzioni liriche italiane), di una piccola galassia di prime ballerine e ballerini di valore: F. Cova, L. Cosi, E. Morini, L. Furno, M. Nativo, E. Terabust, L. Savignano, M. Pistoni, G. Lauri, A. Rainò, G. Vantaggio. Sono di questo periodo anche le prime affermazioni all'estero di un promettente giovane coreografo, allievo di Dell'Ara, per breve tempo scaligero, poi cresciuto nella compagnia di Béjart, V. Biagi (n. 1941), che tornerà in Italia, nel biennio 1977-78, per guidare un primo esperimento di compagnia agile e moderna, la Compagnia di balletto dei Teatri dell'Emilia-Romagna destinata a diventare più tardi l'Aterballetto. Sempre negli anni Settanta, l'arrivo di nuove “avanguardie” del modernismo americano professionalmente organizzate mobilitava ulteriori energie, riuscendo a radicare anche in Italia una “tradizione”, assai giovane ma di spettro sufficientemente ampio, nel campo della modern dance,alla cui diffusione contribuivano, in maniera determinante per la formazione di tutta una generazione di artisti, le danzatrici e coreografe E. Piperno (n. 1942) ed E. R. Garrison (n. 1940). La prima, già solista del London Contemporary Dance Theatre, si stabilì a Roma aprendovi una scuola e una compagnia ispirate all'insegnamento di M. Graham (1894-1991). L'opera di diffusione e proselitismo svolta da allora, instancabilmente, in tutta la penisola, affiancata dopo qualche anno dall'italo-americano J. Fontano (n. 1950), ha contribuito, o indirettamente favorito, all'aggiornamento degli specialisti – in questo saldandosi, sia pure con modalità affatto diverse, all'opera di Milloss – e ha finito per promuovere il coagularsi e l'approfondirsi di molte esperienze diverse, in alcuni casi preesistenti, tutte in qualche modo legate alla corrente modernista della danza. La Garrison, di formazione cunninghamiana e postmoderna (Judson Church Group, gruppo americano d'avanguardia, basato sul rifiuto di una tecnica classificabile per esprimere al massimo la naturalezza del movimento), con la creazione nel 1979 della sua Everyday Company, ha trasfuso in tutti gli anni della sua attività di insegnante e coreografa l'amore per la purezza di quello stile, alla cui base è il movimento come espressione, insieme all'anelito alla creazione e alla sperimentazione. Una lunga ricerca culminata nel 2004 a Roma con uno spettacolo celebrativo dei 25 anni di attività, in cui quel linguaggio è apparso ancora vivo e prezioso. Il nuovo clima di curiosità e il desiderio di sperimentazione – generato in quegli anni da una forte spinta, comune sia al teatro sia alla danza, a rifiutare i consueti modi di affrontare i testi e di rappresentare i gesti, proponendone e sperimentandone di nuovi – si sono poi saldati, negli anni Ottanta, ad analoghi fermenti presenti nell'ambiente teatrale, e hanno finito, sia pure indirettamente, per suscitare un interesse al rinnovamento anche nel campo del balletto, nel quale a lungo si erano osteggiati i nuovi metodi e i nuovi stili nati al di fuori della purezza della danza tecnico-accademica. Della generazione cresciuta alla scuola millossiana, molti erano quelli (Dell'Ara, Pistoni, fra gli altri) che possedevano piena padronanza dei cosiddetti “ferri del mestiere”. Fra tutti è emersa, verso la fine degli anni Settanta, la personalità di A. Amodio (n. 1940), alla guida di una delle esperienze più significative di aggiornamento e di rinnovamento nel campo del balletto dopo quella di Milloss, quella del già ricordato Aterballetto, con la cui formazione, nel 1979, è nata in Italia la prima compagnia itinerante di taglio moderno, indipendente dall'attività di un ente lirico, plasmata sul modello delle migliori esperienze europee e forte di un repertorio di livello internazionale comprendente opere, fra gli altri, di A. Tudor, A. Ailey, G. Balanchine, Milloss, W. Forsythe, oltre che dello stesso Amodio. Sulla scia dell'Aterballetto – e però più incline a valorizzare il talento di giovani autori italiani – si è collocato, a partire dal 1985, il Balletto di Toscana. Altre formazioni a carattere regionale, come la Compagnia di Balletto del Teatro Nuovo di Torino, il Balletto di Venezia di G. Carbone, il Balletto di Napoli creato da M. Fusco e, dal 1992, diretto da uno fra i più attivi e innovativi coreografi, L. Cannito (n. 1962), sono nate o si sono rafforzate negli anni Ottanta, affiancandosi alle pochissime esperienze superstiti nate in epoca millossiana (il Balletto di Roma, della coppia Bartolomei-Zappolini, fusosi nel 2001 con il Balletto di Toscana, I Balletti di S. Egri, che sono divenuti nel 1999 Nuova Compagnia EgriBiancoDanza, basata sullo stile accademico ma con un'apertura verso il linguaggio della danza moderna e contemporanea) e alla piccola galassia di gruppi di ispirazione modernista, legati per lo più alla figura di singoli autori-coreografi. In questo campo, a un primo momento (ispirato direttamente alle diverse fasi del modernismo americano) che aveva caratterizzato gli anni Settanta, con gruppi e autori legati di volta in volta all'eredità di Martha Graham (Piperno-Fontano, P. Cerroni), di D. Humphrey (1895-1958) e J. Limón (1908-1972) – N. Giavotto, S. Fuciarelli –, di A. Nikolais (1912-1993) – indirettamente, nel gruppo Teatro e Danza La Fenice formatosi nel 1981 intorno a C. Carlson –, o all'esperienza del puro stile Cunningham e postmoderno (R. E. Garrison, L. Latour), ne è seguito un secondo (curiosamente corrispondente al periodo di maggior decadenza dell'attività ballettistica negli enti lirici) di più acceso e però più consapevole sperimentalismo, con l'emergere di giovani artisti più indipendenti da modi e momenti dell'evoluzione coreutica di altri Paesi. Fra questi si ricordano gli ex componenti del gruppo Sosta Palmizi (G. Rossi, R. Castello, F. Bertolli, R. Giordano), compagnia che, nata nel 1984, trasformatasi nel 1990 in Associazione Sosta Palmizi, è divenuta nel 2004 Sosta Palmizi Network, ponendosi come obiettivo quello di diffondere il linguaggio della danza contemporanea in Italia e all'estero e di sostenere, con l'assegnazione di due borse di studio, coreografi emergenti residenti in Italia, ma privi di finanziamenti ministeriali. E ancora la triade formata dai coreografi M. Moricone (n. 1958), L. Cannito e M. Bigonzetti (n. 1961) legata anch'essa, per generazione, al gruppo precedente (identificato negli anni Ottanta con il generico appellativo di “nuova danza italiana”), ma più orientata in direzione di un rinnovamento in ambito ballettistico. Le iniziative legate ai gruppi emergenti, e via via affermatisi, portano a un rifiorire dell'interesse per la danza e, con esso, di una serie di attività: nascono nuove riviste specialistiche, tra cui Balletto (da non confondere con l'omonimo trimestrale, divenuto poi Balletto-oggi, di nuovo mensile), Danza & Danza e quella di studi storici La danza italiana; vengono creati centri di documentazione (a Genzano e a Torino) e si moltiplicano le traduzioni di alcuni testi fondamentali.
Danza e balletto: l’operato degli enti lirici e dei gruppi
Dalla fine degli anni Ottanta, però, lo scenario mondiale della danza registra un'involuzione sia per la morte di alcuni grandi interpreti, come Graham e Nikolais, sia per la carenza di finanziamenti insieme a una generale povertà di idee e di intraprese, sia per il declino di alcune importanti compagnie internazionali, fatta eccezione per l'Opéra di Parigi e per l'esplosione del tedesco Thanztheater di P. Bausch (n. 1940). Anche tutte quelle iniziative che, nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, avevano portato la danza su tutte le piazze e in tutti i teatri d'Italia, con la creazione di nuovi festival dedicati esclusivamente o prevalentemente a questa disciplina (Festival di Castiglioncello, Festival Oriente-Occidente di Rovereto, Ballo è Bello a Comacchio, Rassegna Invito alla Danza a Roma), nonché il moltiplicarsi di innumerevoli altre occasioni di spettacolo, tra la fine del Novecento e gli inizi del Duemila hanno conosciuto una grave crisi. In questo difficile contesto è proseguita l'attività di alcuni dei maggiori enti lirici, le cui grandi compagnie hanno permesso il consueto allestimento dei balletti di repertorio e di quelle opere divenute dei classici del moderno e contemporaneo. Per citarne due: Il Balletto del Teatro alla Scala di Milano, tornato nel 2004 alla storica sede del Piermarini, dopo il lungo restauro e le innovazioni (nuova torre scenica per consentire più allestimenti in contemporanea) che lo hanno reso più moderno e funzionale, ha prodotto, oltre a lavori ovunque apprezzati, una generazione di danzatori eccellenti (le già affermate E. Armiato, I. Seabra e A. Magyari e le più giovani S. Brazzo e M. Romagna, nominate prime ballerine nei primi anni del sec. XXI) e la conferma di artisti di livello mondiale, come R. Bolle (n. 1975), nominato étoile della Scala nella stagione 2003-2004 che, con partner di altissimo livello, ha dato vita a grandi spettacoli con struggenti e brillanti interpretazioni. Il Teatro dell'Opera di Roma, dopo un periodo di non particolare fulgore, con la direzione del Balletto di A. Amodio prima e poi di E. Terabust e C. Fracci, ha visto sensibilmente alzarsi la qualità del corpo di ballo. Al repertorio classico tradizionale si sposa l'attenzione data ai lavori dei maggiori coreografi italiani e stranieri del genere moderno e contemporaneo, quali Bigonzetti, Ailey, Limón, Amodio, Gades (1936-2004). Tuttavia proprio sul fronte degli enti lirici, la crisi si è tradotta in una vera e propria emorragia di talenti che spesso hanno preso la via dell'esilio artistico cogliendo sorprendenti successi in prestigiose compagnie straniere: seguendo l'esempio della Fracci e della Terabust, ballerine come R. Calderini e P. Cantalupo prima, A. Ferri (n. 1963), prima ballerina étoile oltre che della Scala anche dell'American Ballet Theatre di New York, e V. Durante (n. 1967), dal 1996 al 2002 al Royal Ballet di Londra, invitata a danzare all'American Ballet Theatre nel 1999, poi, per mancanza di sbocchi in patria hanno svolto all'estero la propria carriera. E ancora S. Azzoni e L. Cazzaniga all'Hamburg Ballet, M. Galeazzi al Royal Ballet di Londra, V. Pace al Ballet National de Marseille, tutte prime ballerine nel 2004. Tra i ballerini hanno dovuto cercare uno sbocco all'estero A. Molin, M. Bellezza, T. Candeloro, G. Picone che, partito dal San Carlo di Napoli, dal 1993 al 1997 ha lavorato con la compagnia dell'English National Ballet, ha debuttato all'American Ballet Theatre di New York con Cenerentola di B. Stevenson, è stato ospite in teatri e festival di tutto il mondo (Royal Ballet, Boston Ballet, Bolsoj, Festival dei Due Mondi di Spoleto) e nel 2004 è stato étoile dell'Opera di Vienna diretta da un altro grande italiano, R. Zanella (n. 1961). A questa diaspora si è aggiunta, agli inizi degli anni Novanta, la crisi potenzialmente gravissima di strutture considerate ormai tecnicamente e artisticamente solide come l'Aterballetto che, solo negli ultimi anni del decennio, con la direzione artistica (dal 1997) di Bigonzetti, succeduto ad Amodio, iniziava a recuperare, arricchendo il proprio repertorio di coreografie di nuovi e interessanti giovani artisti europei oltre ai più famosi W. Forsythe, J. Kilian, I. Galili, e ai lavori dello stesso Bigonzetti che, entrato nella compagnia nel 1982 come solista, vi aveva compiuto le più importanti esperienze come interprete e come coreografo, acquisendo una maturità tale da meritargli l'invito a creare una coreografia per il New York City Ballet. Da ricordare in questi anni anche l'operato del Balletto di Milano, compagnia attiva dalla metà degli anni Ottanta, costituita da un nucleo di danzatori di grande levatura artistica e con significative esperienze di palcoscenico, che si è distinta in tournée in Italia e all'estero (Tango… una rosa per Jorge Donn, 1999, al Bolsoj; Primadonna: le eroine del melodramma, 2000; Traviata, 2001). Parallelamente all'attività di queste compagnie si è sviluppata quella di altri gruppi minori e indipendenti, eredi dell'avventura del moderno e postmoderno; tra essi Naturalis Labor, Obiettivo Danza, Compagnia di Danza Francesca Selva, di ispirazione neoclassica, il gruppo Border Line il cui linguaggio – basato su un lavoro di sperimentazione sul corpo, su una comunicazione fondata sul rapporto “emozione-muscolarità”, dove non solo il movimento è parte integrante della rappresentazione – si serve delle contaminazioni con pittura, musica, video e voce per dare vita all'avventura scenica, la compagnia fondata nel 1982 da P. Koss (n. 1959), la cui formazione artistica, che spazia dalla sperimentazione teatrale alle arti figurative, si è sviluppata nel segno del connubio tra danza butoh (nata in Giappone nel dopoguerra e il cui senso è quello di “danza delle tenebre”) e body art. Il costante lavoro di queste compagnie, limitate spesso solo alla realtà locale, fa emergere quanto nel panorama italiano, soprattutto a opera dei più giovani coreografi, sia ancora sentita la spinta alla ricerca di un linguaggio nuovo.
Danza e balletto: le manifestazioni
Se la crisi del balletto ha portato all'abolizione di molte delle sue vetrine più prestigiose, non tutti gli spazi dedicati a questa disciplina appaiono definitivamente chiusi e, soprattutto, le nuove tecnologie sembrano offrirle buone prospettive. Intanto il Festival Internazionale di Nervi, dopo un lungo periodo di abbandono e di disinteresse, dal 1995 è tornato ad accogliere prestigiose compagnie di balletto nei suoi parchi. Anche la RAI, che aveva inserito dalla fine degli anni Settanta la danza nei suoi palinsesti, con l'istituzione nel 1977 di un fortunato programma estivo (Maratona d’estate-Rassegna internazionale di danza) e la produzione di alcuni spettacoli in cui la danza era protagonista (fra gli altri Le Divine, Pisa, 1987; gli speciali Mixer-Danza, realizzati a Venezia, Marsiglia, Madrid e New York nel 1988; Il gioco dell’eroe, Roma, 1990, con il corpo di ballo del Bolsoj di Mosca) dedica ormai scarsa attenzione agli eventi che hanno la danza per protagonista, fatta eccezione per la programmazione offerta da RAISat che, dal 1999, nelle sue trasmissioni di interesse culturale, ha riservato un certo spazio al balletto, e per il ciclo Hip Hop Generation (2004), a cura di RAI3, dedicato al ballo di strada, genere ormai entrato nella danza contemporanea. Maggiore interesse si concentra, invece, sull'attività di documentazione che le nuove tecnologie rendono più facilmente organizzabile in biblioteche e videoteche virtuali. Il patrimonio audiovisivo mondiale e italiano, infatti, è ricco di archivi consultabili via Internet, che costituiscono una fonte preziosa di informazione e comunicazione. I siti di biblioteche e centri di studio e documentazione, curati dai teatri stabili o dagli archivi storici delle arti dello spettacolo, favoriscono, oltre che l'approfondimento immediato, la diffusione del genere, come nessun altro strumento potrebbe fare. Tra i progetti più interessanti a riguardo, DanzainVideo, nato nel 1997 a opera della Discoteca di Stato, è un centro di documentazione con un archivio ricco di dati e di spunti, costantemente aggiornato e consultabile da tutti; a livello locale va ricordato il progetto Biblioteca e Videoteca di Danza, a cura dell'associazione Parallelo Dance Co., attiva in Toscana, che, con particolare attenzione alle produzioni del Novecento, costituisce un centro di documentazione importante ai fini della didattica, della ricerca e della diffusione.
Spettacolo: dal dramma liturgico al melodramma
Come negli altri Paesi europei di tradizione cattolica il teatro prese l'avvio con il dramma liturgico. La lingua era il latino, la scena l'altare, gli attori i preti stessi. Verso la metà del sec. XIII il movimento penitenziale dei Flagellanti umbri, inserito in una più generale rinascita dello spirito religioso, trovò espressione scenica nella lauda, che da composizione lirica divenne gradatamente composizione narrativa, con dialoghi in volgare, parti recitate e una vera e propria scenografia, organizzata secondo il sistema dei luoghi deputati, mentre lo spettacolo obbediva al principio della simultaneità. L'inventario della Confraternita dei Disciplinati di Perugia (1339) dimostra l'importanza assunta dagli elementi spettacolari, a scapito verosimilmente del severo spirito religioso delle origini. Il Quattrocento fu invece il secolo della sacra rappresentazione, fenomeno soprattutto fiorentino, caratterizzato dal fasto delle messinscene con macchine e congegni elaboratissimi, dall'uso della musica, dall'inserimento sempre più frequente di episodi comici e popolareschi e dal carattere di festa sempre più staccata dall'occasione religiosa ormai ridotta a mero pretesto (“festaiolo”, infatti, era chiamato il regista degli spettacoli). Gli “ingegni” inventati dal Brunelleschi per la festa dell'Annunciazione e descritti dal Vasari annunciarono i successivi sviluppi dello spettacolo rinascimentale, mentre preludio al nuovo teatro, assolutamente profano, fu il teatro goliardico della fine del Quattrocento, oggi noto soltanto attraverso alcuni testi, ovviamente in latino. Fu subito teatro per gli svaghi e le cerimonie delle élite: la corte, il palazzo, occasionalmente la piazza. La rottura con la tradizione medievale fu totale, come appare anche dalla riscoperta entusiastica dei classici, e se n'ebbe come risultato, negativo, che in Italia, anche per ragioni storiche, non si verificò un fenomeno paragonabile al teatro elisabettiano o a quello spagnolo del secolo d'oro. All'attivo va posto tuttavia il grande apporto del Rinascimento al teatro moderno, come, per esempio, nello stesso campo dell'architettura teatrale. Delle sale della seconda metà del sec. XV si ignora quasi tutto (del Serlio resta per esempio il Trattato sopra le scene nel Secondo libro d'architettura, 1545, ma non l'edificio, provvisorio, che egli costruì un decennio prima a Vicenza) e le testimonianze più antiche sono date dal Teatro Olimpico di Vicenza (1580-85), straordinario esercizio accademico condotto dal Palladio sui precetti di Vitruvio e – esteticamente forse meno perfetti ma storicamente più importanti – i teatri Olimpico di Sabbioneta (1588-90), di V. Scamozzi, e Farnese di Parma (1618-19), di G. B. Aleotti, che contengono in nuce gli elementi fondamentali della sala barocca diffusi nel sec. XVII dagli architetti italiani in tutta Europa. Tra le innovazioni scenografiche spiccano le macchine di Leonardo per le feste alla corte degli Sforza alla fine del Quattrocento; la “città bellissima con strade, palazzi, chiese, torri, strade vere e ogni cosa di rilievo” creata da G. Genga a Urbino nel 1513 per la prima della Calandria; le scene prospettiche di B. Peruzzi e, nella seconda metà del Cinquecento, i mirabolanti addobbi del Vasari per le grandi cerimonie di corte dei Medici o le favolose costruzioni di B. Buontalenti per gli “intermedi” e gli spettacoli allegorici. Nell'epoca barocca anche la scenografia praticata in Italia fu di modello a tutta l'Europa: lo spazio divenne un'entità da modificare ininterrottamente e da recuperare, come avvenne con i Bibiena, nella sua immutabilità, per suggerire, di nuovo con mezzi architettonici, lontananze vertiginose. L'attore, professionista, dell'arte (che qui vuol dire mestiere), a tutto il brulicare di congegni e di trovate oppose orgogliosamente se stesso, il proprio costume semplificato a pochi elementi essenziali, la sua mimica, il suo corpo di acrobata, la sua inesauribile fantasia buffonesca, la sua tecnica ostinatamente perseguita e disinvoltamente sfoggiata. Dai palcoscenici di corte prese a prestito gli intrecci, meri pretesti per l'elaborazione dei suoi lazzi e delle sue improvvisazioni; per il resto trovò le sue fonti d'ispirazione nelle tradizioni secolari di un teatro di piazza o di strada, tra i saltimbanchi e i giocolieri. Per la prima volta si costituirono compagnie professionali, che potevano ricorrere occasionalmente alla protezione di qualche principe e che portavano pittoresche denominazioni (gli Accesi, i Fedeli, i Confidenti, i Gelosi, ecc.); per la prima volta assunsero un'importanza determinante le attrici. Durante quasi due secoli l'Europa, Parigi soprattutto, applaudì estasiata; poi, alla fine del Settecento, la Commedia dell'Arte tornò a morire in Italia, in una Venezia dove una decina di teatri pubblici erano continuamente aperti e dove le prime rappresentazioni, le polemiche tra gli attori o gli autori, gli scandali di palcoscenico erano diventati argomento di interesse generale. Accanto al nuovo portato dall'architettura, dalla scenografia e dall'attore va posto anche il melodramma, che ebbe origine a Firenze nel 1598 con la Dafne di Peri e Rinuccini, espresse il primo capolavoro nel 1607 con l'Orfeo di Monteverdi e nel 1639 era già in grado di fornire tutto un repertorio a un teatro (il San Moisè di Venezia). Nella sola città lagunare, dove nel 1637 il Teatro di San Cassian si aprì – primo teatro d'opera in Occidente – a un pubblico pagante, furono rappresentati, fino alla fine del secolo, ben 360 melodrammi e grande spazio ebbero scenografi e scenotecnici. Poi la capitale del teatro musicale passò a Napoli e l'accento fu trasferito dai valori spettacolari della messinscena a quelli virtuosistici dei cantanti. Fino all'Ottocento e all'affermazione del grande melodramma verdiano – uno dei pochissimi esempi di grande teatro popolare della storia del nostro Paese – il teatro fu anche luogo di incontro e di ritrovo. Alle sale che già si erano imposte nel sec. XVIII per dovizia e qualità di repertorio (i teatri alla Pergola di Firenze, San Carlo di Napoli, Regio di Torino, alla Scala di Milano e La Fenice di Venezia) altre numerose si aggiunsero o furono riammodernate, come i teatri Grande di Brescia, Comunale di Bologna, Valle e Costanzi (poi Teatro dell'Opera) di Roma, Carlo Felice di Genova, Comunale di Firenze, Piccinni di Bari (cui si sarebbe aggiunto nel 1905 il Petruzzelli), Coccia di Novara, Donizetti di Bergamo, Massimo di Palermo, ecc. Accanto a cantanti lirici divenuti leggendari per la loro fama (A. Catalani, G. Pasta, M. Malibran, A. Patti, G. Bellincioni, A. Cotogni, F. Tamagno e poi R. Stagno ed E. Caruso, la cui attività si protrasse per due decenni nel sec. XX) si affermarono grandi attori, come G. Modena (1803-1861), la Ristori (1822-1906), T. Salvini (1829-1915), C. Rossi (1829-1898) e così via fino ad E. Duse (1858-1924), idolatrata interprete in Europa e in America sia di Shakespeare sia del repertorio del momento.
Spettacolo: dalle compagnie itineranti alla prime compagnie stabili
L'Ottocento fu nel teatro di prosa il secolo delle innumerevoli compagnie ancora e sempre ai margini della società rispettabile, formate in massima parte (con scritture triennali) da cosiddetti “figli d'arte” appartenenti a famiglie dove da più generazioni non si praticava altro mestiere. Alcuni raggiungevano le vette del successo internazionale, i più conducevano una grama esistenza in formazioni di guitti che percorrevano le più sperdute località di provincia. Fu anche il secolo che vide la nascita dei grandi teatri dialettali piccolo-borghesi (Torino, poi Venezia, Milano, Napoli, la Sicilia, ecc.), animati da straordinarie personalità di attori; l'apogeo e la morte della gloriosa tradizione di Pulcinella al Teatro San Carlino di Napoli; la diffusione, legata soprattutto a famiglie come quelle dei Lupi e dei Colla, del teatro di marionette e di burattini; la costituzione in Sicilia di un teatro dei pupi; l'affermazione dell'operetta (ma un repertorio italiano di qualità sarebbe nato soltanto negli anni Dieci e Venti del secolo successivo); lo sviluppo del circo; verso la fine, i primi esempi di teatro di varietà (dal caffè-concerto alle sale specializzate, con buffi e cantanti, sciantose e macchiettisti, giocolieri come Rastelli e trasformisti come L. Fregoli) e i primi tentativi (la Casa di Goldoni a Roma, il Teatro d'Arte a Torino) di organizzazioni meno precarie della normale compagnia. Questi tentativi si moltiplicarono all'inizio del Novecento (il più importante fu la Stabile Romana fondata nel 1905 dal critico Boutet e dall'attore F. Garavaglia), ma la situazione restò più o meno immutata fino al primo conflitto mondiale. Negli anni tra le due guerre si ebbero invece molte novità: le difficoltà economiche delle compagnie, dovute in parte alla concorrenza di altre forme di spettacolo, determinarono l'intervento finanziario dello Stato nel settore; apparve la figura del regista (prima di allora c'erano stati soltanto direttori di compagnia, magari eccellenti come Talli, e il termine stesso entrò nella lingua soltanto nel 1932); furono aperti alcuni teatri sperimentali, di cui il più significativo fu quello romano degli Indipendenti, diretto da A. G. Bragaglia (1890-1960); si tennero i primi spettacoli di rivista, genere che ebbe poi il suo apogeo nel decennio 1945-55, e i primi spettacoli estivi all'aperto (a quelli del teatro greco di Siracusa, iniziati nel 1914 e dal 1925 proseguiti a cura dell'Istituto nazionale del dramma antico, si aggiunsero fastose messinscene, soprattutto a Firenze e a Venezia, preludio alle innumerevoli stagioni estive del secondo dopoguerra). Il fascismo intervenne con una politica paternalistica comprendente sovvenzioni ma anche una rigida censura che tenne lontano quasi tutto il miglior repertorio europeo e che, come istituto, restò in vigore fino al 1966.
Spettacolo: il teatro di regia
C'è un evento che fa da spartiacque alla vicenda novecentesca del teatro italiano: è l'illuminante debutto registico di L. Visconti (1906-1976) all'Eliseo di Roma con I parenti terribili di Cocteau (gennaio 1945). Questa messinscena segna l'avvio anche in Italia del teatro della regia critica che ha fin da subito due indiscutibili protagonisti: Visconti, per l'appunto, a Roma, e G. Strehler (1921-1997), che al Piccolo Teatro di Milano esordisce con L’albergo dei poveri di Gorkij (1947). È in pratica l'irrompere di una cultura moderna in una scena premoderna, che nonostante gli sforzi di Pirandello negli anni Venti-Trenta continuava a rifarsi al cosiddetto teatro all'antica italiana. Ciò che voleva dire una struttura rigidamente capocomicale, repertori modesti o polverosi, allestimenti frettolosi e pressappochisti, stessi testi classici inscenati in modo sommario, senza alcun approfondimento interpretativo, arte dell'attore legata a canoni ottocenteschi, esteriorizzati e manieristici. La “riforma” attuata, pur con stili diversi, da Visconti e Strehler segna il passaggio del primato dal capocomico attore al regista non attore: figura che detiene una cultura critica della messinscena, che affronta il lavoro con un taglio interpretativo fortemente caratterizzato e personale nei confronti sia dei classici sia dei testi contemporanei, che impone prolungati periodi di prove per riuscire a plasmare un nuovo e più elaborato stile recitativo, che eleva la qualità complessiva degli allestimenti, curando ogni dettaglio, dalle luci ai costumi, dal suono alle scenografie. Tutto ciò introduce un inedito rigore etico, professionale e culturale, un metodo moderno che diventerà il più importante e, di fatto, imprescindibile modello di riferimento per tutto il teatro del secondo Novecento. Il magistero di Visconti, intrecciato con la compagnia Morelli-Stoppa e legato a spettacoli memorabili come Troilo e Cressida di Shakespeare (1949), Zoo di vetro (1946) e Un tram che si chiama desiderio (1949) di Tennessee Williams, Morte di un commesso viaggiatore (1951) e Uno sguardo dal ponte (1958) di Arthur Miller, L’Arialda di G. Testori (1961), si esplica sino all'inizio degli anni Sessanta, quando il regista decide di dedicarsi principalmente al cinema, lasciando come sua diretta erede la Compagnia dei Giovani dell'Eliseo (G. De Lullo, R. Valli, R. Falk, E. Albani, A. Guarnieri, F. De Ceresa, U. Orsini), che incarnerà l'immagine di un nuovo e sofisticato “teatro borghese”, fornendo le sue migliori prove sia rilanciando la drammaturgia di Pirandello (da Sei personaggi in cerca d’autore a Enrico IV, a Il gioco delle parti), sia consentendo l'affermazione autorale di G. Patroni Griffi (n. 1921) con D’amore si muore (1958), Anima nera (1960) e soprattutto Metti, una sera a cena (1967). A questa linea si contrappone, in un certo senso, Strehler che, grazie al decisivo contributo politico-organizzativo di P. Grassi (1919-1981), con il Piccolo di Milano fonda e impone un modello di teatro pubblico animato da una tensione pedagogico-culturale, che da un lato rivitalizza la tradizione (si veda lo spettacolo-bandiera Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, che dopo il debutto nel 1947 verrà riproposto, con F. Soleri al posto del grande M. Moretti, per oltre mezzo secolo), dall'altro importa i drammi politico-civili di B. Brecht (da L’opera da tre soldi, 1955-56, a L’anima buona di Sezuan, 1957-58, da Vita di Galileo, 1962-63, a Santa Giovanna dei Macelli, 1970-71), toccando poi forse i suoi vertici con Il giardino dei ciliegi di Čechov (1954-55), El nost Milan di Bertolazzi (1955-56), I giganti della montagna di Pirandello (1966-67), Re Lear (1972-73) e La tempesta (1978-79) di Shakespeare. Il Piccolo di Milano realizza peraltro il prototipo del teatro stabile pubblico, che verrà in seguito riprodotto, con alterni risultati, a Genova, Torino, Roma, Bolzano, L'Aquila, in Friuli-Venezia Giulia, in Sardegna, in Umbria e da ultimo a Napoli. Sulla scia di Visconti e Strehler la scena della regia critica propone vari altri protagonisti, tra cui emergono negli anni Cinquanta il veronese G. De Bosio (n. 1924), cui si deve soprattutto la riscoperta del teatro dialettale cinquecentesco del Ruzante (da La betìa a La moscheta, a Il reduce), e il livornese L. Squarzina (n. 1922), che incarna un'idea – in parte anche professorale – di teatro di cultura, svariando da Ibsen a Shaw, da D'Annunzio a Goldoni, da Shakespeare a Betti, cogliendo un significativo successo anche come autore con Tre quarti di luna (1953). Altri nomi si possono ricordare, da Missiroli a Cobelli, da Trionfo a Enriquez, da Costa a Zeffirelli, ma il vero nuovo protagonista della regia critica è L. Ronconi (n. 1933), che debutta con La buona moglie di Goldoni (1963) e firma il suo primo capolavoro nel 1968 al Festival di Spoleto con L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Ronconi sintetizza la migliore tradizione registica con gli stimoli della sperimentazione, mettendo a punto una macchina scenica magniloquente, fastosa, di impianto neobarocco, che si può esercitare indifferentemente su Giovan Battista Andreini e Schnitzler, Pasolini e von Hofmannsthal, Maeterlinck e Gadda, Kraus e O' Neill, Arno Holz e Baricco, Calderòn e l'astrofisico John Barrow. Al dominio politico-estetico di Ronconi si è sottratto un regista di spiccata inclinazione per il gioco derisorio e grottesco come M. Castri (n. 1943), i cui esiti più convincenti risalgono alle messinscene anni Ottanta-Novanta di lavori di Ibsen, Pirandello ed Euripide. Nell'ultimo scorcio del Novecento il teatro della regia critica sembra aver raggiunto un punto di saturazione. I suoi esponenti più giovani come C. Lievi, N. Garella, E. De Capitani, C. Pezzoli, P. Maccarinelli, A. Latella producono spettacoli assai ben fatti, ma con il sapore del già visto e già sentito.
Spettacolo: il teatro d’attore
Messo in sottordine dal teatro di regia, il teatro d'attore ha continuato a operare in Italia lungo due direttrici. La prima è stata quella tradizionale e convenzionale del primattore e dell'attore-mattatore, che non di rado si è incontrata, anche in modi conflittuali, col teatro di regia. Qui il nome più importante è quello di V. Gassman (1922-2000), dizione perfetta e spiccato atletismo scenico, erede estremo dell'istrione ottocentesco, ma anche interprete colto dall'Amleto del 1952 al Moby Dick melvilliano (1992), passando per Kean di Dumas-Sartre (1956), Otello (1956) – scambiandosi i ruoli principali con S. Randone (1906-1991) –, I tromboni di Zardi (1959), Adelchi di Manzoni (1960), Un marziano a Roma di Flaiano (1960), DKBC (1968), Sette giorni all’asta (1977) in un teatro-tenda, Affabulazione di Pasolini (1984). Altro primattore storico è G. Albertazzi (n. 1923), su una linea di maggiore problematicità culturale e di più acuta introspezione psicologica. A lungo in sodalizio con A. Proclemer (n. 1923), si è cimentato con molti autori contemporanei, da Brancati a Faulkner, da Camus a Miller, da Sartre a Brusati, da D'Annunzio a Terron, trovando poi nella maturità, diretto da M. Scaparro (n. 1932), il grande colpo d'ala con Memorie di Adriano dalla Yourcenar (1989), periodicamente riproposto. Il terzo rilevante attore-mattatore è G. Lavia (n. 1942), esploso come attore-regista con I masnadieri di Schiller (1982) e poi portabandiera per oltre un decennio, dalla ribalta dell'Eliseo di Roma, di un teatro attorale dai marcati tratti melodrammatici, sentimental-popolari, neodivistici. Di primattori e primattrici di classe il teatro di prosa italiano ne ha avuti e ne ha tanti: ricordiamo, oltre a Randone, G. Santuccio, L. Brignone, V. Cortese, G. Lazzarini, V. Moriconi, F. Valeri, T. Carraro, T. Buazzelli, A. Tieri, A. Lionello, T. Ferro, M. Scaccia, M. Melato, A. Foà, R. Herlitzka, tra i dialettali G. Govi, C. Baseggio e C. Durante, tra i più giovani E. Pozzi, M. Crippa, M. Popolizio. La seconda direttrice del teatro d'attore è quella dell'attore creativo o dell'attore-autore, che ha i suoi più illustri rappresentanti in E. De Filippo (1900-1984) e D. Fo (n. 1926), e che si fonda sulla centralità e il carisma dell'interprete. Eduardo ha segnato il secondo dopoguerra con commedie indimenticabili, da Napoli milionaria (1945) a Questi fantasmi! (1946), da Filumena Marturano (1946) a La grande magia (1948), da Le voci di dentro (1948) a Sabato, domenica e lunedì (1959), sino a Il sindaco del Rione Sanità (1960), capaci di intrecciare comicità e dramma, lingua italiana e dialetto napoletano, tradizione familiare e critica sociale. Ma a rifulgere è soprattutto la lezione d'attore di Eduardo, con la sua severità, la sua moderna sobrietà, la sua esemplare umanità, testimoniata dalle sue ultime, mitiche uscite in palcoscenico, nel Berretto a sonagli di Pirandello (1979) e in Sik Sik, l’artefice magico (1980). Fo, premio Nobel per la letteratura nel 1997, dopo un'iniziale affermazione (assieme alla moglie F. Rame) come brioso autore ed eccentrico interprete di lavori comici come Gli arcangeli non giocano al flipper (1959), Isabella, tre caravelle e un cacciaballe (1963), Settimo: ruba un po’ meno (1964), ha impresso una svolta culturale al suo teatro, realizzando con Mistero buffo (1969) il suo capolavoro, in cui viene riscoperto l'attore-giullare, l'uomo-orchestra, e in cui si mescolano testi medievali, vangeli apocrifi, dialetti e il gramelot (o grammelot), sproloquio grottesco-onomatopeico. Da lì, sull'onda dei movimenti del '68, Fo si impegna in un teatro di satira politica militante, da Morte accidentale di un anarchico (1970) a Pum, pum: chi è? La polizia (1972), da Non si paga, non si paga! (1974) a Il Fanfani rapito (1975), fino a L’anomalo bicefalo (2004), che lo ha proposto come una sorta di Brecht italiano. Ma su tutto spicca la sua inimitabile presenza scenica, che fonde azione mimica e irresistibile verve di affabulatore. Tra gli interpreti creativi bisogna rammentare C. Cecchi (n. 1942), anomala figura di attore-regista, irregolare allievo di Eduardo, capace di inscenare con personale estro e straniato senso critico le tragedie di Shakespeare e le farse di Scarpetta, i drammi di Büchner, Pirandello e Pinter come le commedie di De Filippo. Versione popolare dell'attore “totale” è il romano G. Proietti (n. 1940), che con A me gli occhi, please (1976) ha creato un prototipo di one-man show istrionico e parodistico, infinitamente variato e imitato da innumerevoli comici. Negli ultimi anni del Novecento la riscossa del teatro d'attore contro quello di regia è stata guidata dai cosiddetti attori-narratori, in qualche modo eredi della “linea Dario Fo”: M. Baliani, M. Paolini, L. Curino, A. Celestini, D. Enia fanno del racconto drammaturgico la forma stessa dell'atto scenico. A loro si possono affiancare interpreti creativi trasversali, quali l'attore-cantante M. Ovadia (n. 1946), legato alla cultura yiddish, e P. Rossi (n. 1953), animatore di un corrosivo teatro comico-anarchico.
Spettacolo: il teatro di ricerca e sperimentazione
L'avanguardia che esplode negli anni Sessanta-Settanta si propone fin dall'inizio come esperienza multidisciplinare. Il suo radicale impeto di energia linguistica attinge alle arti visive, all'arte concettuale, alla body art, alla danza contemporanea, all'happening, alla performance, al cinema, al video, alla più avanzata ricerca musicale. In quel ventennio i due nomi dominanti sono gli attori-registi globali C. Bene (1937-2002) e L. De Berardinis (n. 1940). Il salentino Bene incarna, con indiscutibile genialità, la sublimazione estrema e il rovesciamento nichilistico del modello del grande attore-istrione romantico ottocentesco. Il suo teatro si realizza come uno straordinario, dissacratorio pastiche culturale, che approda negli anni Ottanta – attraverso l'elaborazione tecnologica dell'artificio della phoné – alla teorizzazione su “C.B. macchina attoriale”, l'attore-narciso che si distacca da sé per creare una terremotata e straniata macchinazione vocale come esperienza recitativa assoluta, assai prossima alla musica lirica. Le tappe della sua evoluzione vanno da Caligola (1959) a Pinocchio (1961), da Salomè (1965) a Nostra Signora dei Turchi (1965), dal S.A.D.E. (1974) al Manfred (1979), da Otello, o la deficienza della donna (1979) a L’Adelchi (1984), a Lorenzaccio (1986) e poi alla lunga serie dei suoi Amleti, dal primo spettacolo del 1961 sino a Hommelette for Hamlet (1987) e Hamlet Suite (1994). Il pugliese De Berardinis (affiancato sino al 1981 dalla bravissima P. Peragallo) ha seguito percorsi scenici contraddittori e variegati, riuscendo a reinventarsi quasi a ogni decennio, mantenendo un filo di tenace coerenza con l'idea di un attore solista “free” (dal free jazz), capace di passare con personalissimo talento e sovversiva lucidità da Shakespeare alla sceneggiata napoletana, da Pirandello a Totò, dalle esperienze “selvagge” con gli emarginati di Marigliano alla Bibbia, da Dante a Leopardi. Se negli anni Settanta rimangono impressi lavori come ’O zappatore (1972), King lacreme Lear napulitane (1973), Sudd (1974), Chianto ’e risate e risate ’e chianto (1974), nella fase della maturità spiccano Novecento e Mille (1987), Il fiore del deserto (1988), Ha da passà ’a nuttata (da Eduardo, 1989), L’impero della ghisa (1991), I giganti della montagna (1994), Past Eve and Adam (1999). Significativi protagonisti del rinnovamento avanguardistico del teatro sono anche stati negli anni Sessanta registi come M. Ricci (James Joyce, 1968) e C. Quartucci, cui si devono pionieristiche e bellissime messinscene di Beckett e la collaborazione con G. Scabia per il coraggioso esperimento metadrammaturgico Zip Lap Lip Vap Mam Crep Scap Plip Trip Scarp & la grande Mam (1965). Successivamente esplode, negli anni Settanta, il movimento delle cantine romane, identificato come “teatro-immagine” per l'assoluta prevalenza della scrittura scenico-visiva sull'elemento testuale: capofila furono G. Nanni (A come Alice, 1970, con M. Kustermann), G. Vasilicò (Le 120 giornate di Sodoma, 1972), M. Perlini (Pirandello chi?, 1973), il singolare duo post-beckettiano Remondi & Caporossi (Sacco, 1973; Cottimisti, 1977), S. Carella (Autodiffamazione, 1976). A loro si aggiungono tanti altri generosi e validi sperimentatori, tra cui è giusto ricordare P. Di Marca, B. Mazzali, G. Varetto, U. Margio, G. Marini, G. Sepe, G. Colosimo, L. Natoli, S. Saltarelli. A metà degli anni Settanta si affaccia una seconda generazione del teatro di ricerca detta di postavanguardia che segna lo slittamento nella deriva del postmoderno e che dà vita a forme sceniche permeate di “pensiero debole”, di ipercitazionismo, di tecnologia e moda, risucchiate nell'immaginario del videoclip, imbevute di uno spirito di euforia edonistica, di velocità, di vibratile leggerezza. I gruppi leader di questa tendenza sono i fiorentini Magazzini (già Carrozzone e Magazzini Criminali, F. Tiezzi, S. Lombardi e M. D'Amburgo: Presagi del vampiro, 1976; Vedute di Porto Said, 1978; Ebdomero, 1979; Crollo nervoso, 1980), i romani La Gaia Scienza (G. Barberio Corsetti, M. Solari, A. Vanzi: La rivolta degli oggetti, 1976; Gli insetti preferiscono le ortiche, 1982; Cuori strappati, 1983) e i napoletani Falso Movimento guidati da M. Martone (Rosso Texaco, 1980; Tango glaciale, 1982; Ritorno ad Alphaville, 1986). In posizione defilata e autonoma agisce dal 1977 il Piccolo Teatro di Pontedera, guidato da R. Bacci (n. 1949), che si pone come principale referente italiano della linea antropologica del “terzo teatro” di ascendenza Grotowski-Barba. Ma il gruppo in prospettiva più significativo nasce nel 1981 a Cesena: è la Socìetas Raffaello Sanzio, diretta dal regista R. Castellucci (n. 1960), che nell'arco di due decenni, dai primi spettacoli neodadaisti e iconoclasti (Persia-Mondo 1 a 1, 1981; Santa Sofia-Teatro Khmer, 1986) all'imponente ciclo degli undici spettacoli della Tragedia Endogonidia (2001-04), ha saputo diventare il più importante gruppo della ricerca italiana ed europea, mettendo a punto un teatro di straordinaria eloquenza figurativa e composizione visiva, un teatro patologico e perturbante, popolato di animali ed esseri mostrificati, un teatro artaudiano di cruenta estetica, creaturale e parapolitico, percorso da palpiti spirituali e sacrali estremistici, che non vuole fare esibizionismo dell'horror, bensì proporre una contemplazione di “forme di bellezza dimenticate”. Negli anni Novanta si è infine fatta avanti una terza generazione della sperimentazione, che rimastica forme di scrittura scenica e codici tecnovisivi già ampiamente visti e manipolati, avendo come ossessione la domanda sulla “vera natura della realtà”, dunque sul cosa significhi essere reali e, in ultima analisi, essere umani. Tra installazioni necrofile e identificazione euforica con la discoteca, l'utopia teatrale appare esaurita, la plastificazione della realtà è senza via d'uscita, l'arte non può più evocare un “fuori”, essendo tutto “dentro” la mercificazione globale, l'arte è mero lavoro sulla morte del senso come “altrove”. A questo teatro manierista e nichilista sembra sfuggire la compagnia di P. Delbono (n. 1959), che grazie a spettacoli quali Barboni (1997), Guerra (1998), Gente di plastica (2002), mescolando attori “normali” e portatori di gravi handicap, ha saputo raggiungere punte di poesia-verità e di sofferta autenticità, dentro una costruzione collettiva, narrativa e musicale influenzata dalla lezione teatrale di Pina Bausch. Anche un artista solitario e orgoglioso come il milanese D. Manfredini (n. 1957) – di lui ricordiamo Miracolo della rosa, 1988, e Al presente, 1998 – ha saputo partire dalla propria condizione omosessuale per riuscire a dare un toccante senso di verità al suo genettiano gioco di “commediante, santo e martire”.
Cinema: il cinema muto
Anche in Italia, come altrove, il cinema si affacciò quale documento d'attualità. Se le primissime proiezioni pubbliche a titolo sperimentale risalgono al 1896, soltanto col nuovo secolo esse si diffusero continuativamente da Torino a Napoli. A Torino il pioniere fu A. Ambrosio (1869-1960) e il suo campo preferito, dal 1904, la cineripresa dal vero, in cui si distinse l'operatore R. Omegna (specializzatosi inoltre nel film scientifico). Il primo film italiano a soggetto, La presa di Roma (250 m), uscì invece nel 1905 dalla società romana “Alberini & Santoni”, che l'anno successivo si trasformò in “Cines”. Subito l'“Ambrosio”, l'“Itala” e le altre si convertirono al nuovo genere. Nel biennio della prima stabilizzazione industriale (1907-08) la sola produzione delle nove case di produzione attive al Nord e al Sud non bastava ad alimentare gli oltre 500 cinematografi già in funzione nella penisola, per cui si rafforzò, badando soprattutto a soddisfare la quantità, anche il noleggio. Gli italiani avevano raggiunto una particolare abilità nel concentrare in poche centinaia di metri di pellicola un numero inverosimile di accidenti. Così nacque il filone comico con protagonisti come Cretinetti e altri, che presto si esaurì dopo aver fatto intravvedere i rudimenti di un dinamismo nuovo. Ebbe invece maggior fortuna il film in costume, fermo sui moduli del melodramma e del solo romanzo “popolare” esistente in Italia, quello d'appendice. I colossi storici (Quo vadis?, 1912, di E. Guazzoni; Gli ultimi giorni di Pompei, 1913, di M. Caserini; ecc.), che nei primi anni Dieci conquistarono i mercati stranieri, riempivano in patria un vuoto che la letteratura non aveva colmato. Finché nel 1914, in Cabiria del ragionier Pastrone (1882-1959), ribattezzato Piero Fosco, avvenne ufficialmente il connubio con la cultura (didascalie di D'Annunzio), ma i meriti tecnici del grandioso spettacolo in movimento non legavano troppo con la magniloquenza del poeta. Oltre Cabiria, comunque, non fu possibile spingersi: tant'è che proprio nel 1913, mentre splendidamente si suggellava il filone eroico, si apriva (con Ma l'amor mio non muore, ancora di Caserini) quello piccolo-borghese, salottiero e divistico. I trionfi del costume, da un lato, e del divismo, dall'altro, sconfissero l'unica possibile alternativa culturale: il film naturalista e verista d'impronta meridionale, che ebbe in Sperduti nel buio (1914) di N. Martoglio (1870-1921) il modello per il momento senza futuro. Per quanto eccellente in Assunta Spina (1915), la diva F. Bertini non rappresentò la popolana, ma la donna fatale, ancora espressione di quella belle époque che affogava nel sangue della grande guerra. Il conflitto riportò in auge il documentario con le cinecronache di L. Comerio (1878-1940) dal fronte e accelerò il processo di disfacimento del cinema narrativo nelle sue correnti artificiose predominanti. Per singolari tocchi di eleganza, di intimismo crepuscolare o di eccentrismo, si potrebbero tuttavia salvare alcuni titoli (da Histoire d'un pierrot, 1913, di B. Negroni a Il re, le torri e gli alfieri, 1917, di L. D'Ambra) e certi esperimenti avanguardisti di A. G. Bragaglia (Perfido incanto e Thaïs, 1916-17), mentre un cenno merita E. Ghione (1879-1930) che, col nomignolo di Za la Mort, fu l'eroe patetico e sinistro di avventure in serie (la più nota: I topi grigi, 1917-18) sul modello francese e statunitense. “La parabola di Ghione – scrisse M. Gromo – doveva quasi essere un simbolo di quella del nostro cinema muto, che si credette invincibile, diventò megalomane, e morì squallido”. Nel 1919 l'UCI (Unione Cinematografica Italiana), il trust dei produttori cui rimasero estranei soltanto S. Pittaluga (1887-1931) a Torino e G. Lombardo (1920-2005) a Napoli, tentò invano di porre un argine all'invadenza di Hollywood e dell'UFA tedesca, senza peraltro controllare l'esercizio che invece era apertissimo alla produzione straniera, d'altronde ben più efficiente, e crollò nel 1924 con l'ultimo supercolosso (un secondo Quo vadis?, girato da G. Jacoby e Gabriellino D'Annunzio), mentre gli Americani vennero proprio in Italia a girare il loro primo gigantesco Ben Hur (1926), finito a Hollywood da F. Niblo. Né lo Stato fascista si adoperò per arrestare la crisi, pago di curare la propaganda del regime attraverso i cinegiornali LUCE.
Cinema: dal sonoro al neorealismo
Una certa ripresa (non “rinascita” come allora fu definita) si ebbe soltanto all'avvento del sonoro, quando Pittaluga riuscì a riaprire la “Cines” (1930) e poi, con la direzione artistica di E. Cecchi, si poté dar esito all'interesse per il cinema avvertito da qualche anno negli ambienti intellettuali. I due registi che avrebbero caratterizzato il decennio, M. Camerini (1895-1981) e A. Blasetti (1900-1987), realizzarono le loro opere migliori, rispettivamente Gli uomini, che mascalzoni! (1932) e 1860 (1934). Vennero invitati cineasti stranieri come W. Ruttmann e M. Ophüls, fu stimolato il documentario anche sociale (Cantieri dell'Adriatico, 1933, di U. Barbaro) e un film, Ragazzo di I. Perilli, venne vietato dalla censura. Si recepivano le lezioni stilistiche e perfino contenutistiche dall'estero: seppure a modo suo, Blasetti si era dimostrato attento ai Sovietici e Barbaro traduceva Pudovkin e altri saggi teorici innovatori. Ma il regime intervenne a “fascistizzare” il cinema, che parafrasando Lenin (“l'arte più importante”) Mussolini chiamò “l'arma più forte”. Creata nel 1935 la Direzione generale per la cinematografia, al gruppo Pittaluga in liquidazione fu sostituito tra il 1936 e il 1938 un complesso parastatale di sale (monopolio ENIC), di studi (Cinecittà) e di produzione (la terza “Cines”). Con tutto ciò, non si approdò, comunque sia, al film “fascista” (nel 1937 Scipione l'Africano, di C. Gallone, naufragò nel ridicolo) ma a una produzione, nei casi meno indegni, spettacolarmente evasiva (Blasetti) e tendenzialmente piccolo-borghese (Camerini), alimentando più la commedia dei telefoni bianchi che l'“epos virile” (cui sacrificarono A. Genina e G. Alessandrini). Anzi il Centro sperimentale, dove insegnava Barbaro fiancheggiato e protetto da L. Chiarini, e le riviste Cinema e Bianco e Nero svolsero sostanzialmente un'azione estranea o di disturbo e finirono col preparare una generazione di antifascisti. La guerra radicalizzò la contraddizione: per evitare la propaganda diretta ci si rifugiò nel formalismo e calligrafismo letterario (M. Soldati, A. Lattuada, R. Castellani) o nel documentarismo d'arte (la coppia Emmer-Gras) e mentre C. Zavattini sceneggiava la flebile protesta della piccola borghesia – Quattro passi fra le nuvole, 1942, di Blasetti; I bambini ci guardano, 1943, di V. De Sica (1901-1974), passato anche alla regia – e il comandante di Marina F. De Robertis si avvaleva di interpreti autentici per cronache di guerra “obiettive” (la più genuina e sorprendente delle quali fu la prima: Uomini sul fondo, 1941), con Ossessione di L. Visconti, in nome del verismo e di un Paese reale, la pattuglia di punta lanciò nel 1942-43 una sfida di cui, sebbene impegnato da più drammatici problemi, perfino il regime non poté far a meno di accorgersi. Resa inoperante e saccheggiata Cinecittà dai Tedeschi, spariti i produttori, l'Italia si trovò a edificare un cinema finalmente libero sulle macerie della guerra e sull'impulso della Resistenza e del suo clima ideale unitario. Era un cinema che, per la prima volta, rivelava la nazione a se stessa, non tacendo né miseria né problemi, ma sottolineando dignità e diritti di un popolo che, divenuto protagonista della storia, lo fu anche delle vicende reali dello schermo. Questo movimento si chiamò neorealismo: da un lato confluenza e maturazione delle migliori istanze del passato, dall'altro apertura verso una società tutta da esplorare. Da Roma città aperta (1945) e Paisà (1946) di R. Rossellini a La terra trema (1948) di Visconti, da Sciuscià (1946) e Ladri di biciclette (1948) a Umberto D. (1952) di De Sica-Zavattini, fu una stagione breve e gloriosa, qui ricordata nelle sue vette artistiche, ma alla quale partecipò a diversi livelli e in varie direzioni gran parte del cinema postbellico, affermando molte voci nuove. Trionfante sul piano mondiale, in patria il neorealismo ebbe una intensa ma breve primavera. La diffusione di pellicole hollywoodiane, il mutato clima di restaurazione politica, lo esaurì nella denuncia, mentre all'inizio degli anni Cinquanta aveva successo un altro cinema, in parte proveniente dai suoi cascami sostituendo alla disperazione “due soldi di speranza”, all'esame critico “pane, amore e fantasia”, ai problemi sociali le “maggiorate” fisiche, come promettevano gli stessi titoli. Una errata politica avvilì anche il fervore documentaristico dei giovani, abbinando ai film con grande incasso i prodotti più conformistici, mentre la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, sorta nel 1932, subiva un continuo deterioramento. Venne a mancare un cinema idealmente e culturalmente compatto, mentre si affermò solo il cinema delle varie personalità (Rossellini o Germi, Fellini, Visconti o Antonioni) attraverso quelli che C. Lizzani ha definito nella sua Storia del cinema italiano (1953) “i film della crisi”. Lasciato a se stesso, ciascuno di questi registi (si potrebbero aggiungere lo stesso Lizzani, A. Lattuada, G. De Santis, L. Zampa, M. Monicelli, M. Bolognini e altri) percorse una propria strada isolata, sviluppando un proprio genere personale, talvolta non senza eclettismo come P. Germi (1914-1974), che dai temi sociali (In nome della legge, 1949; Il cammino della speranza, 1950) passò all'autobiografia familiare (Il ferroviere, 1956; L'uomo di paglia, 1958), per dedicarsi infine, da Divorzio all'italiana (1961) in poi, alla commedia di costume. Più coerente si è rivelato il cammino di F. Fellini (1914-1974), che, provenendo dal sodalizio con Rossellini, sembrò, specie con La strada (1954), dilatarne la componente mistica; mentre Visconti in Senso prefigurava nello stesso anno, ma con un vigore che non avrebbe più ritrovato, la scelta per lo spettacolo fastoso cui sarebbe approdato, dopo Il gattopardo (1963), alla fine degli anni Sessanta. Tenace, contrastato e difficile fu l'avvicinamento di M. Antonioni (n. 1912), da Cronaca di un amore (1950) a Il grido (1957), al proprio mondo, che doveva pienamente affermarsi nel 1960 con L'avventura: il mondo del privato e dell'incomunicabile che, già balenante in Europa '51 (1952) e Viaggio in Italia (1953) di Rossellini, aveva caratterizzato la crisi del decennio e si sarebbe proposto in seguito a paradigma internazionale.
Cinema: la svolta degli anni Sessanta e la concorrenza della televisione
Attorno al 1960 il cinema italiano parve segnare una svolta, favorita anche da nuove situazioni ideologiche e politiche. La dolce vita (1959) di Fellini e Rocco e i suoi fratelli (1960) di Visconti costituirono con L'avventura di Antonioni l'imponente trittico dei massimi autori del momento. Si riaprirono il filone “resistenziale” e l'indagine critica sul fascismo, caddero i primi tabù (La grande guerra, 1959, e I compagni, 1963, di M. Monicelli), si affrontarono temi scottanti come la mafia e la speculazione edilizia (Salvatore Giuliano, 1961-62, e Le mani sulla città, 1963, di F. Rosi). Antonioni impostò in termini di alienazione e di nevrosi il rapporto tra civiltà industriale e individuo (La notte, 1961; L'eclisse, 1962; Deserto rosso, 1964), mentre, dopo lo spietato quadro de La dolce vita, Fellini si ripiegò a riesaminare il proprio io in Otto e mezzo (1963). In genere si accentuava il dissidio tra la realtà sociale, del “miracolo economico” oppure del sottosviluppo, e l'interiorità dell'uomo (1961: Accattone di P. P. Pasolini e Il posto di E. Olmi; 1962: I giorni contati di E. Petri; 1963: Chi lavora è perduto di T. Brass), ma ciò comunque ristabiliva, sebbene in forme di contestazione e di ripulsa, il dialogo tra cinema e società troncato dalla fine del neorealismo. Mentre M. Ferreri (1928-1997) cominciava a lanciare i suoi strali contro i pilastri dell'ordine costituito (L'ape regina, 1963), nel Vangelo secondo Matteo (1964), dedicato alla memoria di papa Giovanni, Pasolini rifletteva nei modi della sua arte l'equazione cristianesimo-marxismo entrata, oltre che nella vita spirituale, anche in quella politica con la nascita della formula governativa del “centro-sinistra”. Nel 1965 una nuova legge fu dedicata anche al cinema, per la prima volta privilegiato, almeno nelle intenzioni, quale “mezzo di espressione artistica, di informazione culturale, di comunicazione sociale”. La seconda metà del decennio, che si annunciò all'insegna dei giovani (Prima della rivoluzione, 1964, di B. Bertolucci; I pugni in tasca, 1965, di M. Bellocchio), innestò motivi e previsioni di contestazione generale sul bilancio di un periodo storico (Uccellacci e uccellini, 1966, di Pasolini; Sovversivi, 1967, dei fratelli P. e V. Taviani), mentre nel 1966 tre film di registi più esperti venivano dall'estero (La presa di potere di Luigi XIV di Rossellini, Blow-up di Antonioni e La battaglia di Algeri di G. Pontecorvo). La rivolta studentesca europea del 1968 e il susseguente “autunno caldo” sindacale in Italia, oltre alle varie nouvelles vagues cinematografiche fiorite un po' dovunque, alimentarono anche nel cinema italiano una forte tensione critica, che da una parte investì i festival (compresa la mostra veneziana, che pure aveva tentato parzialmente di rinnovarsi con la gestione Chiarini imperniata sulla qualità) e dall'altra favorì e quasi generalizzò la tendenza cosiddetta “politica”, sia in film di dibattito militante (I dannati della terra di V. Orsini nel 1968; Apollon, una fabbrica occupata e Il contratto di U. Gregoretti, rispettivamente nel 1969 e nel 1971; Sierra Maestra di A. Giannarelli e Lettera aperta a un giornale della sera di F. Maselli nel 1970; Il sasso in bocca di G. Ferrara nel 1971), sia in metafore artistico-ideologiche (Dillinger è morto e Il seme dell'uomo di M. Ferreri, rispettivamente nel 1969 e nel 1970; Sotto il segno dello Scorpione dei Taviani e I cannibali di L. Cavani nel 1970 e Uomini contro di Rosi nel 1971, senza contare le “provocazioni” intellettuali di C. Bene, che fa parte a sé), sia in polemiche spettacolari, più o meno spregiudicate e incisive di carattere “civile”, il cui modello fu Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) di Petri che, dopo gli anni del neorealismo e quelli di Fellini, riguadagnò all'Italia il premio Oscar. Nei primi anni Settanta si registrò, accanto al dilatarsi, talvolta non senza compromessi e ambiguità, dell'impegno civile (nei film di Petri, Rosi, D. Damiani, Bolognini, L. Wertmüller, F. Vancini, G. Montaldo, N. Loy e altri), anche il fenomeno della liberalizzazione in campo sessuale, per cui Pasolini fu il primo a battersi nella sua cosiddetta “trilogia della vita” (Decameron, 1971; I racconti di Canterbury, 1972; Il fiore delle Mille e una notte, 1974). Nel frattempo altri proseguirono isolatamente il loro discorso: Fellini dal Satyricon (1969) ad Amarcord (1973) e al Casanova (1976), Antonioni da Zabriskie Point (1970) a Professione: reporter (1975), Visconti dalla “trilogia tedesca” (La caduta degli dei, 1969; Morte a Venezia, 1971; Ludwig, 1973) all'autobiografico Gruppo di famiglia in un interno (1974) e al postumo L'innocente (1976). Pure Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini uscì postumo (1976) incorrendo subito nel sequestro come accadde anche a Ultimo tango a Parigi (1972) di Bertolucci, il quale da Strategia del ragno (1970) e Il conformista (1971) approdò poi all'affresco colossale di Novecento (1976). Quanto a Ferreri, ostacolato in patria (L'udienza, 1971), trasferì in Francia la propria vena apocalittica, da La grande abbuffata (1973) a L'ultima donna (1976). Bellocchio passò dall'autobiografico Nel nome del padre (1972) allo straordinario Matti da slegare (1975), film-documento sulla malattia mentale e le nuove terapie “aperte”. La Cavani raggiunse il successo internazionale con Il portiere di notte (1974); e così, nel campo della commedia di costume, D. Risi con Profumo di donna (1974) ed E. Scola con C'eravamo tanto amati (1974). Nel genere politico figurano Il sospetto di Maselli nel 1975, Cadaveri eccellenti di Rosi e Todo modo di Petri, entrambi da L. Sciascia, nel 1976. Alla corrente politico-metaforica appartiene San Michele aveva un gallo (1972), frutto di una collaborazione con la televisione; gli autori, i fratelli Taviani, gli fecero seguire Allonsanfàn (1974). E proprio la Palma d'oro vinta a Cannes nel 1977 dal loro Padre padrone significò la rivincita sul cinema commerciale di un rigoroso prodotto d'autore e di un film realizzato per la televisione, in un concorso in cui essa era riguardata come nemica. In effetti la sua concorrenza si è rivelata decisiva nel ridimensionare lo spettacolo cinematografico. Ma la televisione ha avuto senza dubbio anche un ruolo positivo, non soltanto nei casi clamorosi dei Taviani e di Olmi, che nel 1978 con L'albero degli zoccoli ripeté a Cannes il trionfo italiano, ma per aver finanziato, già a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, molti altri registi, da Fellini (Prova d'orchestra, 1978) ad Antonioni (Il mistero di Oberwald, 1980), da Comencini (Pinocchio, 1972) a Rosi (Cristo si è fermato a Eboli, 1979), a F. Giraldi (La rosa rossa, 1972; La giacca verde, 1980). E tuttavia nemmeno la televisione poteva offrire un'alternativa valida alla crisi dell'industria cinematografica, dovuta alla diminuzione del pubblico, e quindi degli incassi, a una sensibile discesa produttiva e all'invadenza crescente della produzione estera. Certamente sono emersi, nonostante tutto, alcuni giovani (Moretti e Troisi su tutti) e si sono confermati gli anziani: nel 1976 Zurlini con Il deserto dei tartari, nel 1977 Monicelli con Un borghese piccolo piccolo, Scola con Una giornata particolare, B. Bozzetto col lungometraggio d'animazione Allegro non troppo, nel 1978 Ferreri con Ciao maschio e nel 1979 con Chiedo asilo, nel 1980 Fellini con La città delle donne e Bellocchio con Salto nel vuoto, nel 1981 Rosi con Tre fratelli.
Cinema: i “nuovi comici”
Gli anni Ottanta si sono rivelati estremamente importanti per il cinema italiano, sia dal punto di vista artistico e sociologico sia da quello economico e istituzionale. Un concorso di cause ha, infatti, gradualmente ma radicalmente trasformato l'abituale corso della produzione, grosso modo suddivisa fino a quel momento tra film d'autore, alto intrattenimento e "generi bassi": la scomparsa dei grandi produttori e dei registi di punta (o l'esaurimento della loro vena), la concorrenza delle videocassette e un'offerta televisiva sempre più massiccia e invadente. Un vero e proprio spartiacque si è, così, creato fra la tradizione e l'innovazione, i linguaggi consolidati e gli stili emergenti e, quel che più conta, fra le diverse generazioni di spettatori. Anche il dibattito culturale connesso al consumo di cinema ha conosciuto un tumultuoso sviluppo, con la conseguenza di scompaginare le categorie critiche, stimolare l'interesse mediatico, incrementare il numero e l'autorevolezza delle specifiche cattedre universitarie e trasformare profondamente le pratiche del cineforum, dei revival, dei festival internazionali e delle rassegne locali. Alcuni organi di stampa, in particolare, hanno contribuito a dilatare questo dibattito, ora promuovendo esageratamente certi autori e certe tendenze ora blandendo i cinefili supportati dal boom della videocassetta e della videoregistrazione. In questa situazione il cinema italiano ha cercato faticosamente un'identità stabile e ha finito col riparare nel successo della farsa, della commedia e di una pattuglia di giovani e agguerritissimi comici. Non a caso M. Troisi (1953-1994) ha segnato l'inizio del decennio con l'enorme successo del film d'esordio Ricomincio da tre (1981), che ha trasmesso il messaggio di una gioventù disincantata e perplessa, capace di sorridere dei propri difetti e d'infondere un velo di surreale malinconia nell'irriverenza d'origine cabarettistica. Efficace nella recitazione, nella quale conferma sempre l'originalità di una dizione e di una mimica giustamente definite posteduardiane (Che ora è, 1988, e Splendor, 1989, entrambi di E. Scola; Il postino, 1994, di M. Radford), più che nella scrittura e nella regia, Troisi, con la curiosa e fortunata commedia fantastica Non ci resta che piangere (1984) in coppia con R. Benigni (n. 1952), ha consegnato, in pratica, il testimone e il primato dell'eterogenea dinastia dei "nuovi comici" all'attore toscano. Già attivo negli anni Settanta, l'esuberante Benigni ha esordito nella regia con Tu mi turbi (1982) e si è imposto con una serie di affermazioni sia presso il pubblico sia presso la critica, dal sulfureo e imprevedibile Il piccolo diavolo (1989) agli scatenati Johnny Stecchino (1991) e Il mostro (1994). I principali compagni di strada di Troisi e Benigni sono stati C. Verdone (n. 1950) e F. Nuti (n. 1955): il primo, titolare di una prodigiosa capacità di osservazione e tipizzazione, è stato autore-mattatore di camaleontici identikit generazionali (dai primi, deliziosi e rapsodici, Un sacco bello, 1980, e Acqua e sapone, 1984, a Compagni di scuola, 1988, o Maledetto il giorno che t'ho incontrato, 1992, più organici nella scrittura, nella composizione e nella direzione degli attori e percorsi da una straordinaria vena sarcastica); il secondo, prima diretto da M. Ponzi e poi regista in proprio (Io, Chiara e lo Scuro, 1983; Caruso Pascoski (di padre polacco), 1988), ha esplorato con crepuscolare egotismo l'eterno tema del rapporto. Proveniente dal teatro off milanese, M. Nichetti (n. 1948) si è mantenuto per un breve periodo al vertice della popolarità, dal felice esordio di Ratataplan (1979) all'indovinata replica di Ho fatto splash! (1980) ma in seguito l'approccio da realismo fantastico si è disperso in una maniera autoreferenziale con titoli garbati ma superflui come Ladri di saponette (1989). N. Parenti (n. 1950), prima al servizio dell'impagabile, "cattiva" e politicamente scorretta maschera di P. Villaggio (Fantozzi contro tutti, 1980), poi specializzato nelle farse “usa-e-getta" da festività natalizie come Merry Christmas (2001) e Christmas in Love (2004), a sprazzi confortate dal virtuosistico macchiettismo del duo Boldi-De Sica. Su un fronte completamente opposto agisce N. Moretti (n. 1953): abile promotore di una propria idea di cinema, che ama definire "morale”, polemico, egocentrico, carismatico, egli ha alternato l'attività di regista e di attore a quella di operatore culturale e opinion leader. Esaurita la serie prettamente autobiografica (da Ecce Bombo,1978, a Palombella rossa, 1989), ha irrobustito il suo modo di raccontare filmando (e viceversa) dividendosi tra divagazioni sociopsicologiche pungenti (Caro diario, 1993) e il pamphlet d'impegno civile (Aprile, 1998). Nel 2001 ha ottenuto un grande successo, coronato dalla Palma d'oro al festival di Cannes, con l'asciutta cronaca familiare di La stanza del figlio.
Cinema: il tramonto dei “maestri”
A partire dagli anni Ottanta la crisi del cinema d'autore, benché generalizzata, ha conosciuto qualche eccezione. S. Leone (1926-1989) ha presentato, nel 1984, C'era una volta in America, il suo capolavoro e anche una pietra miliare del cinema italiano per come sa incidere nell'immaginario collettivo una visione grandiosa e stratificata, cruda, romantica e in qualche modo "definitiva" dell'epopea cinematografica. F. Fellini, dopo essere tornato con una certa stanchezza sui propri temi (E la nave va, 1983; Ginger e Fred, 1986), è apparso vivido e conciso nell'Intervista (1987) che mette in scena in souplesse le ossessioni perdute dell'anziano regista. M. Antonioni è stato costretto, invece, a farsi quasi del tutto da parte a causa di una malattia invalidante, dopo aver realizzato lo sperimentale e irrisolto Il mistero di Oberwald (1980) e Identificazione di una donna (1982), che inserisce ardite tensioni erotiche in una cornice enigmatica e liricizzante. Anche E. Olmi e F. Zeffirelli non hanno abbandonato la scena: il primo non ritrovando la purezza espressiva di L'albero degli zoccoli nei film successivi, tra cui va ricordato il letterario e ingessato La leggenda del Santo Bevitore (1988, Leone d'oro a Venezia); il secondo impegnandosi in alcuni adattamenti letterari (Jane Eyre, 1995). Soltanto con l'icastico Il mestiere delle armi (2001) e l'affabile Un tè con Mussolini (1999) i due hanno, rispettivamente, recuperato una chiara e fervida capacità espressiva. Su una linea antagonista, vicina in qualche modo a una "militanza" artistica, invece, si sono espressi cineasti come i Taviani, M. Ferreri e M. Bellocchio. I fratelli toscani, già vincitori della Palma d'oro, si sono distinti con l'elegiaca rievocazione della guerra partigiana di La notte di San Lorenzo (1982, ancora un Premio speciale a Cannes) e con le trasposizioni pirandelliane di Kaos (1984) e Tu ridi (1988); mentre meno felice è apparsa la loro produzione successiva. Gli apologhi di Ferreri non si sono dimostrati all'altezza di quelli usciti a cavallo del 1970; si sono distinti, solo, i corrosivi e iperbolici La carne (1991), Diario di un vizio (1993) e il (quasi) pacificato epicedio di Nitrato d'argento (1996). Il più imprevedibile e anche il più geniale è apparso Bellocchio, capace di abbandonare le giovanili rabbie e denunce e di reinventarsi senza perdere, ma anzi accrescendo le peculiari doti di stile: dai problematici e benissimo recitati Salto nel vuoto (1980) e Gli occhi, la bocca (1982) all'intenso e conturbante Diavolo in corpo (1986), dal rarefatto Il sogno della farfalla (1994), che documenta l'adesione del regista alle teorie psicanalitiche di M. Fagioli, alla ricostruzione del rapimento di A. Moro da parte delle Brigate Rosse in Buongiorno, notte (2003) che suona come epitaffio dell'utopia ideologica. Tra gli alfieri dell'impegno civile non vanno, infine, dimenticati F. Rosi (Dimenticare Palermo, 1990; La tregua, 1997) e F. Maselli (Storia d'amore, 1985; Cronache del terzo millennio, 1996), che non hanno ammorbidito l'antica vis polemica, ma solo a tratti l'hanno adeguata alle mutazioni linguistiche e antropologiche suggerite dai tempi nuovi. Ancora più isolati si sono trovati i padri nobili della commedia all'italiana, resa obsoleta dall'esplosione dei succitati giovani autori-attori. Risi e Monicelli sono apparsi ancora i migliori, conservando intatti la facilità descrittiva e l'humour, mentre Comencini e Scola hanno provato a variare registro e ispirazione senza ottenere risultati davvero memorabili. Sarebbe ingiusto, peraltro, ridurre la cinematografia italiana contemporanea a un duello tra vecchi, nuovi e 'novissimi'. Almeno due nomi, infatti, hanno contribuito a sorreggere l'autorevolezza internazionale del cinema nazionale assediato dalle ricorrenti minacce di crisi: quello del siciliano G. Tornatore (n. 1956) e quello del parmigiano B. Bertolucci. Il primo ha debuttato con l'avvincente Il camorrista (1986) e si è clamorosamente affermato con Nuovo cinema Paradiso (1988, premiato a Cannes e Oscar per il miglior film straniero), accorata cronaca semiautobiografica del ritorno al paese natio di un regista disilluso. Rimproverato dalla critica di pensare e filmare troppo in grande (cioè inseguendo il magico principio hollywoodiano del bigger than life), Tornatore si espresso sotto tono in qualche titolo (Stanno tutti bene, 1990; L'uomo delle stelle, 1995), ma ha continuato a esibire in altri (Una pura formalità, 1994; La leggenda del pianista sull'oceano, 1998) il vigore e la passione di un talento impareggiabile. Quanto a Bertolucci, dopo lo spettacolare e scenografico L'ultimo imperatore (1987, vincitore di ben nove Oscar) che racconta col passo del kolossal visionario il passaggio della Cina dall'assolutismo medievale al totalitarismo maoista, ha diretto film molto meno riusciti come Piccolo Buddha (1993), Io ballo da sola (1996) e The Dreamers (2003), con la splendida parentesi del terso e dannunziano thrilling di un desiderio proibito L'assedio (1998).
Cinema: tra film d’élite e film d’intrattenimento
Si è spesso, e a ragione, sostenuto che una delle principali debolezze del nostro cinema, se non si vuole ricorrere all'abusata invettiva contro lo strapotere americano (che ha conosciuto, peraltro, i suoi momenti di stallo e i suoi travagli creativi), è diventata la carenza di cinema "medio", la fine di un intrattenimento di genere variegato e attraente. Hanno provato a invertire la tendenza molti registi, alcuni decisamente più ambiziosi e dotati, altri frenati da un inguaribile velleitarismo. Un elenco esaustivo sarebbe pletorico, ma è opportuno sottolineare innanzitutto gli sforzi compiuti in questa direzione da Salvatores, Amelio e Avati. G. Salvatores (n. 1952) ha vinto un Oscar per il miglior film straniero col gradevole Mediterraneo (1991), elogio degli eterni sogni giovanili di fuga ambientato in un'isoletta greca nel corso del secondo conflitto mondiale. La sua filmografia, assai diseguale sia negli spunti sia nel linguaggio, va dal disincantato road-movie Marrakech Express (1989) alla “ballata” Io non ho paura (2003). Già critico cinematografico, G. Amelio (n. 1945) ha affrontato da una prospettiva rigorosa e tuttavia emotiva, partecipata le ripercussioni familiari della tragedia del terrorismo e l'ulcerata sensibilità degli adolescenti emarginati nei suoi film migliori, Colpire al cuore (1982), Il ladro di bambini (1992, Gran Premio della giuria a Cannes) e Le chiavi di casa (2004). P. Avati (n. 1938) è colui che più si è avvicinato al concetto e alla pratica di un cinema mediatore tra i prodotti d'élite e quelli dozzinali: la sua strenua dedizione al mestiere si è così, generosamente, divisa tra i nostalgici Aiutami a sognare (1981), Festa di laurea (1985) e Il cuore altrove (2003), forse il suo film più commovente, e i sardonici Regalo di Natale (1986) e I cavalieri che fecero l'impresa (2001). Accanto a costoro hanno operato altri cineasti assai disomogenei per capacità tecnica, per propositi culturali, per versatilità tematica: da D. Argento (di cui si ricorda La sindrome di Stendhal, 1996) a F. Archibugi (Mignon è partita, 1988), a M. Calopresti (La parola amore esiste, 1998), da C. Mazzacurati (L’amore ritrovato, 2004) al dotatissimo M. Garrone (L’imbalsamatore, 2002, autore, secondo alcuni critici, di uno dei film italiani più sorprendenti); da S. Soldini, che ha ottenuto grande popolarità con Pane e tulipani (2000) a R. Torre (Tano da morire, 1997), a M. T. Giordana, di cui si menzionano I cento passi (2000) e la commossa saga generazionale girata per la televisione La meglio gioventù (2003).
Cinema: i problemi del Duemila
Alcuni cambiamenti, verificatisi tra la fine del Novecento e gli inizi del Duemila, hanno approfondito la crisi del cinema italiano, segnato dalle trasformazioni produttive e dai conflitti d'interesse distributivi. Prima di affrontare questi problemi, va segnalato però il trionfo ottenuto nei circuiti tradizionali da La vita è bella (1997) di e con R. Benigni: vincitrice del David di Donatello, del Gran Premio della giuria a Cannes e di tre Oscar. La ballata tragicomica dell'ometto ebreo internato in un lager col figlioletto (a cui farà credere di stare partecipando a un divertente gioco a squadre) ha fatto dimenticare una messa in scena elementare in virtù dell'intensità emotiva ottenuta con la sovrapposizione dell'orrore indicibile dell'Olocausto alla sincerità e purezza infantili. La fortuna del film, in parte provvidenziale e in parte deleteria perché pur sempre vincolata alla figura di un one-man show che utilizza il cinema spesso impropriamente, non è riuscita, tuttavia, a dare nuova linfa al cinema italiano, sempre appiattito sull'instancabile autoriproduzione dei commedianti: se, da una parte, i fratelli E. e C. Vanzina (Sapore di mare, 1983; Il cielo in una stanza, 1999), L. Pieraccioni (Il ciclone, 1996; Il paradiso all'improvviso, 2003) e il trio meneghino Aldo, Giovanni e Giacomo (Tre uomini e una gamba, 1997; Tu la conosci Claudia?, 2004, diretto da M. Venier) si sono dedicati a un paziente lavoro di consolidamento commerciale, Verdone (Sono pazzo di Iris Blond, 1996; Ma che colpa abbiamo noi?, 2002), P. Virzì (Ferie d'agosto, 1996; Ovosodo, 1997; Caterina va in città, 2003) e, soprattutto, G. Muccino (L'ultimo bacio, 2001; Ricordati di me, 2003) si sono limitati ad abbellire il genere con copioni ben congegnati e facce carismatiche. Un cinema, dunque, poco preparato ad affrontare grandi trasformazioni; la prima delle quali risale a un decreto ministeriale del 1988 che ha introdotto anche nel nostro Paese il multiplex. Rapidamente moltiplicatesi, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, le megastrutture dotate di numerosi schermi hanno, da una parte, costituito un consistente aiuto per le sale cinematografiche (un'uscita normale, che fino a pochi anni prima era di circa 60-80 copie, è diventata da allora di circa 200), ma dall'altra, non facendo coincidere una maggiore varietà con la maggiore ricchezza di proposte, hanno finito con l'aumentare il disinteresse verso la cinematografia nazionale. Il dibattito che ne è seguito si è spesso bloccato su posizioni di principio, giustamente preoccupate di preservare dall'eccesso consumistico il nostro patrimonio e la nostra memoria cinematografica (peraltro premiati dal crescente interesse per le attività di restauro dei negativi compromessi e delle copie danneggiate, avviato dalla nascita nel 1991 dell'associazione Philip Morris Progetto Cinema), ma tendenti a sottovalutare con troppa disinvoltura il problema di rendere davvero competitivo il prodotto, troppo spesso tenuto in vita dalle sovvenzioni statali in un mercato che sia veramente libero e di respiro europeo (obiettivo, per esempio, risolutamente perseguito in Francia). Il dibattito, comunque, ha evidenziato i principali nodi da sciogliere della cinematografia nazionale: il mutamento del ruolo dei produttori in quello di meri finanziatori; la scarsissima produzione di genere; l'involuzione professionale degli sceneggiatori; l'inadeguato ricambio del vecchio star-system con più moderne, ma altrettanto carismatiche figure d'attore; l'indisponibilità degli spettatori (sia degli amanti del cinema d'essai sia di quelli del sabato sera) a qualsiasi rischio, contaminazione, variazione di gusto o di prospettiva; le responsabilità dei media. Forse, come ha sostenuto Lizzani in un convegno di fine millennio, continuano a esistere buoni film italiani e persino eccellenti, ma è venuta meno la traccia di un'identità culturale, di un cinema riconoscibile come "italiano" da tutti; andrebbe però, a questo punto, stigmatizzato lo strapotere del regista-autore, feticcio intoccabile della cultura e della critica, nonché tutto ciò che questa esaltazione ha comportato in termini di solipsismo, arroganza, sottovalutazione del mercato e di un corretto rapporto tra risorse e risultati. Alla crisi più o meno cronica del cinema, certamente non arginata dai finanziamenti erogati dall'apposita commissione ministeriale, ha fatto da contraltare la crescita vigorosa di RAI Cinema, la società creata dalla televisione di Stato per coprodurre copioni interessanti insieme a una serie di produttori indipendenti. In effetti grazie all'illuminata direzione di C. Macchitella, la RAI ha raggiunto una serie di egregi risultati; anche se, talvolta, ha polemizzato troppo per la mancata premiazione dei "gioielli di casa" (come nel caso di Buongiorno, notte e Le chiavi di casa, presentati a Venezia rispettivamente nel 2003 e nel 2004). Meriti indiscutibili si sono guadagnati anche i distributori (Bim, Academy, Mikado, Keyfilms e Lucky Red), che hanno portato in sala il cosiddetto cinema di qualità, facendo conoscere cinematografie e registi altrimenti destinati a restare ignoti o emarginati e procurandosi nei festival (dalla stessa Mostra di Venezia al Torino Film Festival, dalla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro al Taormina FilmFest), sempre più spesso affidati ad agguerriti cinefili come A. Barbera o M. Müller, un'adeguata cassa di risonanza. Un imprevisto pericolo è per loro sopraggiunto sia dalla ristrutturazione dell'intero segmento tv, per cui potrebbe venire meno il vitale supporto della vendita dei diritti alle televisioni pay e free, non sostituibili con i soli introiti provenienti dal video e soprattutto dall'aumento esponenziale del DVD; sia dal dilagante fenomeno della pirateria, un fenomeno mondiale che nel nostro Paese sembra assumere dimensioni macroscopiche. Il fatto è che le forme attuali di consumo di cinema e di televisione hanno mostrato la rottura dei paradigmi, delle strutture, delle strategie che avevano reso apparentemente invincibile la televisione cosiddetta generalista. Anche in seguito all'uscita di scena di Tele+ (per alcuni anni uno dei maggiori finanziatori del cinema italiano) e all'avvento del magnate Murdoch di Sky, è apparso chiaro che il problema va inquadrato in un ambito globale, dove il cinema possa essere aiutato per poter affrontare le nuove sfide di un sistema audiovisivo pienamente integrato. Su un piano, per così dire, parallelo, si è registrato l'incremento della fiction televisiva: il dato non è trascurabile perché molti registi di spicco e molti emergenti stanno lavorando in questo ambito con notevoli risultati (basti pensare alla succitata La meglio gioventù), dimostrando come la fiction sia percepita dal pubblico (l'audience) popolare che una volta affollava le sale cinematografiche. Lo specifico televisivo, per la verità, è stato caratterizzato dal boom della serialità modellata su un target italiano (Un posto al sole, Vivere, Incantesimo, Un medico in famiglia): ma se i suoi meccanismi narrativi leggeri – cioè prodotti con strutture più snelle e ritmi di realizzazione standardizzati – riusciranno a sostituire la "vecchia" fiction, varietà e talk-show è questione aperta. La sfida, in ogni caso, ha acceso un vivace dibattito tra i networks, da una parte, e i produttori, gli sceneggiatori e i registi, dall'altra: se la fase di sperimentazione ha prodotto flop e scompensi, è apparso sicuramente avvincente il doversi confrontare con un linguaggio molto codificato e riuscire a far passare attraverso di esso i propri stili e le proprie emozioni (come è riuscito, in campo internazionale, a cineasti del livello di Altman, Lynch o Spielberg).
Cinema: i registi “locali”
Un discorso a parte meritano da ultimo alcuni registi che sembrano legati a realtà locali: primi tra tutti i registi napoletani, che hanno rinsaldato il mai disciolto legame con la tradizione nata agli albori del cinema nazionale. Non è certo possibile inquadrarli in una scuola, in una bottega artigianale e neppure in una comunità ideale, come si è visto nel fallimentare film collettivo I vesuviani (1997), ma è indubbio che la personalità rifondatrice sia stata quella di S. Piscicelli (n. 1948). Dopo l'exploit di Immacolata e Concetta (1978, Pardo d'argento a Locarno), l'ex critico cinematografico ha ribadito la sua vena lucida, impregnata di una napoletanità antiprovinciale, influenzata da Rossellini, dal teatro della crudeltà e dalla rilettura del melodramma americano operata dal nuovo cinema tedesco, con Le occasioni di Rosa (1981), Blues metropolitano (1985), Regina (1987) e, dopo un lungo silenzio, con la storia della "scandalosa" passione senile di Il corpo dell'anima (1999). Tra gli epigoni il più apprezzato è stato M. Martone (n. 1959) che, con l'eccezione di Morte di un matematico napoletano (1991) e L'amore molesto (1995), ha, però, dato il meglio di sé nel teatro off. A. Capuano (n. 1940) ha esordito con l'agghiacciante racconto di malavita adolescenziale Vito e gli altri (1991), per poi oscillare tra neoespressionismo grottesco (Polvere di Napoli, 1998) e noir iperrealista (Luna rossa, 2001), mentre P. Corsicato (n. 1960) ha esplorato con impagabile colorismo naïf una Napoli astratta e kitsch, mitologica e pacchiana, ancestrale e futuribile tanto nei riusciti Libera (1993) e I buchi neri (1995) quanto nel fiacco Chimera (2001). Se i "vesuviani" (ai quali si deve almeno aggiungere l'intenso P. Sorrentino di L'uomo in più, 2001, e Le conseguenze dell'amore, 2004) si sono distinti per l'incontro/scontro con gli ingombranti modelli del passato – tra i quali si possono includere nomi come quelli dei De Filippo, De Sica e Totò –, più occasionali sono apparsi i campioni della comicità "alla toscana" (Benigni, Nuti, Pieraccioni, Virzì, Panariello, Ceccherini) e più marginali i siciliani Ciprì e Maresco, che hanno esordito con Lo zio di Brooklyn (1995) dilatando la disperata subumanità che aveva caratterizzato i loro corti per Cinico Tv di E. Ghezzi. Per rimanere in un ambito regionalistico si deve, però, aggiungere che l'esordio più rilevante in assoluto è stato quello di A. Piva (n. 1969) con LaCapaGira (1999), un pulp a basso costo, rapsodico e feroce ambientato nei recessi malavitosi della Città Vecchia di Bari e recitato in dialetto stretto da attori locali con un'incredibile comunicativa.
Folclore: generalità
Del ricchissimo mondo delle tradizioni di un tempo (il “folclore” o “cultura popolare” o “delle classi popolari”, come viene chiamata anche dagli specialisti) sopravvive, nell'Italia del sec. XXI, forse più di quanto non si creda. Va detto, infatti, che si assiste molto spesso, anche a livello popolare, e ormai da almeno un trentennio, a una ripresa dell'interesse per il folclore e a una rivalutazione della cultura tradizionale, concretizzatesi sia nell'allestimento di raccolte etnografiche e di veri e propri musei (alcuni dei quali ormai di notevole rilievo per la quantità e qualità dei materiali e delle collezioni esposte; si pensi al Museo etnografico Luigi Pigorini di Roma), sia in iniziative e revival di vario genere, dotati di maggiore o minore rigore scientifico e interpretativo. Nuovi studi hanno, inoltre, individuato anche in aree altamente industrializzate testimonianze folcloriche e rituali propiziatori, invernali e primaverili, che si credevano propri esclusivamente di zone arretrate o depresse. Un esempio notevole è offerto dalla festa della Giubiana di Cantù, in provincia di Como, il cui nome, che significa 'strega', si ricollega a quello del giovedì, il giorno in cui si credeva che le streghe si riunissero per il sabba; essa oggi è una grande pupazza, dal poco consueto aspetto provocante (in ricordo della leggenda secondo la quale una giovane donna traditrice avrebbe in passato consegnato al nemico le chiavi della città), che viene bruciata in pubblico, secondo un rituale facilmente rinvenibile anche in altre regioni, e in tutta Europa, e legato ad antiche credenze per allontanare il male dalla comunità. Ciò non significa, però, che non esistano, accanto ad aspetti del patrimonio tradizionale in cui prevale la continuità, altri in cui si sono registrate fratture e interruzioni, seguite a loro volta da riprese impreviste e rilevanti (è il caso, per esempio, di alcune feste e forme drammaturgiche quali il brescello toscano), e altri ancora in cui, invece, osserviamo perdite irreversibili, non solo nel vasto settore delle arti e dei mestieri più tradizionali – che spesso sopravvivono a se stessi solo grazie al turismo – ma anche nella conoscenza e nelle modalità di sfruttamento del territorio e nella pratica di certe forme convenzionali di cerimonialità, non sempre di ambito religioso (come i “cònsoli”, cioè la preparazione e l'offerta di cibo a famiglie colpite da gravi lutti da parte di parenti, amici o vicini di casa, tipici del Mezzogiorno), fortemente osteggiate, oggi, dalle forme di convivenza più radicate nei nostri centri urbani (e non solo).
Folclore: cultura materiale e arte popolare
L'intaglio e la lavorazione del legno di tipo tradizionale sono ancora praticati da pastori e contadini di varie regioni, dalla Sardegna all'Abruzzo, alla Basilicata (tipici i cucchiai e i forchettoni con il manico impreziosito da forme animali di Tricarico, in provincia di Matera), nonché in Valle d'Aosta e in altre zone e vallate alpine: piuttosto noti sono i giocattoli in legno di Ortisei, in provincia di Bolzano, e il caffè valdostano, recipiente basso e di dimensioni variabili, con un numero di beccucci che può essere anche superiore a otto (vi si versa, attraverso la larga apertura centrale, una miscela di caffè bollente, scorza di limone e abbondante grappa, poi bevuta a turno dai commensali). Antichissima tradizione hanno anche le ceramiche, con un'impressionante varietà di forme e di motivi decorativi, dal più semplice vasellame grezzo (piatti, vasi, brocche, anfore) per la cucina o per la tavola (ancora prodotto, per esempio, a Grottaglie, a Grottole, o a Seminara), che spesso riproduce modelli molto antichi, fino a pezzi dipinti e decorati in cui è evidente l'influsso di vere e proprie scuole d'arte colta, o che hanno a loro volta influenzato il gusto di committenze di estrazione non popolare (come si osserva a Faenza, Albisola Marina, Deruta, Castelli, Vietri sul Mare, Caltagirone, ecc.). La creazione di splendide figure in terracotta o in cartapesta di varie dimensioni, e quasi sempre con soggetti che si richiamano alla tradizione del presepio, è fiorente in varie zone del Mezzogiorno, come Napoli, la cui celebre via San Gregorio Armeno e zone limitrofe sono state sede di botteghe fin dal Settecento, il centro storico e numerose cittadine in provincia di Lecce (dove l'arte della cartapesta giunge a livelli di perfezione davvero notevoli) e la già ricordata cittadina siciliana di Caltagirone. In disuso, tranne in pochi comuni alpini e dell'Italia meridionale e insulare (soprattutto della Calabria e della Sardegna), la consuetudine di indossare i costumi locali, in particolare quelli femminili, un tempo ben differenziati da regione a regione, e addirittura da comune a comune, e presenti finanche in versioni diverse (quotidiana, festiva, nuziale, vedovile, ecc.; ricchissimi i costumi sardi e quelli delle comunità albanesi di Basilicata, Calabria e Sicilia); persistono, invece, in alcuni centri che si sono via via specializzati, fome antiche di artigianato tipicamente femminile come il ricamo a mano, per esempio nel Vercellese (dove sopravvive l'arte del puncetto, pizzo in cotone formato da tanti piccoli nodi scorsoi), a Chiavari (nota per il macramè, tecnica di annodatura, esclusivamente manuale, di origine araba, adatta per le bordure di asciugamani di lino), in alcuni comuni della Brianza (dove si produce la raffinata trina milanese), sull'isola di Burano (famosa per la lavorazione all'ago di punti locali, come il punto Venezia e quello Burano), ad Assisi (che ha anch'essa un punto locale), a Offida, Pescocostanzo, Scanno e Isernia (qui è di antica tradizione il merletto a tombolo), nella Sicilia orientale, a Sortino e a Vittoria (dove si ricama lo sfilato siciliano). Anche la tessitura di tappeti, coperte e arazzi con antichi telai azionati manualmente è tuttora praticata – dando vita a prodotti di pregio o di grande effetto cromatico – in diverse località, fra cui la Valtellina (patria di un tappeto rustico chiamato pezzotto), il Cadore (noto per coperte e tappeti in patchwork), il Casentino (dove è rifiorita la tradizione del panno-lana), Pescocostanzo (che produce coperte e tappeti da tavola in lana detti bancali, con il tipico motivo della “fontana d'amore”), San Leucio (forse il luogo più noto dove broccati e damascati vengono ancora rifiniti a mano, all'interno della seteria borbonica), Longobucco (dove si tesse la seta cruda o capisciola assieme con la ginestra), la Sardegna (per esempio nel Nuorese, in Barbagia, in Gallura e nel Goceano), isola in cui è diffusissima anche la colorazione naturale della lana tramite sostanze vegetali. Tuttora abbastanza vitale – malgrado il declino vissuto a causa della forte concorrenza della produzione industriale su più larga scala – è pure l'oreficeria popolare, che ha i suoi centri a Campo Ligure, Scanno e Pescocostanzo, San Giovanni in Fiore, Bosa, Oliena e Dorgali; fra i prodotti più caratteristici, da ricordare la filigrana ligure, gli anelli, le collane e le spille abruzzesi, le maschere beneauguranti e le icone calabresi, le fedi filigranate sarde. Tipica di molte regioni alpine (Friuli) e centro-meridionali (Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria) è la lavorazione del ferro battuto e del rame, spesso per realizzare prodotti divenuti poi simboli della cultura regionale, come la conca di rame ciociara e abruzzese-molisana (un tempo usata per il trasporto dell'acqua). Tra le forme di artigianato più specializzate o particolari, si ricordano infine, a mo' di semplici esempi, la lavorazione della pietra ollare in Valle d'Aosta e Lombardia (Chiesa in Valmalenco), la costruzione delle zampogne a Scapoli, la fusione delle campane ad Agnone, la lavorazione del corallo a Torre del Greco, l'intreccio degli arbusti di asfodelo nelle zone interne della Sardegna e della palma nana sulle coste del Sassarese.
Folclore: riti e tradizioni del ciclo dell’anno
Mentre i rituali legati al ciclo della vita sono andati quasi completamente scomparendo nella seconda metà del Novecento (solo in Basilicata e in alcune zone della Sardegna sopravvivono forme antiche di pianto funebre rituale), numerose sono ancora le feste di contenuto genuinamente folclorico che vengono celebrate durante l'arco dell'anno. Rituali invernali di propiziazione con accensione di falò sono segnalati in diverse località dell'Italia settentrionale, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, e anche al Sud e in Sardegna (spesso ricollegati al culto di sant'Antonio abate). Tuttora radicato, malgrado il dilagare dei divertimenti in ogni periodo e stagione, è il carnevale, che, se in alcune località ha sviluppato l'aspetto satirico proprio del tradizionale processo in cui venivano messi in piazza episodi e “fattacci” della comunità – in una sorta di confessione pubblica dei peccati – fino a trasformarsi nella sfilata dei carri allegorici (come a Viareggio, in provincia di Lucca), altrove ha mantenuto tracce più evidenti dell'originaria natura trasgressiva, grazie alla quale era lecito il totale sovvertimento dei divieti e delle convenzioni sociali (si pensi alla battaglia delle arance del carnevale di Ivrea, in provincia di Torino, in cui vi sono anche due elementi propiziatori, la gara e l'arancia, frutto dotato del potere di procurare abbondanza), nonché del carattere ctonio, demoniaco proprio delle feste invernali pagane, nelle quali i morti ritornavano sulla Terra, e di cui sono un lontano ricordo i travestimenti mascherati di oggi. Tra i carnevali arcaici, che rivelano un antico strato culturale paleoeuropeo, va annoverato senz‘altro quello di Mamoiada, in provincia di Nuoro, caratterizzato dai mamuthones, dodici inquietanti personaggi, vestiti di pelliccioni scuri e con i volti coperti da nere maschere di legno, che avanzano agitando pesanti campanacci. In molti paesi ancora oggi si celebra un processo burlesco in cui Carnevale, variamente personificato, viene riconosciuto colpevole di tutte le malefatte compiute nell'ultimo anno e, la sera di martedì grasso, si brucia un fantoccio che lo rappresenta. La sopravveniente quaresima un tempo era rigidamente osservata: essa era, ed è, perciò rappresentata da una vecchia megera, un fantoccio che a mezza quaresima viene segato a metà (come, per esempio, a Forlì), facendone uscire fichi, noci, ecc. Sempre sentiti e seguiti, un po' in tutto il Paese, sono i riti della Settimana Santa, che al Nord assumono non di rado l'aspetto di lunghe e complesse rappresentazioni sacre, organizzate periodicamente con il concorso di tutta la popolazione, e a volte trasferite nel periodo estivo (così è per la Passione di Sordevolo, in provincia di Biella, che ha come base un antico testo in versi di Giuliano Dati, o per la processione di Valverde a Rezzato, in provincia di Brescia, il 26 luglio), mentre al Sud mostrano piuttosto un marcato aspetto penitenziale, con sfilate di confratelli incappucciati che intonano canti drammatici (così ad Alatri, Chieti, Taranto, Caltanissetta) e, in qualche caso, la presenza di flagellanti e battenti, i quali, per esempio, a Nocera Tirinese (provincia di Catanzaro), incoronati di spine e vestiti lasciando interamente scoperti le cosce e i polpacci, si percuotono a sangue con un disco di sughero al quale sono attaccati dei pezzi di vetro. Assai particolare la rappresentazione denominata I Giudei, a San Fratello, in provincia di Messina. Suggestive e gioiose sono invece le processioni della domenica di Pasqua che hanno come protagoniste le statue del Cristo risorto e della Vergine, come nel caso della Madonna che scappa in piazza di Sulmona, in provincia di L'Aquila. Il Calendimaggio ha ormai perduto gran parte dell'importanza di cui era dotato nella società contadina di un tempo, rimanendo soprattutto come forma drammaturgica estremamente stilizzata celebrante la primavera e l'amore, o anche di argomento epico-leggendario, in molte zone della Toscana (dove si chiama anche brescello; un legittimo erede del Maggio drammatico toscano è poi il Teatro povero di Monticchiello, nel Senese) e nell'Appennino modenese e reggiano. Altri antichi rituali agresti primaverili, conciliatisi da tempo con la tradizione cristiana, si sono però mantenuti da un lato sotto forma di infiorate, spesso organizzate durante il Corpus Domini (famosa quella di Genzano, uno dei Castelli Romani), dall'altro come riti arborei collettivi nei quali meglio si scorgono gli elementi arcaici di fertilità, di cui è un esempio, fra i molti altri, al Nord come al Sud, la festa del Maggio di Accettura, in provincia di Matera, che, in occasione della Pentecoste, prevede l'unione, cioè l'innesto l'uno nell'altro nella piazza del paese, secondo un complesso rituale, di due alberi prescelti, il Maggio e la Cima. Da segnalare anche le antiche feste estive di ringraziamento per il raccolto, dove il motivo originario dell'offerta votiva del grano e dei prodotti della Terra ha assunto nel tempo interessanti forme di spettacolarizzazione, tipiche della fase barocca, con costruzioni di altissimi obelischi e di carri processionali interamente decorati con spighe (essi caratterizzano le feste campane di Fontanarosa, il 14 agosto, di Foglianise, il 16 agosto, e di Mirabella Eclano, il terzo sabato di settembre). Nel periodo invernale cadono le feste in cui tradizionalmente si fanno regali ai bambini. Se oggi come festa dei doni prevale nettamente il Natale, dominato dalla figura del Babbo Natale di importazione angloamericana, un tempo non lontano altre ricorrenze avevano in questo senso maggiore importanza: il giorno dei morti in Sicilia, altrove Santa Lucia, a Roma la Befana (nome derivato da epifania). Le antiche tradizioni invernali e natalizie non sono però scomparse dappertutto: l'arco alpino centrorientale, per esempio, ha manenuto viva la tradizione del san Nicola mitteleuropeo (l'antenato di Babbo Natale-Santa Claus), il quale, a Tarvisio (provincia di Udine), tanto per ricordare un esempio, la sera del 5 dicembre appare per le vie del paese raffigurato come un anziano santo-vescovo accompagnato da un corteo di maschere diaboliche, da lui tenute a bada: tutti i bambini si chiudono in un locale e lì attendono l'arrivo del santo, che li rassicura, fa promettere loro di essere buoni e poi dà loro piccoli doni. Pellegrinaggi e feste religiose presso santuari e chiese isolate sono anche oggi ricorrenti sia nelle zone montane del Settentrione, sia nel Centro e nel Sud. Fra queste, ricordiamo il Bacio delle croci di Zuglio (provincia di Udine), nella cui pieve di San Pietro, il giorno dell'Ascensione, convergono da secoli, provenienti da tutte le chiese parrocchiali della zona, trentadue croci, adornate con lunghi nastri multicolori che, una volta giunte sul posto, dopo la Messa, devono essere inclinate per “baciare” la grande croce “matrice” della pieve; da ricordare, perché ancora molto seguiti, anche il pellegrinaggio al santuario della Santissima Trinità sul Monte Autore (Roma), tra Lazio e Abruzzo (prima domenica dopo la Pentecoste e il 26 luglio); quello al santuario della Madonna dell'Arco di Sant'Anastasia, presso Napoli (lunedì dell'Angelo); il pellegrinaggio alla grotta di San Michele Arcangelo, sul Gargano (8 maggio e 29 settembre), tra i più antichi in assoluto, e quello alla Madonna di Polsi, sull'Aspromonte, non molto lontano da San Luca, in provincia di Reggio di Calabria (1-3 settembre). Spesso, nel corso del pellegrinaggio, sopravvivono comportamenti devozionali extraliturgici di origine contadina (giri rituali dell'edificio sacro, suppliche ad alta voce, inserimento negli interstizi delle cappelle sacre di biglietti con le richieste di grazia o di banconote, ecc.), a lungo combattuti dalle autorità ecclesiastiche, ma spesso in grado di convivere pacificamente con i riti e le celebrazioni ufficiali.
Folclore: feste e spettacoli di origine religiosa e laica
Gare, sfilate e ricostruzioni storiche, originatesi da ricorrenze tanto religiose quanto civili, rappresentano ormai una parte importante del folclore italiano, collocandosi tra le feste che, oggi come un tempo, più colpiscono i visitatori stranieri. Tra esse, particolarmente frequenti e fiorenti nel Centro-Nord, in antichi liberi Comuni, ricordiamo la partita a scacchi di Marostica, in provincia di Vicenza (seconda settimana di settembre degli anni pari), il gioco del calcio in costume a Firenze (24 giugno), il palio della Balestra a Gubbio, in provincia di Perugia (ultima domenica di maggio), e a Sansepolcro, in provincia di Arezzo (seconda domenica di settembre), la giostra del Saracino nella stessa Arezzo (in giugno e settembre), la giostra della Quintana ad Ascoli Piceno (prima o seconda domenica di agosto) e a Foligno, in provincia di Perugia (seconda e terza domenica di settembre). Anche se molte di queste feste e rievocazioni sono state ripristinate dopo un periodo di abbandono più o meno lungo, non di rado con l'intenzione di sfruttarle a scopo turistico, ciò non significa che esse siano in tutto e per tutto "finte" o "false", potendo spesso riscontrarsi una notevole e sentita partecipazione popolare. Un caso a parte – sia per la lunga e ininterrotta tradizione, almeno dal Trecento, sia per il fortissimo coinvolgimento emotivo dell'intera comunità cittadina – è rappresentato dal Palio di Siena (2 luglio e 16 agosto), mentre la componente turistica si mostra ormai prevalente nel caso della regata storica sul Canal Grande a Venezia. Ugualmente spettacolari sono quelle feste all'interno delle quali si sono sviluppati grandi e variopinti macchinari in legno e/o cartapesta di varia forma e dimensione, originatisi o dalla competizione fra le corporazioni medievali, e portati a spalla nell'ambito di gare di abilità (così è nel caso della corsa o festa dei Ceri a Gubbio il 15 maggio, o dei gigli di Nola, in provincia di Napoli, la domenica successiva al 22 giugno), oppure da riti mariani ricorrenti nel vivo della stagione estiva, perpetuando in chiave cattolica culti preistorici ad acque sorgive ecc. (come accade per la processione dei Candelieri a Sassari, il 14 agosto, per la passeggiata dei Giganti e la processione della Vara, carro con l'immagine della Vergine, a Messina, il 14 e 15 agosto, e per la Madonna di Settembre, con la processione della macchina di santa Rosa, a Viterbo, il 3 settembre). Grande partecipazione hanno infine le feste dedicate ad alcune sante patrone di grandi città del Meridione, o a immagini mariane molto venerate, che spesso si svolgono nell'arco di più giorni, con rituali assai complessi e cambiamenti anche notevoli nel corso del tempo (per esempio la festa di santa Rosalia a Palermo, dal 9 al 15 luglio e il 3 e 4 settembre, quella di sant'Agata a Catania, dal 3 al 5 febbario, la processione di sant'Efisio a Cagliari, dall'1 al 4 maggio, la festa della Madonna del Carmine a Napoli il 16 luglio, ecc.). Cavalcate e gare di abilità, alcune forse di remota origine nuragica, altre certamente spagnola (come la Sartiglia di Oristano, domenica e martedì grasso), caratterizzano il vivace panorama festivo folclorico della Sardegna.
Folclore: rappresentazioni e danze popolari
Ancora abbastanza diffuso è in alcune regioni il teatro di burattini e di marionette, il primo con spettacoli improvvisati su un canovaccio e risalenti spesso alla Commedia dell'Arte (come nel caso delle guarattelle napoletane), il secondo con specifici copioni. L'opera dei pupi siciliana – che rappresenta anche un'importante intersezione con l'arte popolare dell'isola, essendo il frutto della stretta cooperazione tra più forme artigiane specializzate (legno intagliato e scolpito, ferro battuto, tessitura e sartoria) – ha un ampio repertorio che narra le gesta di Orlando e dei paladini di Francia in lotta assieme a Carlo Magno contro i Mori infedeli, i cui copioni si rifanno spesso, in modo più o meno diretto, ai poemi cavallereschi del Rinascimento. Oggi, dopo un lungo periodo di crisi dovuto alla concorrenza di cinema e televisione, l'opera dei pupi (ancora distinta nelle due "scuole" principali, la palermitana e la catanese) è diventata uno dei migliori “ambasciatori” della cultura popolare siciliana in Italia e all'estero, e i suoi spettacoli – anche se non più organizzati come un tempo in lunghi cicli a episodi o a puntate – sono di nuovo assai richiesti. Tipicamente siciliani e meridionali sono anche i cantastorie (pupari e cantastorie spesso nascevano nelle stesse famiglie di artisti, o collaboravano tra loro), cantanti girovaghi che, con l'ausilio di una chitarra e, spesso, di grandi cartelloni a colori divisi a riquadri (uno per ogni scena), raccontano cantando in versi o in prosa episodi tragici di cronaca (erano i “quotidiani” di una cultura prevalentemente orale). Fatta qualche eccezione (come, per esempio, per il ballo tondo sardo, o duruduru, intatta sopravvivenza delle arcaiche danze in cerchio), le danze popolari (compresi la tarantella e il saltarello) godono di un ormai scarso seguito, ricoprendo quasi solo funzioni di promozione turistica, anche se va segnalata la perdurante vitalità di forme di danza armata che risalgono a riti agresti propiziatori basati sul principio della lotta, come il ballo degli spadonari di Giaglione, in provincia di Torino, o i balli delle sciabole (bal do sabre) di altri centri piemontesi, o la 'ndrezzata, ballo con bastoni tipico di Barano d'Ischia, in provincia di Napoli. Le esecuzioni musicali possono essere sostenute da strumenti di impiego esclusivamente popolare (il flauto di canna, il firlinfeu brianzolo, erede del flauto di Pan, le arcaiche launeddas sarde, la zampogna, lo scacciapensieri o marranzanu, il tamburello, il tamburo a frizione o putipù, ecc.), o dalla chitarra, dal violino, dal mandolino, dalla fisarmonica, che sono (questi ultimi) anche gli strumenti tipici dei cantastorie e dei suonatori ambulanti. Gli strambotti, i rispetti, gli stornelli, le villotte, che costituiscono la vastissima categoria del cosiddetto canto lirico monostrofico, erano usati principalmente come canti di corteggiamento (o di scherno). Diffusi praticamente in tutta Italia, essi hanno però un'origine prevalentemente centro-meridionale. Per converso, di origine settentrionale è la ballata o canzone epico-lirica, destinata di massima all'esecuzione corale.
Folclore: musei e raccolte di interesse foclorico ed etnografico
L'immenso patrimonio folclorico del nostro Paese è ampiamente documentato nelle sale del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma, fondato da P. Toschi nel 1956 recuperando e integrando le collezioni della Mostra di etnografia italiana allestita nella capitale da L. Loria nel 1911, ma musei etnografici di grande interesse, perché dedicati ad aree piuttosto estese, sono sorti in quasi tutte le regioni, accanto a moltissimi altri, riguardanti singoli centri o zone più ristrette. Fra i primi, vanno menzionati almeno il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige (provincia di Trento), il Museo carnico delle arti e tradizioni popolari di Tolmezzo (provincia di Udine), il Museo della civiltà contadina dell'Emilia di San Marino di Bentivoglio (provincia di Bologna), il Museo etnografico Raffaele Corso di Palmi (provincia di Reggio di Calabria), il Museo etnografico Giuseppe Pitré di Palermo, il Museo etnografico di Nuoro. Fra i secondi, come prima, parzialissima selezione, ricordiamo il Museo etnografico tiranese di Madonna di Tirano (provincia di Sondrio), l'ampia sezione etnografica del Museo civico polironiano di San Benedetto Po (provincia di Mantova), la Casa museo di Ettore Guatelli a Ozzano Taro (provincia di Parma), il Museo etnografico Don Luigi Pellegrini di San Pellegrino in Alpe (provincia di Lucca), il Museo della civiltà contadina della Valle dell'Aniene di Roviano (provincia di Roma), la Casa museo fondata a Palazzolo Acreide (provincia di Siracusa) dall'antropologo A. Uccello.
Gastronomia
Nel dopoguerra, con il progressivo trasformarsi dell'Italia da Paese eminentemente agricolo in Paese industriale sono mutati consequenzialmente gli stili di vita, e quindi anche l'alimentazione della popolazione; molti cibi legati alla tradizione contadina sono andati così scomparendo per essere sostituiti da cibi e modelli alimentari propri dei Paesi più sviluppati e ricchi, non ultimo quello del fast food. Alla fine degli anni Ottanta, però, due avvenimenti hanno segnato la lenta ma graduale rinascita della gastronomia italiana: contro l'appiattimento da fast food, infatti, nascevano, nel corso del 1987, sia il Gambero Rosso, come inserto del quotidiano Il Manifesto dedicato all'enogastronomia, sia lo Slow Food, un movimento, divenuto presto internazionale, che si prefigge la divulgazione, lo studio e la conoscenza della cultura materiale, la salvaguardia del patrimonio agroalimentare dal degrado ambientale, la protezione del consumatore e della buona produzione, la ricerca e la promozione del piacere enogastronomico e della convivialità. Tra le varie iniziative promosse dal presidente e fondatore del movimento, C. Petrini, ha acquistato particolare rilevanza il Salone del gusto, realizzato, a partire dal 1996, nel complesso espositivo del Lingotto a Torino, in cui il territorio, con tutte le sue tipicità anche enologiche, diventa il vero protagonista della tavola. L'Italia, infatti, a differenza della Francia, non ha mai espresso una cucina a carattere nazionale, ma ha sempre privilegiato la connotazione identitaria del cibo, anche a livello delle minoranze gastronomiche del Paese, come i ladini, i sudtirolesi, gli sloveni del Friuli e gli albanesi della Calabria e del Molise. Ogni regione italiana è rappresentata, dunque, da una serie di prodotti naturali e di manufatti tipici, strettamente legati al territorio e alla tradizione locale (persino l'olio di oliva acquista caratteristiche molto diverse da regione a regione). In Piemonte, oltre al leggendario tartufo bianco, troviamo l'asparago di Santena, il peperone di Carmagnola e il cardo gobbo di Nizza Monferrato, cui si aggiungono formaggi di grande qualità, come la raschera, il bettelmatt e il castelmagno. Anche la Lombardia si distingue per i prodotti caseari: gorgonzola, quartirolo, taleggio, bitto, bagoss, grana padano. Ma non dimentichiamo il salame mantovano, il violino di capra di Chiavenna e la raffinata mostarda di Cremona. L'Emilia vanta invece il primato della lavorazione del maiale: bondiola e cappello da prete, culatello di Zibello, mortadella di Bologna, zampone di Modena e prosciutto di Parma. In Campania ritroviamo due formaggi tipicamente artigianali, la mozzarella di bufala e il caciocavallo podolico, ma la gloria della regione è l'autentico San Marzano, un pomodoro così delicato da poter essere pelato soltanto a mano. Il Lazio, che annovera tutti i prodotti della tradizione contadina, dal pane di Lariano alla mortadella di Amatrice, dalla ricotta di pecora all'olio extravergine sabino, si caratterizza soprattutto per una varietà di carciofi, le classiche “mamme romane”, considerati tra i migliori del mondo. Alla Toscana, probabilmente, va il primato della carne, con il maiale di cinta senese e con la razza chianina, tra le più pregiate del nostro Paese. Altri prodotti tipici sono il lardo di Colonnata, stagionato in vasche di marmo sulle Alpi Apuane, il fagiolo zolfino, coltivato in provincia di Arezzo, e il marzolino del Chianti, una rara caciotta di latte di pecora. L'elenco dei prodotti tipici del nostro territorio è inesauribile. Basterebbe citare la bottarga di muggine, il pistacchio di Bronte, i capperi di Pantelleria, la burrata pugliese, l'asparago violetto della Liguria, lo zafferano abruzzese, la cipolla rossa di Tropea, il bergamotto calabrese, i fagioli di Lamón, la lenticchia di Castelluccio, senza parlare del nostro patrimonio caseario, che conta centinaia di formaggi diversi. Tutti questi prodotti, naturalmente, costituiscono la base della cucina italiana, ricchissima di preparazioni e di specialità, che, spesso, non oltrepassano i confini della regione, o addirittura del borgo, tante e tali sono le varianti che ciascuna preparazione subisce passando da una località all'altra. Tuttavia non si può fare a meno di ricordare almeno le più celebri di queste preparazioni. Il Piemonte rievoca inevitabilmente i tajarin o la fonduta al tartufo bianco, il fritto misto all'italiana, il classico brasato al barolo e la familiare bagna cauda, in cui si intingono le verdure crude della zona, cardi, peperoni, carote, topinambur e foglie di verza. I primi piatti sono deciso appannaggio dell'Emilia-Romagna, che si divide tra tortelli di zucca, anolini alla parmigiana, lasagne verdi al forno, cappelletti di magro e passatelli alla romagnola, tortellini alla bolognese, pisarei e fasò alla piacentina. Il risotto, ovviamente, dobbiamo cercarlo in Lombardia, ma a Milano troveremo anche i piccoli capolavori della rusticità, come le polpette di carne e salsiccia (i popolari mondeghili) e l'intramontabile cassoeula, dove il maiale offre il meglio di se stesso, dalle puntine alla cotenne, dall'orecchio al piedino. Della Liguria, si sa, restano in mente, oltre alla farinata di ceci, il pesto alla genovese, la salsa inimitabile, a base di basilico locale, con cui condire trofie o trenette. Da segnalare anche lo stoccafisso in salsa verde, la tradizionale cima e la torta pasqualina, ripiena di bietole, maggiorana e ricotta. La Toscana si celebra di preferenza nelle minestre: l'acquacotta ai funghi porcini, la pappa con il pomodoro, la ribollita al cavolo nero, ma anche le pappardelle al sugo di lepre e il trionfale cacciucco alla livornese. Quando si parla del Lazio, la nostra attenzione è catturata dai bucatini all'amatriciana, dagli spaghetti alla carbonara, dalle costolette d'abbacchio, dalla coda alla vaccinara, per finire con gli immancabili carciofi alla giudia. In Campania, tralasciando la somma “invenzione” della pizza e degli spaghetti, si può passare dal semplice polpo alla Luciana al coniglio all'ischitana, per giungere al complesso, ma immortale, sartù di riso. La Sicilia, invece, punta preferibilmente su due prodotti naturali: il pesce spada, utilizzato soprattutto nei classici involtini, e la melanzana, regina incontrastata degli spaghetti alla Norma e della sontuosa caponata. Immancabile a questo punto un accenno alla pasticceria, molto diffusa in Italia, con specialità locali che hanno ormai raggiunto un mercato anche internazionale, come il panettone di Milano, i torroni di Cremona, gli amaretti di Saronno, i gianduiotti di Torino, il pandoro di Verona, il panforte e i ricciarelli di Siena, i canditi siciliani ecc. Ogni regione, inoltre, ha le proprie peculiarità: così, solo per fare alcuni esempi, se il Piemonte si caratterizza per l'estrema varietà (ogni città ha, in pratica, una specialità tutta sua), la Toscana dimostra una particolare predilezione per le paste asciutte, in genere a base di farina di castagne (castagnaccio, necci ecc.), e per i fritti (bomboloni, migliaccio ecc.); ricchissima di proposte la Campania, con molti dolci a base di ricotta fresca – dalle sfogliatelle (nelle due versioni riccia e frolla) alla pastiera –, senza però trascurare babà, taralli, zeppole; parlare di Sicilia è parlare di pasta di mandorle, materia prima di molti suoi dolci, dalla frutta alla martorana (splendide e coloratissime imitazioni di frutta di ogni tipo) ai dolci di Riposto, ai quali si affiancano la cassata, i cannoli; base di molti dolci della Sardegna sono invece miele, mosto cotto, mandorle e formaggio, dai vari tipi di torrone (particolarmente prelibati quelli di Nuoro e della Gallura) alle zippulas (frittelle di carnevale), alle pardulas (tortini pasquali). Tutte le appetitose preparazioni sin qui elencate richiedono, come si sa, la compagnia di un buon vino. Non essendo possibile, in questa sede, fare il censimento enologico del nostro ricchissimo territorio, che peraltro trova una splendida vetrina in Vinitaly, la manifestazione che annualmente si tiene a Verona dedicata al vino, accenneremo soltanto a una particolare tendenza, affiorata negli ultimi anni del Novecento nel mercato, ma anche nelle sofisticate ricerche di settore. Si tratta della moda, tutt'altro che sprovvista di ragioni, relativa all'impiego dei vitigni autoctoni, di cui l'Italia vanta una straordinaria gamma di varietà, e che costituiscono l'unica risposta alla globalizzazione dell'enologia. Sono vitigni nati nella nostra penisola o che vi si trovano da secoli, e che rappresentano un enorme serbatoio di tradizioni e di esperienze. Ecco, in conclusione, i 24 vitigni autoctoni più diffusi: grignolino (Piemonte), barbera e nebbiolo (Piemonte e Lombardia), pigato (Liguria), prosecco (Treviso), teroldego (Trentino), ribolla, picolit e tocai (Friuli-Venezia Giulia), albana e lambrusco di Sorbara (Emilia-Romagna), montepulciano (Toscana, Lazio, Abruzzo), sagrantino (Umbria), verdicchio (Marche), aglianico (Campania e Basilicata), primitivo (Puglia), nero d'Avola (Sicilia), cannonau (Sardegna). A questi si aggiungono dei vitigni coltivati in tutta Italia: dolcetto, malvasia, moscato bianco, sangiovese, trebbiano e vernaccia.
Bibliografia
Per la filosofia
E. Garin, Cronache della filosofia italiana, Bari, 1955; M. F. Sciacca, Il pensiero italiano dell'età del Risorgimento, Milano, 1963; J. Hoellhuber, Geschichte der italienischen Philosophie, Monaco, 1969; S. A. Efirov, La filosofia italiana borghese del sec. XX, Firenze, 1970; N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano, Torino, 1986.
Per le lingue e i dialetti
M. Cortelazzo, Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, vol. I: Problemi e metodi, Pisa, 1969, vol. III: Lineamenti di italiano popolare, Pisa, 1972; G. Devoto, G. Giacomelli, I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze, 1972; G. Rohlfs, Studi e ricerche su lingua e dialetti d'Italia, Firenze, 1990.
Per la letteratura
A. Momigliano, Storia della letteratura italiana, Milano, 1935; A. Pompeati, Storia della letteratura italiana, Torino, 1944; B. Croce, La letteratura della nuova Italia, Bari, 1950; F. Flora, Storia della letteratura italiana, Milano, 1952; L. Russo, Storia della letteratura italiana, Firenze, 1957; G. Petronio, L'attività letteraria in Italia, Palermo, 1967; M. Sansone, Storia della letteratura italiana, Milano, 1967; C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, 1967; W. Binni, N. Sapegno, Storia letteraria delle regioni d'Italia, Firenze, 1968; E. Cecchi, N. Sapegno, Storia della letteratura italiana, 9 voll., Milano, 1969; C. Salinari, C. Ricci, Storia della letteratura italiana, Bari, 1969-70; A. Asor Rosa, Sintesi di storia della letteratura italiana, Firenze, 1972; G. Getto, Storia della letteratura italiana, Milano, 1972; R. Luperini, Letteratura e ideologia nel primo Novecento italiano, Pisa, 1974; S. Ramat, Storia della poesia italiana del Novecento, Milano, 1976; F. Fortini, I poeti del Novecento, Bari, 1977; G. Farinelli, Il romanzo fra le due guerre, Milano, 1979.
Storie e antologie della critica: M. Fubini, E. Bonora, Antologia della critica letteraria, 3 voll., Torino, 1952-54; L. Russo, La critica letteraria contemporanea, Bari, 1953; L. Russo, Antologia della critica letteraria, Messina-Firenze, 1958; W. Binni, R. Scrivano, Antologia della critica letteraria, Milano-Messina, 1960; G. Getto, S. Jacomuzzi, Poeti e prosatori italiani nella critica, Bologna, 1960; V. Branca, C. Galimberti, Civiltà letteraria d'Italia, Firenze, 1962-64; G. Petronio, Antologia della critica letteraria, Bari, 1962-64; N. Sapegno, Antologia della critica letteraria, Roma, 1964; G. Bàrberi Squarotti, A. Jacomuzzi, Letteratura e critica, Messina-Firenze, 1967; C. Segre, I segni e la critica, Torino, 1969; U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, 1975; W. Binni, I classici italiani nella storia della critica, Firenze, 1977.
Per l'archeologia
M. E. Blake, Ancient Roman Construction in Italy from the Prehistoric Period to Augustus, Washington, 1947; G. Richter, Ancient Italy, Londra, 1955; S. M. Puglisi, La civiltà appenninica e l'origine delle comunità pastorali in Italia, Firenze, 1958; A. Maiuri, Arte e civiltà dell'Italia antica, Milano, 1960; S. Moscati, Italia sconosciuta, Milano, 1972; idem, Italia ricomparsa, 3 voll., Milano, 1983-85; A. Portrandolfo, Guida archeologica d'Italia, Milano, 1991.
Per l'arte
P. Toesca, Il Trecento, Torino, 1951; E. Lavagnino, L'arte moderna dai neoclassici ai contemporanei, 2 voll., Torino, 1956; B. Berenson, I pittori italiani del Rinascimento, Firenze, 1957; C. Maltese, Storia dell'arte in Italia 1785-1943, Torino, 1960; F. Bologna, La pittura delle origini, Roma, 1962; G. C. Argan, Storia dell'arte italiana, 3 voll., Firenze, 1968 (nuova ed., 5 voll., 1988); idem, L'arte moderna 1770-1970, Firenze, 1970; R. Wittkower, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino, 1972; L. H. Heydenreich, W. Lotz, Architecture in Italy 1400-1600, Londra, 1974; G. C. Argan, B. Contardi, Storia dell'arte classica italiana, Firenze, 1987.
Per la musica
G. Roncaglia, Il melodioso Settecento italiano, Milano, 1935; F. Toye, Italian Opera, Londra, 1952; W. Newman, The Sonata in the Baroque Era, Chapel Hill, 1959; idem, The Sonata in the Classical Era, Chapel Hill, 1963; M. Bortolotto, Fase seconda, Torino, 1969; F. Testi, La musica italiana nel Medioevo e nel Rinascimento, Milano, 1969; S. Martinotti, Ottocento strumentale italiano, Bologna, 1972; M. Robinson, Naples and Neapolitan Opera, Oxford, 1972; G. Stefani, Musica barocca: poetica e ideologia, Milano, 1974; G. Pestelli (a cura di), Il melodramma italiano dell'Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, Torino, 1977.
Per la danza
H. Dolmetsch, Dances of Spain and Italy from 1400 to 1600, Londra, 1954; G. Tani, Cinquant'anni di Opera e Balletto in Italia, Roma, 1954; F. Reyna, Des origines du ballet, Parigi, 1955; L. Rossi, Storia del balletto, Milano, 1961; idem, Il ballo alla Scala 1778-1970, Milano, 1971.
Per lo spettacolo
L. Tonelli, Il teatro italiano, Milano, 1924; Autori Vari, Storia del teatro italiano, Milano, 1936; M. Apollonio, Storia del teatro italiano, Firenze, 1939; V. Mariani, Storia della scenografia italiana, Firenze, 1940; P. Toschi, Le origini del teatro italiano, Torino, 1955; M. Fasso (a cura di), Il teatro del Seicento, Milano-Napoli, 1956; V. Pandolfi, Teatro italiano contemporaneo, Milano, 1959; M. Apollonio, Storia del teatro italiano, Firenze, 1981; N. Borsellino, R. Mercuri, Il teatro del Cinquecento, Bari, 1986; F. Angelini, Teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari, 1990; A. Barsotti, Futurismo e avanguardie nel teatro italiano tra le due guerre, Roma, 1990.
Per il cinema
Autori Vari, Il neorealismo italiano, Venezia, 1951; V. Jarrat, The Italian cinema, Londra, 1951; M. A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, I, Milano, 1951; C. Lizzani, Il cinema italiano, Firenze, 1952; M. Gromo, Cinema italiano (1903-1933), Milano, 1954; G. C. Castello, Il cinema neorealistico italiano, Torino, 1956; B. Rondi, Il neorealismo italiano, Modena, 1956; G. Ferrara, Il nuovo cinema italiano, Firenze, 1957; P. G. Hovald, Le néo-réalisme italien et ses créatures, Parigi, 1959; G. Aristarco, Miti e realtà nel cinema italiano, Milano, 1961; G. Gerosa, Da Giarabub a Salò - Il cinema italiano durante la guerra, Milano, 1963; Autori Vari, 20 anni di cinema italiano (1945-1965), Roma, 1965; G. Fofi, Il cinema italiano: servi e padroni, Milano, 1971; M. Quargnolo, Dove va il cinema italiano, Milano, 1972; B. Torri, Cinema italiano: dalla realtà alle metafore, Palermo, 1973; R. Chiti, R. Poppi, Dizionario del cinema italiano, Roma, 1991.
Per il folclore
R. e R. Leydi, Marionette e burattini, Milano, 1958; E. De Martino, Sud e magia, Milano, 1959; P. Toschi, Arte popolare italiana, Roma, 1959; G. Cocchiara, Le origini della poesia popolare, Torino,1966; P. Toschi, Il folclore, Milano, 1967; A. Rossi, Le feste dei poveri, Bari, 1969; R. Leydi, Canti popolari italiani, Milano, 1973.


